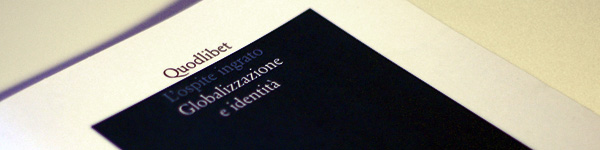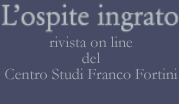home>interventi/interviste> Volponi, il paradosso apocalittico
Volponi, il paradosso apocalittico*
Gabriele Fichera
Il rapporto tra Volponi e il concetto di apocalisse è molto complesso. Vorrei
cominciare ad inquadrarlo adoperando una serie di affermazioni la cui forma,
apparentemente assiomatica, è volutamente smentita da un contenuto di tipo
paradossale.
Il primo pseudo-assioma è così formulato: Volponi è sì, scrittore di apocalissi,
ma non è uno scrittore apocalittico. Non è cioè banalmente pessimista, e
non fa recriminazioni né piagnistei, non è mentalmente manicheo, non è
passatista, e non è neanche ottusamente progressista. Volponi era uno scrittore,
se così si può dire, naturalmente dialettico, ed istintivamente complesso.
L’apocalisse, in un certo senso, per Volponi non esiste.
E non esiste per un primo semplicissimo, ancorché paradossale, motivo: perché in
realtà essa è già avvenuta. E poiché è già avvenuta si tratta in sostanza di
farne, pascalianamente, un buon uso. Può sussistere dunque per Volponi,
cominciamo a tenerlo a mente, un versante positivo dell’apocalisse.
Ma ancora l’apocalisse per Volponi non esiste in un altro senso: essa infatti
non è veramente “apocalittica”. Cioè: non è una vera fine, ma piuttosto una
trasformazione, benché profonda. E soprattutto, qualora fosse una fine, essa non
sarebbe ineluttabile, non sarebbe inevitabile. Forse è diventata inevitabile
dopo, ma c’è stato un tempo precedente in cui non lo era. Per Volponi in realtà
un’alternativa allo sfacelo si dà sempre; ma esperirla fino in fondo è doloroso,
comporta sacrificio, e anche un certo “eroismo”. Quello ad esempio, tanto caro
allo scrittore da assumerlo come nomen omen, della volpe che, caduta in
trappola, si taglia la zampa pur di scappare e mettersi in salvo. A proposito di
questo tipo di eroismo, più tardi, parlerò di un raccontino volponiano
intitolato Talete.
L’ultimo punto di questa serie di pseudo-assiomi dice che l’apocalisse per
Volponi, qualora esistesse, non sarebbe raccontabile. Su questa ultima
affermazione tornerò alla fine dell’intervento.
Provo ad analizzare queste frasi e ad approfondirle. Parto dal secondo punto, da
porre intanto ad un livello generale di tipo filosofico. In Volponi
l’apocalisse non è apocalittica, cioè non è una vera fine. Volponi possedeva
una struttura di pensiero profondamente materialista. Per lui l’universo era
pura trasformazione di materia. Quello della fine del tempo, o più
correttamente, dei Tempi, era un concetto ancora viziato dal solito
antropocentrismo. La materia invece si dissolve e si ricompone continuamente;
composita solvantur, direbbe Fortini. Più che traumi improvvisi ed evidenti,
ciò che si verifica è una lunga e lenta serie di trapassi, cambiamenti di stato,
attraversamenti di soglie che concrescono l’una sull’altra, addensamenti di
materia, e poi rarefazioni, collassi, scissioni. Per Volponi il mutamento è un
passaggio di soglia, un salire e/o scendere continuo di livello; e veramente
come in Benjamin la soglia non è un semplice confine puntuale, ma una zona. Cito
dai Passages di Benjamin: «La schwelle (soglia) è una zona. La
parola schwellen (gonfiarsi) racchiude i significati di mutamento,
passaggio, straripamento» [BENJAMIN 2002, 555]. La realtà si trasforma dunque, e
non è affatto detto che la fine di un mondo non possa preludere ad un nuovo e
migliore ordine delle cose. Ad esempio la rappresentazione del problema della
mutazione antropologica in Volponi, a differenza che in Pasolini, che invece era
un vero apocalittico, è sfumata; la mutazione può essere anche positiva. Dopo
vedremo meglio a quali condizioni si dà questo valore positivo della catastrofe.
Intanto va detto che in Volponi il movimento apocalittico assume una forma
simbolica precisa: quella della dilatazione. Sussistono però due diverse qualità
di tale dilatazione, ci sono cioè due diversi modi in cui la trasformazione
apocalittica riesce ad attraversare, liquidamente, certe soglie, e quindi a
straripare, a dilagare e ad allargare i suoi confini. La prima dilatazione è
negativa; essa è estensiva e strumentale, fagocitante e aggressiva, alienante e
impositiva, si rivolge verso l’esterno per dominarlo; l’altra è invece positiva,
è volta all’interno dell’uomo, è intensiva e liberante, è analitica e produce
salvifiche metamorfosi. La prima, per intenderci meglio, è quella della bomba
atomica, con la sua stupida logica da «reazione a catena», col suo automatismo
omicida e non intelligente. A questa dilatazione apocalittica Aspri, lo
strampalato protagonista del romanzo Corporale, contrappone,
ambiguamente, una progressiva e programmata trasformazione di sé e dell’ambiente
che lo circonda – e qui abbiamo il metodico delirio del progetto di un rifugio
anti-atomico che sia una sorta di novella arca di Noè. Dice Aspri: «Io sono
pronto a mutare: voi no. E così vi fregherà la bomba che avete
prefabbricato: la quale esplodendo metterà in atto regole e reazioni diverse da
quelle della vostra bella continuità» [VOLPONI 2002, 655]. Ma qual è questa
logica della bomba? Ascoltiamo ancora Aspri: «La logica della bomba è la
reazione a catena [...] quando esplode prende tutto e ogni cosa diventa
bomba: anche la tua testa, anche la tua pancia, che ti è stata tolta, è
diventata una bomba» [VOLPONI 2002, 934]. Dunque la bomba è già esplosa,
già solo per il fatto di essere stata costruita. Aspri dimostra dunque di
comprendere a fondo l’estrema pervasività della logica distruttiva bombesca. Una
logica che penetra nei corpi e nelle menti degli uomini prima ancora che la
bomba materialmente esploda. «La bomba H esploderà per il semplice principio che
è stata costruita» [VOLPONI 2002, 478]. Si può affermare dunque che la sua
deflagrante devastazione morale e psicologica quasi prescinde dalla nocività
fisica. Una società che produce questo strumento di morte e distruzione è dunque
una società in cui qualcosa di apocalittico è già avvenuto. La bomba non
è solo il prodotto di una civiltà degradata, ma ne è essa stessa produttrice.
Parafrasando il Volponi di Natura e animale, un saggio di cui tra poco
parlerò meglio, potremmo dire che noi siamo fatti a misura della bomba
non meno di quanto siamo fatti a misura dell’arancia. Per Volponi infatti,
vichianamente, «noi siamo quello che possiamo fare» [VOLPONI 1994, 105].
Il prodotto principale dell’ordigno nucleare, che dilaga nel tessuto sociale e
lo lacera, è la paura. Terrorizzare gli uomini per ridurli in stato di servitù è
il reale compito per cui la bomba è stata creata. Dirà Aspri: «Ti aiuterò a non
avere paura [...] questo sarebbe il vero compito dell’insegnante» [VOLPONI 2002,
589].
Cosa è successo dunque a questo mondo che è già preda di un’apocalisse, è che è
già sconvolto da una mutazione profonda?
È successa una cosa molto semplice: che il modo di produzione capitalista basato
sull’accumulazione di enormi profitti in pochissime mani, e su uno sfruttamento
del lavoro umano e delle risorse naturali sempre più massiccio e indiscriminato,
ha trionfato, ha vinto la sua battaglia e finalmente si è imposto come unico e
totalizzante modello economico e culturale.
Esiste in Volponi dunque un’apocalisse storicamente determinata, quella
capitalista, cioè prodotta dal capitalismo. Tutto il mondo è stato ormai
messo a valore, è stato ingabbiato nelle ferree leggi dei processi di
valorizzazione. Tutto viene fatto e concepito al fine esclusivo della produzione
di profitto.
Questo tema dell’apocalisse capitalista è centrale, oltre che nei romanzi
maggiori come Corporale e le Mosche del capitale, in tantissimi
altri scritti volponiani; e ad esempio in un saggio di straordinaria intensità
come Natura e animale del 1982. Il tema centrale di questo lavoro, in cui
saggismo e narrazione, ragionamento e accensione fantastica si intersecano in
modo perfetto, è la gravissima perdita dei nessi che intercorrono tra uomo,
natura e animale. Leggo alcuni passi da questo scritto, partendo dalle prime
pagine: «La natura e l’animale sono in realtà molto lontani dal nostro mondo,
spezzati, e in parte dimenticati, indagati, usati, condizionati,
strumentalizzati, allevati, tirati fuori dalla loro realtà, dalla
loro condizione originaria, unitaria» [VOLPONI 1994, 103, corsivi miei]. E poco
dopo: «La natura appare ormai come la tastiera di una simulazione, i suoi
elementi, le sue stagioni ridotti essenzialmente ad essere i tasti, i
commutatori, gli imputs di questo piano di simulazione» [VOLPONI 1994,
104]. E tutto ciò cosa comporta? «Tutto è ridotto a strumento, mezzo,
risorsa, energia, o punto d’appoggio per un vorticoso percorso che va sempre più
verso il fuori, un fuori» [VOLPONI 1994, 104, corsivi miei]. Qui sono da
sottolineare almeno due elementi principali: il concetto di asservimento della
natura ai meccanismi alienati e alienanti della ragione strumentale, che
costringe ogni elemento di vita libera dentro i recinti della valorizzazione
capitalista; e poi l’accenno alla direzione verso cui tende questa operazione,
il «fuori», anzi un imprecisato fuori, cioè un mondo di cui non possiamo
conoscere in anticipo e con esattezza i contorni, ma del quale, viste le
premesse, immaginiamo alcune connotazioni, tra l’inumanità più feroce e la
sostanziale mancanza di libertà. È poi da notare che si ha proprio in questa
idea del «fuori» un esempio lampante di quella dilatazione verso l’esterno,
aggressiva e inglobante, che avevamo poco fa individuato come una fra le
principali forme dell’apocalisse in Volponi. A cosa tende questo movimento
estensivo della logica del valore e del profitto? Di nuovo alla «fioritura»
della bomba atomica. E dice proprio «fioritura» Volponi, riprendendo così uno
spunto a lui molto caro che era stato della Morante: «La natura artificiale
[...] benissimo organizzata ... ben colorata, tesa, però alla fine tutta
mossa verso, sì, una nuova grande fioritura che mi pare essere quella
appunto, dell’immenso superiore, velenoso fungo che si sprigiona
dall’esplosione delle bombe atomiche e nucleari» [VOLPONI 1994, 107, corsivi
miei].
In Volponi, come si è detto all’inizio, l’apocalisse, anche se già avvenuta, non
è propriamente apocalittica, nel senso che c’è sempre per l’uomo un’alternativa
da custodire e da esperire; c’è sempre qualcosa o qualcuno che, nonostante
tutto, testardamente resiste.
Sempre in Natura e animale: «La perdita è grave» dice Volponi, ma poi
improvvisamente aggiunge: «La natura poetica persiste» [VOLPONI 1994, 104]. La
natura e l’animale che appartengono al «fuori» sono appunto irrimediabilmente
perduti, ma rinascono dentro l’uomo, nella sua interiorità, nella sua
corporalità. Essi sono: «assunti, introitati, spinti giù, sedimentati, assorbiti
dalle interiora, dalla mucosa dell’anima dell’uomo» [VOLPONI 1994, 109]. L’uomo
dispone dentro di sé di un animale «introiettato», «con tutti i suoi
istinti, la sua voracità, il lampeggiare dei suoi occhi, il fremere del suo
muso, l’umore delle sue glandole, il morbido delle sue pelli: la saliva, il
gusto, l’odore, il calore, le piume, i singulti, gli assalti, gli amori, le
stagioni, gli agguati» [VOLPONI 1994, 109]. Mi sono dilungato nella citazione
del brano per far apprezzare un elemento cruciale dello stile di Volponi: l’uso
reiterato della enumerazione più o meno caotica. Qui, ad esempio, si mescolano
in modo secondo me non casuale parole dal senso concreto e dal senso più
astratto, ma tutte collegabili tra di loro, in virtù di un comune campo
semantico. Bisogna fare attenzione a questi movimenti della scrittura, perché
Volponi usa proprio queste armi da poeta, cioè le enumerazioni e anche le
metafore, per cercare il suo animale «introiettato», e insieme al suo quello di
noi tutti. C’è un nesso forte dunque fra associazione poetica, natura e animale.
«L’animale esiste in tante associazioni e immagini» [VOLPONI 1994, 104]. E per
farsi meglio comprendere usa di nuovo la figura poetica dell’accumulazione:
«l’associazione lo vede come sangue, scatto, bocca aperta, anelante, pelliccia,
calore, piuma, volo, vento, cattura, manovra, entratura, dentro, spinta, sesso,
e anche dolce corpo conquistabile, assumibile» [VOLPONI 1994, 104]. Come si vede
qui l’enumerazione non è semplicemente un accumulo di parole, ma piuttosto un
piccolo racconto scorciato, una narrazione latente, pronta a solidificarsi in
un’immagine, in uno scatto fantastico. La natura e i poeti dunque, formano un
binomio indissolubile. I poeti che infatti sono: «coloro che per loro natura e
anche motivazione e proposito, guardano all’interno di sé e più degli altri,
possono ancora essere detti “custodi degli animali” e un poco animali essi
stessi» [VOLPONI 1994, 111, corsivo mio] – ed è interessante ricordare come in
modo simile la pensasse anche un altro poeta e filosofo del romanticismo tedesco
del calibro di Schiller, per il quale i poeti sono «ovunque, e per definizione,
conservatori della natura». Quindi concludendo si può affermare che la natura
rinasce all’interno dell’uomo, facendosi spazio nella sua interiorità, e così lo
trasforma, dando vita ad un’apocalisse positiva; essa costituisce il:
«patrimonio nuovo dell’essere umano» [VOLPONI 1994, 110]. Adesso bisogna solo:
«riconoscere la natura e anche gli animali come vita e vitalità propria e
non soltanto come paesaggio o brano di bellezza stereotipate e consumate»
[VOLPONI 1994, 112, corsivo mio]. Per compiere questo riconoscimento Volponi
lavora molto sulla lingua italiana.
C’è dunque un cruciale equivalente formale di questa ansiosa ricerca
dell’animale «introiettato» e della sua libertà insopprimibile. Si devono notare
a questo proposito due elementi preponderanti della scrittura volponiana; essi
sono differenti, ma allo stesso tempo appaiono come invischiati l’uno
nell’altro, dunque solidali: c’è un potente scatto immaginativo, un continuo
scarto metaforico nella rappresentazione della realtà; e poi, accanto,
l’accumulazione ansiosa dell’enumerazione caotica. A proposito di questo ultimo
aggettivo va notato che Elsa Morante aveva sottolineato come la rappresentazione
del Caos fosse la cifra principale del romanzo Corporale. E aveva
ipotizzato che, come in un antico racconto mitologico, anche nella scrittura di
Volponi ci fossero come dei buchi che facevano guarire quel Caos. Si può forse
apporre una chiosa a questo spunto, dicendo che l’enumerazione e la metafora
sono i buchi poetici che guariscono la scrittura volponiana, mettendola
in collegamento col mondo affine della natura e dell’animale. Le fessure formali
che Volponi incide sulla carne della sua prosa; i fori salvifici che rendono la
sua scrittura incandescente e porosa al tempo stesso, nascono dalla
coordinazione di enumerazione e metafora. Si può dunque considerare
l’enumerazione uno strumento stilistico e conoscitivo di tipo “apocalittico”,
che Volponi adopera quasi per mettere alla prova la tenuta della nostra lingua,
saggiandone la consistenza sintattica e la coerenza semantica. Come se Volponi
provocasse a bella posta, dentro il periodo, dei piccoli smottamenti
linguistici; magari per abituarci all’idea di un successivo e più tumultuoso
crollo. L’enumerazione sembra essere quella forza che insieme scatena ed
organizza forze linguistiche distruttive, scagliandole contro la sintassi della
norma, e che poco dopo raccoglie i detriti provocati dalla sua stessa
esplosione, mettendosi con pazienza a rovistare fra i calcinacci delle parole,
per poi allinearli sui nastri della frase. La metafora volponiana invece
squarcia nell’illuminazione di un attimo la materia accumulata. Se
l’enumerazione è la pala che scava un labirinto di cunicoli verbali, la metafora
è il foro che all’improvviso illumina tale labirinto. Tutt’e due, enumerazione e
metafora, collaborano ad una poetica messa in dubbio dell’esistente come blocco
di senso compatto, granitico, e inscalfibile.
All’apocalisse dunque si può e si deve resistere, a maggior ragione quando tutto
sembra perduto. Volponi è uno scrittore dialettico; e ha sempre un’ultima carta
da giocare; nutre fino alla fine un’indocile speranza. E però: si può e si deve
resistere, ma non si può pensare di non pagare dazio per questa resistenza; la
barbarie lascia comunque dei segni indelebili, e non tutte le ferite si possono
occultare. Come si diceva all’inizio: le vere apocalissi non sono raccontabili.
Vorrei portare come testimonianza di tutto ciò un raccontino volponiano del 1987
intitolato Talete. Il protagonista è l’antico filosofo-scienziato greco,
l’uomo saggio amato dal popolo per aver, in un certo senso, inventato le
previsioni meteorologiche, e così salvato i raccolti dei contadini del suo
villaggio.
Questo Talete però si trova a vivere adesso in una fase storica infausta.
Volponi descrive ciò che gli accade intorno; e sono scene da fine del mondo.
Eserciti che si scontrano in guerre sanguinosissime, dando vita a conflitti
efferati. Gente che muore di fame agli angoli delle strade. E poi: una nuova
disgustosa barbarie si impadronisce dei cuori degli uomini, trasformandoli in
belve che senza ritegno si scannano a vicenda. Gli uomini cadono nell’abiezione
del cannibalismo. Un cannibalismo ben lontano da quello ritualizzato da alcuni
popoli, perché feroce e crudele; esso infatti rivolge la sua violenza verso le
proprie vittime addirittura mentre esse sono ancora in vita. C’è un passo del
racconto in cui si dice: «Tutti avevano perduto anche la più piccola remora
contro il cannibalismo. Mangiavano il compagno caduto al loro fianco, ancora
nell’atto di invocarli, con l’avidità e il gusto di capre fra bietole» [VOLPONI
1999, 193]. Ecco lo squarcio della metafora a cristallizzare, ed anche a
frenare, in un’immagine l’onda crescente del disgusto. Talete però è filosofo e
poeta. Nonostante tutto decide di resistere e dunque rifiuta il cannibalismo. Ma
come orchestra il suo rifiuto? Con calma e certosina dedizione il filosofo
comincia a staccare dal suo corpo prima un orecchio, poi l’altro, poi un
pezzetto di guancia, poi uno zigomo, e così via. Dunque si nutre di queste sue
parti. Le mangia. Un gesto estremo e paradossale con cui rifiuta di portare la
violenza sugli altri e cerca, simbolicamente, di ritrovare e conservare qualcosa
di intimo, la propria sostanza umana, potremmo dire il proprio «animale
introiettato». Ecco dunque che Talete risponde all’apocalisse “esterna” dei
barbari con una sorta di dilatazione rovesciata, che non aggredisce più il
“fuori”, ma si rivolge all’interno dell’uomo, e si tramuta in pensiero
corporale, in analisi, in pacata dissezione dell’io. Questo paradossale
allargamento e arricchimento dell’io, compiuto attraverso dei tagli – e vedo
ancora campeggiare sullo sfondo i salvifici fori della Morante – viene premiato,
ed infine si traduce in un mutamento qualitativo, in una metamorfosi. Talete
prima si trasforma in una perfetta figura geometrica, il quadrato, e poi
collassa su se stesso, sbriciolandosi in una lieve fiammata di luce. I suoi
tagli lo hanno salvato dal destino barbarico del cannibalismo. Questo modo di
resistere all’apocalisse non è però indolore. Talete è eroico come la già
menzionata volpe che si taglia la zampa pur di conservare la sua libertà, ma
sconta la sua scelta a favore della dignità umana con la morte. Si badi bene
però come sia proprio da questo gesto follemente ponderato che nasce qualcosa di
nuovo: una misurata speranza. Il racconto di Volponi infatti si conclude con una
figura ambigua, quella del superstite; è da notare ancora una volta l’intrinseca
dialetticità del movimento narrativo: dal terribile conflitto fra soldati
imbarbariti da una parte, e il civile Talete dall’altra, scaturisce un tertium,
una provvisoria sintesi: un superstite, che però porterà su di sé per sempre i
segni della catastrofe appena superata. Vediamo il fuggitivo allontanarsi a
cavallo dalla battaglia senza mai distogliere lo sguardo dalle scene di guerra;
egli porta con sé un carico di appunti. È evidentemente animato dalla ferma
volontà di essere un testimone. Poi, a guerra finita, si stabilisce in un
villaggio; è molto stimato e rispettato come abile cavaliere e come erudito. Ma,
e qui sta il problema, il superstite non racconta nulla, anzi «tralascia» la
narrazione. L’orrore estremo non si può narrare. Aveva detto poco prima Volponi:
«Le ultime battaglie e la fine non sono mai state descritte né mai raccontate»
[VOLPONI 1999, 194]. Ho spesso pensato che nel filosofo e scienziato Talete si
possa ravvisare un doppio metaforico dello stesso Volponi; forse in questo
strano superstite, privato della parola, si potrebbe scorgere in filigrana la
figura di un altro straordinario scrittore italiano che più volte a Volponi è
stato accostato: Primo Levi. Levi è stato un testimone impossibile. Sapeva bene
che il senso profondo del Lager non era raccontabile, perché chi lo ha davvero
compreso ed esperito fino in fondo non è più tornato alla vita civile. Le vere
apocalissi, come dicevo all’inizio, non sono narrabili.
Vorrei concludere questo intervento con una nota amaramente ironica. C’è
un’ultima apocalisse di Volponi di cui forse si dovrebbe parlare; ma per
intenderla quel genitivo «di Volponi» andrebbe per un attimo rovesciato e
considerato oggettivo, e non soggettivo; nel senso che lo scrittore Volponi è
anche vittima di un’apocalisse. C’è in atto una scomparsa di Volponi. A volte i
grandi libri sono stati bruciati; altre volte invece, senza scendere al livello
di questi gesti estremi e controproducenti, più semplicemente si è tentato di
renderli irriconoscibili agli occhi dei lettori. Di tutto questo Volponi fu
facile profeta. C’è ad esempio quell’intensa ma triste pagina delle Mosche,
in cui la valorizzazione della narrazione, la sua mercificazione, si traduce
nell’immagine davvero apocalittica del racconto come «bancone del supermercato».
L’incubo di Volponi era lo scaffale librario in cui i volumi di Mann e Proust
diventassero d’un tratto indistinguibili dalle bottigliette d’acqua o dalle
boccette dell’ultimo profumo su cui la pubblicità non smette di blaterare. Ma
forse Volponi era stato addirittura ottimista. Oggi ad esempio i suoi volumi in
libreria non si trovano proprio, o sempre più difficilmente; e quando, in
ossequio alla banale e consolatoria sequenzialità dell’ordine alfabetico, lo
cerchiamo fra gli scaffali sotto la lettera “V” che cosa troviamo? Un ripiano
stracolmo dell’ultimo pezzo di Fabio Volo; e poi... basta. Una cinquantina di
copie del libro di Fabio Volo; e nessuna invece del suo più sfortunato vicino di
consonante.
Anche questo può essere il segno di un’apocalisse che davvero non possiamo
tralasciare.
*Intervento presentato al Convegno Internazionale di studi, Urbino 24 novembre 2012. «Il ritorno del trauma. Le apocalissi di Volponi»
Opere citate:
- W. Benjamin, Das Passagenwerk, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1982 (trad.
it. I «passages» di Parigi, a cura di R.
Tiedemann, ed. it. a cura di E.
Ganni, 2 voll., Einaudi, Torino 2002).
- P. Volponi, Corporale, in Romanzi e prose I, a cura di E.
Zinato, Einaudi, Torino, 2002.
- P. Volponi, Natura e animale, in Scritti dal margine, Manni,
Lecce 1994.
- P. Volponi, Talete, in Del naturale e dell’artificiale, Il
lavoro editoriale, Ancona 1999.
[23 gennaio 2013]
home>interventi/interviste> Volponi, il paradosso apocalittico.