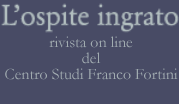home> scrittura/lettura> La funzione Fortini. Risposte al questionario II
Giovanni Nadiani
1.
Senza voler fare della mitologia generazionale, mi sento di poter dire
che la mia generazione – quella nata negli anni Cinquanta e
che ha cominciato a prendere coscienza di sé negli anni
Settanta – abbia avuto la “grazia” di una
ferita immedicabile, che la rende testimone necessario e
incomprensibile a un tempo (ai più giovani ma anche ai padri
riciclatisi giovanilmente in nipoti, tutto scordando o rimuovendo). La
lucida ferita privata dentro una storia più grande di cui,
in qualità di semplice e periferico esponente di tale
generazione, sento di dover raccontare, affinché si possa
intuire se non fendere e capire la nebbia di questa notte disgustosa e
inquietante, diventando piccolo traduttore/traghettatore di un
“luogo” alla volta del magma indistinto in cui ci
si vuole comodamente adagiati e dimentichi, è quella di
essere risultati oggetti della Grande Trasformazione che nel corso
degli anni Sessanta e Settanta (in questi ultimi con particolare
accelerazione e virulenza) ha posto le basi del vivere oggi in Italia
in particolare, ma non solo; Grande Trasformazione (dalla testa della
gente al paesaggio in cui essa si muove) tanto lucidamente analizzata
da Pier Paolo Pasolini nei suoi vari aspetti, non da ultimo in quello
linguistico.
Le parole di Eugenio Turri, cui si deve anche la definizione di
“Grande Trasformazione”, riferite in primo luogo al
paesaggio, sembrano adattarsi molto bene a qualsiasi aspetto del nostro
vivere (territoriale-architettonico, socio-politico,
linguistico-mediatico), risultando, a distanza di un quarto di secolo,
addirittura profetiche: “[…] il paesaggio confuso
d’oggi, dove l’individualità degli
interventi ha continuato a porsi anche in un contesto che imponeva
ordine, serialità, regola […]. Da noi
casualità di segno, resistenza o ogni serialità,
anarchia, disordine edilizio. Tutto ciò, si dice,
è dovuto alla mancanza di pianificazione e di leggi
sull’uso dei suoli, ma prima ancora è il risultato
di un inveterato e non facilmente correggibile modo di ricondurre la
rappresentazione paesistica al proprio schema mentale, ai propri
interessi particolari”.
E chi, come me, si è trovato a vivere direttamente sul
proprio corpo e sulla propria lingua, su tutto l’essere della
propria gente il passaggio di questo tornado, risulta essere
permeabilissimo al racconto di esso, perché il suo vento
spira ancora, anzi la sua dirompenza costituisce il labile, molle e
malleabile (secondo i propri interessi particolari) basamento del
nostro orrifico presente. Canto e racconto, dunque, non tanto (o non
solo) dell’immediato, immedicato ieri,
dell’immaginario coatto che ci ha portati all’oggi,
bensì assolutamente di questo oggi, le cui contraddizioni,
le cui “ingiustizie” grondano nella ferita di ieri.
Perché, in realtà, la ferita di ieri è
la ferita perenne inferta dal capitalismo, nella sua attuale variante
post-fordista e finanziaria votata alla massimizzazione dei profitti
nel minor tempo possibile spesso ammontato da schiavistiche ideologie
(come in Cina), a quasi ogni luogo della Terra, avente come testa di
ponte un immaginario pervasivo, senza i correttivi o le illusioni
dell’universalismo illuminista e democratico o cristiano o
persino della paternalistica soziale Marktwirtschaft del Vecchio Mondo,
accecante l’individuo smarrito, alienato e insicuro die ieri
e di oggi, “fagocitato e ‘parlato’ dalle
nuove tecnologie e dai nuovi linguaggi che recano l’illusione
di una libertà e di una ricchezza inaudite e alla portata di
tutti ma che spesso, nella realtà, per milioni di persone,
non sono altro che strumenti di sfruttamento ed espropriazione. Ma
soprattutto la Grande Trasformazione antropologica, il nuovo
“paesaggio umano” (i noi e attorno a noi), indotto
e accelerato dai noti sommovimenti politico-economici non solo in
Europa, dalle 33 guerre (molte tra poveri) attualmente in corso o
dall’incessante saccheggio della geografia da
“qualche parte”, confluisce naturalmente nella
scrittura.
2. Penso che non esista artigiano della parola che non rifletta, operando, sul suo lavoro. Direi che ciò capiti naturalmente. Nel mio specifico caso di poeta che nasce “dalettale”, la materia stessa di cui è fatta la scrittura, la lingua/le lingue, il loro convivere o il loro contrastarsi è diventata talvolta oggetto di riflessione metapoetica, ma mai fine a sé stessa. Sinceramente il “menarsela” sulla poesia nella poesia non mi ha mai interessato troppo, fortunatamente nei poeti italiani che leggo con passione essa è una componente marginale se confrontati con altre realtà europee. Ciò non toglie che mi capitino sotto molti testi in “poetese” che si accarezzano l’ombelico metapoetico.
3. La citazione da Fortini, se vogliamo, nella prima parte è abbastanza scontata: “naturalmente” qualsiasi artigiano della parola sa che qualsiasi forma necessita di sforzo e progetto che, negli anni, si attesteranno in una sua unica, riconoscibile e indispensabile “voce”. Sul dare un valore etico-politico alla forma, avrei qualche dubbio, a meno che non si intenda con questa etichetta lo studio, la professionalità, il rigore e anche la passione con cui si affrontano pure tutte le altre questioni del vivere e agire umani. C’entra la tradizione con tutto questso? Forse, a volte, molto spesso no: le risposte che richiede questo nostro tempo molte volte non si trovano nella tradizione, richiedono inventività e impensabilità non ancora pensata. E, probabilmente, il peso, la forza, l’incidenza che Fortini e compagni d’epoca assegnavano anche socio-politicamente al loro operare letterario era “trasfigurato”, sproporzionato alla realtà dei fatti. Faccio fatica, insomma, a entrare in dialogo con le riflessioni citate. Probabilmente la domanda andrebbe riformulata.
4. La traduzione fa parte indissolubile del mio quotidiano artigianato, per motivi sia di lavoro sia di interesse: è chiaro che, scrivendo come traducendo, non si opera su una tabula rasa scoprendo l’acqua calda: la tradizione, i maestri sono lì, presenti compagni di viaggio. Come tutti i compagni di viaggio a volte possono essere però anche importuni, inquietanti, poiché se può essere vero che vi sia una qualche tensione (conscia o inconscia) a una tradizione, le sfide che il tradurre (per sua natura condizionato dall’immediatezza e dunque sempre, subito caduco) pone, necessitano di concrete strategie ogni volta nuove per affrontare adeguatamente nell’habitat di reazione il testo stimolo dando vita a un testo reazione che, magari, viaggia, è costretto a viaggiare, al di fuori di qualsiasi tradizione per arrivare da qualche parte.
5. Ma secondo me, anche qui si sfiora il banale: per chi scrive e in quella data forma, questa è sempre non conciliante, su di essa non si contratta. Se volessimo definire questa posizione come “politica”, qualsiasi poeta che sia tale, sarebbe anche “politico” e dunque tutti potrebbero essere ricondotti a una “funzione Fortini”. Penso però che non si possa fare questa uguaglianza. Certamente vi sono in circolazione determinati poeti che potrebbero rientrare, anche con la loro forma, nel concetto di “politicità” indicato da Mengaldo per Fortini (magari mi sbaglio, ma mi viene da pensare a Gianni D’Elia o a Giancarlo Sissa), quanto però essi si riconoscano nella “funzione Fortini” non posso dire. Per quanto mi riguarda, essa non mi ha mai interessato particolarmente.
[26 giugno 2008]
home> scrittura/lettura> La funzione Fortini. Risposte al questionario II