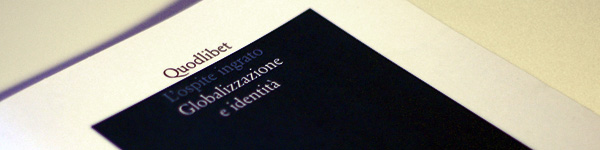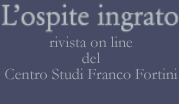home>interventi/interviste>
Su Renato Solmi
Su Renato Solmi.
Luca Baranelli
7. La critica della cultura – ed intendiamo, con Adorno, la critica
conservatrice e romantica – ha già attirato l’attenzione sul fenomeno
delle vacanze. Esso riproduce, su più vasta scala, l’antinomia di
lavoro e svago caratteristica della società borghese. (Non per nulla le
vacanze, sconosciute ai Greci dell’epoca classica, sono state inventate
dai Romani: il concetto di vacanza è strettamente connesso alla
separazione di pubblico e privato e alla fondazione dello «stato di
diritto».) Ma con la trasformazione della società borghese in società
di massa, o, se si preferisce, con la decadenza della società borghese,
anche le vacanze entrano in una fase qualitativamente nuova. Gli
antichi concepivano le vacanze come espressione tipica del privato,
come l’otium per eccellenza: consoli e oratori si ritiravano
nella
villa tiburtina o prenestina, dove attendevano alle letture e ai
piaceri della vita campestre. Questa concezione ritorna nel
Rinascimento, e perdura – pressoché immutata – durante tutta la
parabola ascendente della borghesia. Le vacanze rappresentano
l’apoteosi della vita privata, e instaurano – o tendono ad instaurare –
un felice equilibrio tra civiltà e paesaggio, proprietà privata e
natura. L’aurea mediocritas della villeggiatura borghese fa
parte di
quell’«apparenza di vita» che Marx concedeva ancora agli sfruttatori
del suo tempo. Ma che cos’è rimasto, oggi, di quell’apparenza?
Nell’aggiornamento della celebre definizione marxiana è la sostanza
delle considerazioni di Adorno. Al dominio – sempre più totale – del
lavoro alienato fa pendant l’alienazione delle vacanze. Anche
qui, come
altrove, l’alienazione si presenta come esasperazione, tendenza
all’eccesso. Il borghese vorrebbe dimenticare di esserlo. Il soggiorno
in villa era la proprietà quieta, trasparente e compiaciuta della
propria essenza: fonte di energie per la proprietà in movimento,
impegnata nella lotta e nella concorrenza. Oggi, nelle vacanze, il
borghese vorrebbe cancellare la propria determinazione di classe, e
provare – con falsa evidenza – la tesi in cui non crede più da tempo:
che il borghese è l’uomo, e l’uomo è il borghese. È questo il senso del
ritorno alla natura. Il borghese in slip sfida chiunque a
riconoscerlo,
e crede di essersi liberato per sempre di bastone e bombetta. Ma la
nuova barbarie non fa che smascherare la vecchia. Col proprio corpo, il
borghese mette a nudo la propria essenza: e la sua verità perviene a se
stessa. Mentre i resti della borghesia ottocentesca trascorrono le loro
ferie piovose in piccoli châlets di montagna, dove famiglie
numerose e
timide convivono in living-rooms troppo stretti e cercano di
proteggere
la loro autonomia dalla minaccia permanente della canasta, la canaglia
up to date si raccoglie nel collettivo della spiaggia.
L’opposizione,
ormai diffusa, non è meno falsa della promiscuità che denuncia. Lo
snobismo dei gruppi che si dànno convegno – anno per anno – in un’isola
selvaggia e fuori mano, fieri della differenza e della propria
scoperta, è di cattiva lega come lo humor di certi bohémiens
attardati
che si distinguono dai borghesi solo perché sanno fare loro il verso.
Ma l’ultimo termine di questo sviluppo è nella falsa abolizione del
contrasto. Come l’automobile diventa uno strumento di lavoro, e il
sonnellino è in funzione del profitto, sparisce la distinzione di
attività e riposo, di vacanza e trasferta. Il privato è sussunto – in
tutto e per tutto –sotto lo schema della produzione. Come i managers
ultimo modello fanno a meno delle vacanze, sparisce il confine tra
lavoro e tempo libero, e il primato del rendimento penetra nelle
reazioni più sottili. Tutto diventa, anche contro la volontà dei
soggetti, oggetto di calcolo. Ma a chi teme di perdere ogni minuto, i
minuti fuggono tra le dita. L’integrazione del tempo libero è la
caricatura della vera vita. Ritorna, anche qui, uno schema tipico di
Adorno: l’autonomia sparisce nella negazione della differenza, e la
società totalitaria è la verità della società borghese.
Se mi sono deciso a questo breve
intervento non è solo per le insistenze di Giovanni La Guardia, ma
perché credo che ognuno di noi debba esprimere riconoscenza a Renato
Solmi per quello che ha fatto nella sua vita di studioso, insegnante e
militante, e che si riflette almeno in parte nell’Autobiografia
documentaria. Rispetto ad altri, io ho anche un debito di
riconoscenza
personale e ormai quasi cinquantennale con lui, che nella primavera del
1962 favorì il mio ingresso da Einaudi. Ero un laureato come tanti, e
ancora mi domando per quale concorso di circostanze Renato fu indotto a
darmi fiducia. Fatto sta che lui, il redattore di maggiore spicco della
casa editrice, fu licenziato un anno dopo, nell’autunno del ’63, per
presunte e pessime ragioni di Realpolitik aziendale; e io invece vi
rimasi fino al 1985.
Quando arrivai da Einaudi sapevo in modo generico
ciò che Renato aveva fatto e scritto nel decennio precedente. Nell’anno
e mezzo che lavorai al suo fianco, in quello che fu il mio
apprendistato editoriale, egli non si occupava più di Adorno e di
Benjamin, ma aveva la responsabilità di una collana di attualità
politica, i Libri bianchi, consona alla mia formazione e ai miei
interessi. In quegli anni aveva conosciuto in casa editrice Raniero
Panzieri e si era avvicinato all’attività politica e di ricerca dei
Quaderni rossi. Aveva inoltre cominciato a studiare a fondo il problema
degli armamenti atomici e del disarmo nucleare.
Come sapete, e come l’Autobiografia documentaria mostra, la sua
scoperta di Minima moralia risale al 1952, appena un anno dopo
la prima
edizione tedesca (si veda la recensione apparsa nel febbraio del ’53) e
l’edizione ridotta da lui curata appare nel 1954; la sua raccolta
benjaminiana Angelus novus esce nel 1962 (ma Renato ci aveva
lavorato
in anni precedenti); e la traduzione della Dialettica
dell’illuminismo
è portata a termine nel 1961, anche se sarà pubblicata nel 1966, quando
non era più da Einaudi, con lo pseudonimo di Lionello Vinci (solo nel
1980, nell’edizione della collana Einaudi Paperbacks, sarà accreditata
a Renato Solmi).
Ricordiamoci anche che quando Renato scoprì, propose, tradusse e
introdusse in Italia quel libro era un giovane fra i venticinque e i
ventisette anni. Qualche anno fa proprio Renato mi disse ridendo che,
quando era molto giovane e riempiva incessantemente quaderni di
scritti, poesie, traduzioni, note e abbozzi, suo padre gli diceva
scherzando che era come se scrivesse sotto dettatura dello spirito
santo.
Sul lavoro di Renato per far conoscere in Italia Benjamin, Adorno e la
scuola di Francoforte nel decennio 1952-1961 occorrerebbe forse un po’
di filologia editoriale per ristabilire una cronologia reale, diversa
da quella fuorviante del catalogo Einaudi. A tal proposito, vorrei
aggiungere che la nuova edizione integrale di Minima
moralia uscì nella
NUE nel 1979 in un modo che a me pare deplorevole: per sapere che è la
prima traduzione italiana completa bisogna cercare una riga in corpo
minore nella pagina del copyright; Renato Solmi compare giustamente
come traduttore sia in frontespizio sia in sopracoperta, ma non si dice
da nessuna parte che è stato lui stesso a completare e correggere la
traduzione del 1954; e che le numerosissime note al testo sono sue.
L’altra novità, più rilevante e a mio avviso scandalosa, è la scomparsa
della sua Introduzione, anche se Leonardo Ceppa, autore della nuova
Introduzione, dice subito, alla quarta riga, che quella di Solmi «fece
epoca». Ma perché, allora, non includerla in questa nuova edizione? E
perché non aggiungere le precisazioni contenute in una sua lunga
lettera del 1977 al direttore di «Belfagor» (inclusa nell’Autobiografia
documentaria, pp. 257-62)?
Nel 2006 mi ricordai, ci ricordammo, che l’anno successivo Renato
avrebbe compiuto ottant’anni; e con Michele Ranchetti, suo amico dai
tempi di scuola, pensammo di raccogliere tutti i suoi scritti editi in
un volume della collana Verbarium, che Michele dirigeva nell’ambito
della casa editrice Quodlibet. Il merito di questa iniziativa va
comunque esteso al Centro Fortini e a Luca Lenzini; a Raffaella Solmi,
sorella di Renato e preziosissima collaboratrice in tutte le fasi della
lavorazione del libro, dal reperimento di alcuni testi giovanili alla
correzione delle bozze; e alla mia carissima e compianta compagna
Fiamma, che collaborò alla scansione e al controllo dei testi
originali. Per me rivendico il compito più ingrato: avere costantemente
e ostinatamente incalzato Renato nei mesi in cui il libro prendeva
forma; ed essermi molto arrabbiato con lui, e con successo, quando
minacciava di non volervi includere le sue Introduzioni a Adorno e
Benjamin, e in particolare quella a Minima moralia (una
singolare
coincidenza censoria con chi aveva approntato l’edizione Einaudi della
Nue), o quando non sapeva decidere che taglio dare all’introduzione. La
struttura del libro e la divisione in sette sezioni
tematico-cronologiche sono invece opera di Renato.
Degli scritti che compongono il libro posso dire che avevo letto in
tempo reale quasi tutti quelli delle ultime tre sezioni, che Renato
scrisse e pubblicò nel corso degli anni ’60 e ’70 del Novecento sui
«quaderni piacentini», nella Serie politica Einaudi e in altre sedi. Se
la sezione La contestazione nella scuola documenta l’impegno e
il
lavoro da lui profusi nei lunghi anni del suo insegnamento (ma sappiamo
che ci sono, ancora inediti, molti materiali didattici che Renato
preparava per i suoi corsi di filosofia e di storia), quella dedicata
alla Nuova sinistra americana, alla guerra del Viet Nam e ai
movimenti
pacifisti contiene testi di grande rilievo sia documentario sia teorico
(spesso gli spunti teorici più innovativi vanno cercati nelle note).
Negli Sguardi sul passato, infine, Renato riannoda i fili della
sua
biografia rendendo omaggio a familiari come il padre Sergio Solmi,
grande critico poeta e scrittore del Novecento, a un amico fraterno
come Luciano Amodio e ad altre figure di amici e compagni come Delfino
Insolera (a cui il libro è dedicato), Raniero Panzieri (che interagì
intensamente con Renato nei primi anni ’60), Sergio Caprioglio e altri
ancora.
Io non ho alcuna formazione e competenza filosofica. Ma penso di poter
ugualmente apprezzare l’Introduzione di Renato a Minima moralia
come un
testo quasi miracoloso per l’immaginazione critica e lo stile; e per
quel che vale la mia impressione, mi pare che essa sia all’altezza di
Adorno. A mo’ di esempio vorrei leggervi il paragrafo 7
dell’Introduzione a Minima moralia.
Vorrei concludere con un auspicio. Alcuni di noi sanno che Renato
conserva numerosi testi e materiali preparati per le sue lezioni
d’insegnante di liceo; la traduzione integrale di Della guerra
di
Clausewitz; versioni integrali o parziali di grandissimi poeti
dell’Ottocento; e anche poesie giovanili proprie. Bisognerebbe che
amici ed estimatori gli facessero sentire il grande interesse che c’è
per questi suoi lavori inediti e lo incitassero a pubblicarli. Mi
sembra che proprio l’esperienza felice dell’Autobiografia
documentaria
– un libro nato dall’iniziativa di un gruppo di amici – ci possa
incoraggiare a farlo.
Siena, 14 dicembre 2010.
home>interventi/interviste> Su Renato Solmi.