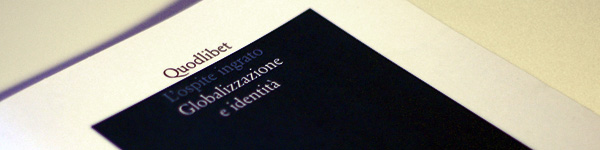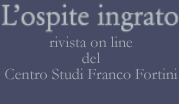home>interventi/interviste> Su Ceti medi senza futuro?
Su Ceti medi senza futuro? di Sergio Bologna. Note per una discussione
Maria Vittoria Tirinato*
Leggendo
l’ultima raccolta di scritti di Sergio Bologna sul
lavoro ho avuto la sensazione di trovarmi davanti ad una di quelle
mappe che, nelle stazioni o nelle piazze delle città,
aiutano i viaggiatori ad orientarsi. Se l’analisi della
riorganizzazione capitalistica postfordista è la mappa della
città, la descrizione del lavoro in Occidente sembra avere
la funzione di quel prezioso punto rosso che dice ai viaggiatori:
«voi siete qui». Come ogni mappa che si rispetti,
anche questa contiene indicazioni su come muoversi in città:
si tratta di un aspetto importante perché il paesaggio
urbano è irriconoscibile anche solo rispetto a un decennio
fa; molte sono le strade interrotte, i ponti crollati, le sopraelevate
incompiute. Oltre ad indicare le linee “soppresse”
o inefficienti (la critica ai sindacati e alla sinistra istituzionale
è senza sconti) Bologna esamina anche nuove
possibilità di movimento, affrontando questioni pratiche e
teoriche di non poco rilievo.
La premessa decisiva è che la riorganizzazione postfordista,
nell’ultimo trentennio, ha frantumato i luoghi della
produzione per incrementare l’estrazione di plusvalore e
neutralizzare il potenziale conflittuale che la fabbrica, nella figura
dell’operaio massa, aveva espresso negli anni Sessanta e
Settanta. Il soggetto sociale su cui si focalizza
l’attenzione, in parziale continuità con le tesi
del 1997,¹
è quello dei lavoratori autonomi di seconda generazione. Non
sono i classici architetti o avvocati ma tutte quelle figure,
dall’autotrasportatore al giornalista freelance,
dal consulente al grafico pubblicitario, che non sono dipendenti e
nemmeno tutelate dagli Ordini professionali. Appartengono a questo
grande insieme le Partite IVA, le “ditte
individuali”, la tanto celebrata
“microimprenditoria”: è questo, avverte
l’autore statistiche alla mano, l’unico settore
produttivo italiano veramente dinamico. Bologna include tra le nuove
figure del lavoro anche i collaboratori coordinati, i lavoratori a
progetto e in generale i titolari di contratti
“atipici” (ma questo stesso aggettivo è
giustamente messo in discussione) che prestano la loro forza lavoro
– manuale ma soprattutto e sempre di più
intellettuale – a enti pubblici o a privati.
Il merito fondamentale di questo libro consiste a mio parere nella
demistificazione della retorica che impedisce di comprendere una parte
importante dei rapporti di produzione oggi. Bologna smantella pezzo per
pezzo l’ideologia bipartisan secondo cui questi lavoratori,
per i quali spazi e tempi di lavoro spesso coincidono con quelli di
vita e che sono privi di tutele sociali e previdenziali, vengono
collocati nel campo simbolico del capitale come “piccoli
imprenditori”. Il perno di questa operazione è un
concetto fondamentale e molto semplice, ribadito più volte
nel testo: se è vero che perché si dia impresa
sono necessarie almeno tre figure (il capitale, il management e il
lavoro) è facile comprendere che, quando questi ruoli sono
incarnati in una sola persona, siamo in presenza di
un’impresa almeno quanto lo siamo della santissima
Trinità.
L’analisi si fonda su una pluralità di strumenti,
dalle testimonianze raccolte da blog italiani, europei e statunitensi
dedicati al lavoro autonomo/precario, ai siti internet di associazioni
e giornalisti, alle ricerche prodotte da enti ufficiali, banche,
istituti pubblici e privati. Le citazioni da scritti e saggi di
esperti, economisti sociologi politologi, sono invece più
rare. Questa scelta rimanda a una presa di posizione molto precisa: per
comprendere il lavoro oggi, sembra suggerire l’autore,
è molto più utile ascoltare le voci dei
protagonisti, che le leggere disquisizioni accademiche lontane anni
luce dalla realtà.
Bologna impiega come fonte anche la propria carriera professionale,
dedicando pagine illuminanti sia alla narrazione della propria
esperienza come consulente freelance nel settore
della logistica, sia all’analisi di questo settore come nodo
strategico e specola privilegiata del postfordismo.
Attraverso l’uso incrociato di queste fonti si organizza
insomma un riposizionamento percettivo, grazie al quale si
può guardare al lavoro con lenti simili a quelle che sole
permettevano ai protagonisti di Essi vivono
– eccezionale b-movie di John Carpenter,
scritto e ambientato non a caso in epoca reaganiana – di
accorgersi che il mondo è invaso dagli alieni, e di
organizzarsi di conseguenza.
Il libro vede affiancati e organizzati in tre sezioni interventi di
natura molto diversa, dal saggio all’articolo,
dall’intervista alla prefazione o alla recensione. La scelta
di questa composizione mi sembra legata in parte alla critica rivolta a
tanta letteratura “ufficiale” sul lavoro, in parte
alla stessa personalità intellettuale dell’autore.
La sua educazione umanistica, le esperienze politiche e culturali degli
anni Sessanta e Settanta, la professione e le attenzioni di oggi sono
tutte compresenti nel testo, e tutte contribuiscono alla declinazione
del tema-cornice, che è quello della democrazia (intesa, con
Polànyi, non come sistema di governo ma come
«forma ideale di vita», p. 7).
Per quanto ricca e affascinante, questa struttura rende in
realtà complicata una disamina sistematica di tutti i temi
affrontati. L’impostazione di fondo e il retroterra
metodologico tendono a fare da collante, ma
l’eterogeneità degli interventi non facilita la
percezione della coerenza complessiva del discorso. Questo si avverte
soprattutto sul versante pratico-politico, dove l’analisi
sembra a tratti perdere di vista elementi a mio parere decisivi della
stessa realtà che, per altri versi, rischiara. Vorrei dunque
concentrarmi su questi passaggi, che mi paiono i più fecondi
proprio perchè richiedono la collaborazione critica del
lettore.²
Le osservazioni che seguono
sono basate sui tre saggi più organici (L’undicesima
tesi, I lavoratori della conoscenza dentro e fuori l’impresa,
Il senso della coalizione), collocati nella sezione
Postfordismo e dintorni, non a caso la più nutrita
del libro.
Un primo punto critico riguarda l’analisi psico-sociale del
lavoratore autonomo di seconda generazione, in particolare in tema di
“libertà”. Sulla scorta delle
testimonianze raccolte da internet e assumendo l’ottica di
una parte del femminismo italiano, l’autore afferma che
questi lavoratori, più o meno giovani e spesso donne,
scelgono talvolta liberamente il lavoro autonomo «per
difendere una propria autonomia e indipendenza di vita o per conciliare
il lavoro conto terzi e il lavoro di cura» (pp. 31-32). A
questo proposito, Bologna aggiunge che il «rifiuto del lavoro
normato», così come si manifestò nel
’77, è una delle cause della riorganizzazione
postfordista e dunque della «precarizzazione», e
che per questo si dovrebbe dismettere ogni accento vittimista e
guardare anche al lato positivo della situazione.
Ora, anche accogliendo il presupposto non scontato della libertà
di simili scelte – le sottili coercizioni esercitate dal
capitalismo sono reali quanto difficilmente misurabili – va
in primo luogo considerato il fattore “durata”. Non
occorre citare dati statistici per affermare che, alla lunga, il lavoro
autonomo stanca ed aliena. Del resto è proprio questo uno
dei presupposti dell’analisi: se, come nella maggior parte
dei casi, le condizioni iniziali di incertezza materiale e psicologica
permangono, se non esistono tutele che consentano di accettare
più serenamente il rischio, se tutto resta precario per
troppo tempo, anche il lavoro autonomo diventa
un’insostenibile schiavitù. A questo punto, per
quanto libera fosse stata in origine, il lavoratore tenderà
a riconsiderare la propria scelta. Qui si presenta una delle
incongruenze cui accennavo: rivendicare la libertà di scelta
e la parziale indipendenza che questo tipo di lavoro concede significa
in parte smussare la critica all’asservimento che lo
sottende, cioè una delle premesse fondamentali del discorso.
È vero che le testimonianze colte dalla rete e utilizzate in
quest’ottica hanno un peso e una verità non
trascurabili. Ma non si tratta pur sempre di narrazioni soggettive che,
in quanto tali, sono in complesso rapporto con la realtà
oggettiva cui rimandano?
Dal punto di vista femminile c’è un altro dato da
considerare. Se è vero che il lavoro autonomo può
conciliarsi col lavoro di cura è altrettanto vero che, in
alcuni casi, esso può rappresentare un impedimento non solo
alla possibilità di stabilire relazioni durature, ma anche a
quella di procreare. Le «mutazioni antropologiche»
che, come si osserva giustamente, riguardano questi lavoratori, non
sono ancora mutazioni genetiche: l’orologio biologico della
donna, qualunque sia il lavoro che svolge, la conduce inesorabilmente
verso un momento in cui diventare madre sarà più
complicato, più rischioso o addirittura impossibile, mentre
il permanere di condizioni materiali precarie tende a ritardare la
scelta della maternità. Non si tratta di fare le
«vittime», senza dubbio
l’autodeterminazione e la tutela dei diritti della donna non
è legata solo alla possibilità di fare figli, ma
questo è un altro discorso. Oltre a considerare che il
capitalismo valorizza – in senso marxiano – alcune
funzioni femminili («oggi il lavoro delle donne
[…] è il lavoro tout court»,
p. 32) bisogna forse anche chiedersi quali funzioni, altrettanto
femminili, esso tenda a reprimere.
Anche sotto il profilo ideologico e più immediatamente
politico la rivendicazione di strategie di libertà
individuali sembra in difficile coabitazione con la tensione verso
un’identità collettiva. Anche qui, la pratica
della narrazione soccorre ma fino a un certo punto. Siamo certi che la
narrazione, oltre ad offrire materiale conoscitivo, abbia di per
sé la capacità di convertire i vissuti in
esperienza universale, in dinamica collettiva?
Infine e a margine vorrei aggiungere che, se l’ideologia
liberale ha riassorbito e neutralizzato alcuni dei contenuti
più dirompenti degli anni Settanta, trasformandoli nella
schiavitù quotidiana di milioni di persone, questa mi pare
più che altro una sconfitta storica, su cui ancora manca una
riflessione complessiva (almeno dal punto di vista degli sconfitti).
L’analisi del lavoro postfordista, come si è
accennato, riguarda anche i lavoratori della conoscenza. Nel testo si
chiarisce che i lavoratori autonomi di seconda generazione
possono essere lavoratori della conoscenza e viceversa, ma
che le due categorie non sono completamente sovrapponibili. La
realtà del knowledge work, dipendente o
autonomo, è svelata con estrema chiarezza:
la
figura del knowledge worker è
indissolubilmente legata al computer portatile nella sua doppia
funzione di strumento di elaborazione-comunicazione […] e di
organo di una specifica organizzazione del lavoro, quella
caratterizzata dall’ubiquità del posto di lavoro
[…]. Col portatile ti porti appresso il luogo di lavoro, ti
sposti l’ufficio ovunque, cioè non ti stacchi mai
dalla prestazione, sei perennemente produttivo, almeno
finché sei sveglio. Ma è proprio questa
libertà di scelta […] a condizionare la
“schiavitù” del knowledge
worker» (p. 97).
Scrostato dalla retorica della libertà da gerarchie e tempi
prestabiliti, la condizione del lavoro intellettuale
nell’impresa, dipendente o indipendente che sia, si presenta
dunque in questi termini.
Il mito liberale e democratico del lavoratore della conoscenza sarebbe
tuttavia alimentato da due connotati propri della sua
attività: quello dell’«indiscriminata
accessibilità al mercato» e quello
dell’«indiscriminata accessibilità
all’uso del computer, cioè della
possibilità di accedere al linguaggio dei simboli senza
educazione formale, con una semplice scolarità di
base» (ibidem). Questo mito, secondo
Bologna, «scricchiola» proprio se si riflette sul
secondo elemento: non è vero che i lavoratori della
conoscenza possono divenire tali senza un’elevata
scolarizzazione, è vero invece che la maggior parte delle
imprese assumono, nei posti di maggiore responsabilità, solo
persone provenienti da università private e con percorsi di
specializzazione costosissimi ed esclusivi, anche se non
particolarmente meritevoli. La generale accessibilità al
lavoro di conoscenza, dunque la profonda democraticità della
società su di esso fondata, sarebbe quindi smentita,
perchè solo una esigua minoranza selezionata per censo
può permettersi di accedere a questo tipo di formazione.
L’autore tematizza qui il rapporto pubblico/privato e
s’interroga sull’adeguatezza dei sistemi formativi
«rispetto ai bisogni delle imprese che si muovono in un
mercato globale» (p. 135).
Bisogna considerare che, da una decina d’anni, i sistemi
formativi europei tentano di riorganizzarsi proprio per rispondere alle
«sfide» dell’economia della conoscenza, o
meglio alle esigenze degli attori forti di questa economia,
multinazionali in primis (a questo riguardo
è utile leggere i documenti dell’U.E. sulla
costruzione dello Spazio Europeo della Ricerca e
sull’armonizzazione dei sistemi formativi dei paesi membri).³ Se
si analizzano strutture e tendenze del sistema, risulta chiaro che
l’obiettivo essenziale è individualizzare i
percorsi formativi – così come si individualizzano
i rapporti di lavoro – ed educare da una parte alla logica di
impresa, dall’altra allo specialismo più estremo.
Venendo all’Italia, e fatte salve le nostre
specificità, si può osservare che, con
l’introduzione del 3+2 (riforma Berlinguer-Moratti),
l’università di massa tende a sfornare individui
ossessionati dal mito della produttività
(quantità e ritmi degli esami sono il vero nocciolo della
valutazione), incapaci di cogliere i nessi tra discipline e tra
contenuti, privi di funzioni socio-intellettive
“pericolose” quali la capacità di
astrazione, l’esercizio critico, il senso di cooperazione. I
percorsi post lauream, diversificati quanto
costosi, servono a specializzare ulteriormente questi lavoratori per
renderli più competitivi, o (come in Italia) a ritardarne
l’immissione sul mercato. Come si vede, la questione della
formazione oggi non investe solo i contenuti, la sua maggiore o minore
accessibilità, la sua durata, ma la sua stessa architettura
e il suo orientamento. Per queste e per altre ragioni che non
è possibile elencare in questa sede, la risposta alla
domanda dell’autore circa l’adeguatezza dei sistemi
formativi rispetto alla knowledege economy
è sostanzialmente affermativa. Ma è proprio
questo il problema: i sistemi formativi postfordisti sono organizzati
in modo da evitare che i lavoratori possano assumere una qualche
consapevolezza di sé e attrezzarsi per la difesa dei propri
diritti. In altre parole, per andare alla radice del problema,
è necessario prendere atto che il tramonto
dell’educazione formale da cui lo stesso Bologna proviene
è diretta conseguenza della spinta ad adeguare i sistemi
formativi a questi rapporti di produzione: non si tratta solo di
«compensare il peso attribuito alle discipline
tecnico-scientifiche riscoprendo il valore degli insegnamenti
umanistici» (p. 135), o di chiedersi se le imprese possano
farsi carico dei costi del lifelong learning.
È necessario mettere in discussione il sistema formativo
dalle fondamenta, in termini pratici e teorici, considerandolo oggi
più che mai specchio e pietra angolare del sistema
produttivo.
Un’ultima osservazione riguarda quelle che ho definito
“indicazioni per muoversi”. Nel saggio Il
senso della coalizione, Bologna sostiene che il web
è «uno dei pochi terreni sui quali la condizione
isolata, individualizzata della lavoratrice e del lavoratore nel
postfordismo raggiunge una dimensione collettiva,
un’espressione corale» (p. 11). Questo è
senz’altro vero, ma mi pare si debba sottolineare la
distinzione tra “espressione corale” e
“dimensione collettiva”. Un conto è lo
sfogo, la denuncia, la testimonianza, un conto è la
consapevolezza che la propria condizione possa essere migliorata solo
attraverso pratiche condivise, che mettano in difficoltà la
controparte. Purtroppo siamo ben lontani da questo, anche nelle
realtà di lavoratori precari che si dotano di una forma
più o meno organizzata per raggiungere obiettivi sindacali.
In questi ambiti, la comunicazione via internet è in genere
uno strumento utile per confrontarsi su temi di analisi o programmi di
intervento, e uno spazio per dar voce ai singoli precari. Spesso
isolati nei loro stessi ambiti di lavoro, quasi sempre isolati
nell’uso di internet, questi singoli trovano nel blog o nel
sito di riferimento la possibilità di condividere le proprie
opinioni, sensazioni, frustrazioni, persino quella di formulare
proposte dettate dall’elaborazione personale di stimoli e
notizie. Non è poco, ma il problema arriva quando si tratta
di passare all’azione, di darsi una dimensione pubblica.
È a questo punto che le reti fatte di individui, che non
abbiano alle spalle e sotto i piedi una dimensione collettiva, rivelano
la loro debolezza. Si potranno promuovere appelli, lettere aperte, class
actions. Si potrà organizzare qualche bella
manifestazione-evento, o tentare operazioni di lobbying.
Ma è lo stesso Bologna ad avvertirci, ad esempio a proposito
dei movimenti contro il CPE in Francia, che «mille siti non
avrebbero potuto sortire gli effetti di una grande manifestazione nel
centro di Parigi» e che «l’uso del web
quindi non può sostituire la dimensione pubblica, visibile,
della protesta […] ma la dimensione pubblica […]
deve avere essa stessa certe caratteristiche, in primo luogo quella
della continuità» (p. 21). La
divaricazione tra queste considerazioni e quelle secondo cui sarebbe
inutile «intestardirsi a voler innescare dinamiche di
coalizione secondo i vecchi schemi e modelli del fordismo»
(p. 15) mi sembra difficilmente sanabile.
Gli esempi di lotte di lavoratori precari e persino di autonomi di
seconda generazione tuttavia non mancano. Bisogna tener conto anche del
fatto che i lavoratori non sono sempre isolati: il call center
è una linea produttiva a tutti gli effetti (e anche,
certamente, un panopticon dotato di strumenti di
controllo ben superiori a quelli dei vecchi capireparto) dove decine o
centinaia di lavoratori svolgono le stesse mansioni;
l’università e i luoghi dell’impiego
pubblico vedono una concentrazione sempre maggiore di lavoratori
“a contratto” o “a progetto”.
Si può obiettare che gli autonomi, i freelance
dell’industria dello spettacolo, le Partite IVA ecc. vivono
una condizione diversa, più frammentaria: bene, al tempo
stesso si può osservare, e Bologna l’ha fatto, che
forme visibili di organizzazione e di lotta – anche grazie al
web – questi lavoratori le hanno praticate con successo. I
picchetti (pratica di lotta tradizionalmente operaia) degli
sceneggiatori di Hollywood saranno stati tutt’altro che
virtuali: per organizzarli, nemmeno un’assemblea?
Il problema fondamentale è quello del conflitto, e resta
sostanzialmente aperto. La rete può aiutare, ma non basta; i
sistemi formativi sono programmati in senso opposto. Come ho cercato di
dimostrare, le pratiche di narrazione e le libertà
individuali sono certamente necessarie, ma non sufficienti.
Uno dei nodi su cui ancora riflettere, a questo proposito, è
quello della compresenza di fordismo e postfordismo sia in Occidente,
con la sopravvivenza di «ampi segmenti di forza lavoro
“garantita”» (p. 16), sia nei
“Paesi terzi”, destinatari di delocalizzazioni e
mittenti di forza lavoro ricattabile, anch’essa funzionale
alla programmata «rottura dell’unità di
classe» (ibidem). La costruzione di
un’identità autonoma delle forme di lavoro
postfordiste non può, a mio parare, prescindere da queste
considerazioni.
Paradossalmente – ma non troppo – ho trovato l’indicazione politica più innovativa nella parte del libro dedicata alla storia dell’operaismo. Va detto che questa sezione, intitolata Operaismo e dintorni, si può anche leggere come una lunga postfazione in itinere al discorso sul lavoro oggi – come dire che la storia offre a chi li cerchi strumenti per leggere il presente, e immaginare un futuro. Qui, Bologna ci ricorda che «il problema del conflitto è in realtà il problema della “politica” tout court» (p. 242) e che chi sceglie di agire in questo campo, oggi come quaranta anni fa, è costretto a «produrre pensiero politico» oppure a produrre «ricerca come base di un pensiero politico» (ibidem). Pensare e agire oggi in termini di coalizione significa innanzitutto recuperare la funzione intellettuale, non come prerogativa di gruppi specializzati ma come «mente politica» (p. 236), collettiva e individuale, in ogni ambito di competenza. Di questi tempi, non è davvero poco.
*Precaria della ricerca all’Università di Siena. Collabora col Centro Studi Franco Fortini e fa parte del Gruppo Intrecci, che da tre anni produce ricerca e dibattito sul nesso capitale/lavoro/formazione.
1. S.
Bologna et al., Il lavoro autonomo di
seconda generazione. Scenari del postfordismo in Italia.
Feltrinelli, Milano 1997.
2. Per una panoramica della discussione sul libro rimando alle
recensioni di L. Cigarini, C. Marazzi, Klaus Neudlinger e altri,
raccolte in un dossier in corso di pubblicazione per DeriveApprodi, e
scaricabile alla pagina internet
www.deriveapprodi.org.
3. Cfr. Documenti ufficiali dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/education/sitemap_it.html.
.
home>interventi/interviste> Su Ceti medi senza futuro?