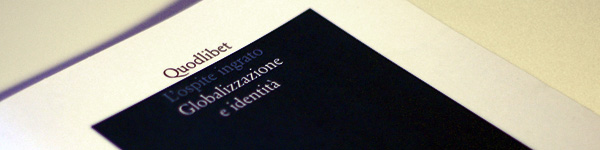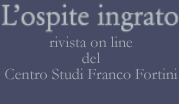home>interventi/interviste> “un outsider che interviene, non fa testo, e poi se ne va…”: Michele Ranchetti (1925-2008)
“un outsider che interviene, non fa testo, e poi se ne va…”: Michele Ranchetti (1925-2008)1
Paola Di Cori
1. uno studioso non comune
All’interno del panorama culturale italiano degli ultimi decenni una
contrapposizione potrebbe bene sintetizzare la figura di Michele Ranchetti, il
quale sembra oscillare come tra due punte estreme. Da un lato, egli è stato
venerato come Maestro con la M maiuscola da un numero consistente - seppur
limitato - di allievi, amici, lettori, e intellettuali (toscani, lombardi,
torinesi, napoletani; ma anche tedeschi, francesi, inglesi) che avevano avuto
modo di conoscerlo e incontrarlo fin dal dopoguerra nel corso delle innumerevoli
iniziative che per decenni l’hanno visto agire in Italia da acutissimo e
discreto protagonista della vita culturale e del dibattito su temi
storico-filosofici e sulle pratiche religiose post-moderniste2. Dall’altro lato,
Ranchetti rimane un nome molto poco conosciuto; ancor meno letto e apprezzato,
perfino presso un pubblico colto; così in vita, ma ancor di più dopo la sua
scomparsa, avvenuta nel febbraio del 2008. Essere stimatissimo da pochi e
sconosciuto da molti, è stato anche ciò che ha contraddistinto le numerose
attività editoriali da lui promosse, le poesie e i tanti scritti sparsi in
riviste e pubblicazioni di genere assai diverso. Era un intellettuale che amava
insegnare, promuovere riviste, gruppi e seminari, appoggiare iniziative
(possibilmente marginali), riscoprire testi inediti, pubblicare in luoghi
raffinati esercitandosi nella cultura alta. Al tempo stesso appoggiava
generosamente con il proprio straordinario ingegno gli sforzi iniziali di
giovani e poco noti gruppi ed esperienze, cui si sentiva attirato da una
profonda simpatia umana e da una insaziabile curiosità teorica.
La sua immensa versatilità, la riluttanza a fabbricare dense monografie
‘definitive’ di stampo tradizionale, il rifiuto e l’estraneità
all’autopromozione accademica, editoriale o politica, l’impegno nell’analisi
critica delle forme di religiosità in epoca storica come nella contemporaneità –
tutto ciò lo colloca accanto a uno sparuto gruppo di brillanti intellettuali
animatori della vita pubblica, rimasti indipendenti da sette e conventicole,
famiglie e partiti influenti, ai quali negli ultimi decenni spesso chi vive e
lavora in Italia guarda con profondo rispetto e ammirazione, nostalgia e
desiderio per un modello che in terra italica sembra quasi irraggiungibile.
Questo spiega anche la forte attrazione che in anni recenti si è sviluppata
intorno all’opera di Ranchetti3.
E intanto è indispensabile qualche breve cenno biografico4.
Ranchetti nasce nel 1925 a Milano da una famiglia benestante e trascorre, nelle
sue stesse parole, “un’infanzia felice e protetta”. Da giovane frequenta gruppi
di cattolici post-modernisti, studia storia all’Università Statale di Milano con
Federico Chabod, e nel 1951 va a Ivrea, come segretario di Adriano Olivetti che
sta costruendo una ‘comunità’ fatta di tecnici e di umanisti. In quella
occasione diventa amico di Franco Fortini5. Avvia fin dal dopoguerra una
impegnativa, instancabile e assai intelligente attività di consulente presso
alcuni tra i principali editori italiani del dopoguerra – Garzanti, Einaudi, Boringhieri, Feltrinelli, Adelphi; più di recente ha lavorato per la casa
editrice Quodlibet di Macerata. Dopo una collaborazione con Delio Cantimori, nel
1973 diventa ordinario di Storia della Chiesa all’università di Firenze, dove
insegna fino al 1998. Dedica le sue lezioni universitarie alla lettura di testi
poco noti della storia e della filosofia dell’età moderna e contemporanea, ma
anche ad approfondite rivisitazioni di Wittgenstein. Un corposo volume che
raccoglie scritti di allievi e amici – Anima e paura – pubblicato nel 1998 in
occasione dei suoi 75 anni, illustra l’ampio raggio di influenza del suo
insegnamento6. Oltre a un importante libro sul modernismo cattolico del 1963
(tradotto in inglese)7, la sua produzione è di una straordinaria eterogeneità,
come testimoniano i quattro volumi di Scritti diversi, a cura di Fabio Milana,
pubblicati nel corso dell’ultimo decennio – una indispensabile raccolta di
scritti scelti che senza dubbio costituisce la migliore fonte per cominciare a
conoscerne l’opera8.
Fin da bambino aveva cominciato a scrivere poesie, suonare il pianoforte,
composto musica e si era dedicato anche al disegno; come testimonia una raccolta
stampata di quelli che lui definisce “disegni scritti”9. La poesia diventa “una
sorta di elaborazione privata” che lo accompagna come una vita parallela; un
luogo “da cui far partire i tracciati della mente e degli affetti”10. Ormai in età
matura, nel 2001 vince il Premio Viareggio per la raccolta poetica Verbale11. Un
grande riserbo sulle vicende della vita privata caratterizza tutte le interviste
e autoritratti scritti12.
L’estrema versatilità di Ranchetti rende difficile il compito di descrivere il
suo percorso formativo, che certamente non avvenne mai attraverso passaggi
‘cumulativi’, di incremento progressivo della conoscenza. Nelle pagine di
affascinante autoritratto che egli costruisce negli ultimi anni di vita – e
intitola in tedesco, Über sich selbst – immagina di comporre il proprio
necrologio, e scrive di sé: “Ha insegnato molto e non ha imparato ‘niente”13.
Vede infatti se stesso imparare e conoscere non come chi attraversa delle fasi
ascendenti di apprendimento, quasi salisse i gradini di una scala; ma il
contrario. Il suo è il percorso di colui che cammina in una direzione
divergente; qualcuno che non sceglie “un itinerario verso una certezza o almeno
una persuasione conoscitiva, estetica, morale, religiosa”. Privo di tensione
verso una meta futura, egli avverte in se stesso la forza contrastante di
qualcosa che funziona come un sostegno immodificabile, simile a un “deposito
originario rimasto immutato, direi intangibile, in larga misura inconscio”. Ai
momenti differenziati di uno sviluppo ascendente avverte come sempre presente la
forza opposta e ignota: “un assieme indistinto di un sapere diverso, di cui non
conosco l’origine e la provenienza”. Sono considerazioni che contribuiscono a
illustrare i momenti chiave di quell’incessante riflessione sulla storia che lo
accompagna fin dal dopoguerra: la comprensione del tempo presente,
l’elaborazione di un’etica civile, la lettura critica della situazione politica.
Intorno a questi nodi convergono insieme sia l’impegno nella scrittura poetica
che gli studi sulle figure di riferimento fondamentali della propria
elaborazione intellettuale: Freud, Wittgenstein e Benjamin.
Gli studi intorno ai tre ‘maestri’ lo impegnano per molti anni a livello
didattico ed editoriale; ma è soprattutto nel corso degli anni ’90, nella piena
maturità, dopo la caduta del muro di Berlino e i grandi mutamenti negli
equilibri politici internazionali (guerra del Golfo, guerre nei Balcani) e
nazionali (processi di Mani Pulite, crollo della cosiddetta Prima Repubblica,
ascesa di Berlusconi) che la triade sembra esercitare l’influenza maggiore. La
scrittura di Ranchetti appare animata in questi anni da una nuova radicalità e
dal bisogno impellente di decifrare il tempo che si sta vivendo. Nell’eco
poetica di Verbale risuona la stessa urgenza: “La previsione non può avverarsi
se coincide/ con il presente: la poesia si annulla/ nell’esistente, la ragione
penetra solo nell’oggi”. Poco più avanti si stagliano i tre versi: “Per sempre o
per un poco/ Il confronto non regge: il tempo/ È immisurabile presente”14.
Per le sue profonde conoscenze della cultura e della lingua tedesca tra ‘8 e
‘900, oltre che di misticismo, di religioni occidentali e orientali, lo vediamo
protagonista di insostituibili imprese editoriali, tra cui spiccano, per
importanza: il contributo determinante all’edizione delle opere complete di
Freud, la cura di alcuni inediti di Wittgenstein (oltre a una biografia per
immagini uscita in tedesco15) e di Michel de Certeau16; nuove traduzioni delle
poesie di Celan e di Rilke, l’edizione di scritti poco noti di Adorno e di
Taubes, la presentazione di testi di Ved Mehta, di Scholem; una nuova edizione
critica delle Tesi sulla filosofia della storia di Walter Benjamin. E poi:
puntuali recensioni, commenti, riflessioni sulla storia del cattolicesimo e su
esperienze divergenti come quella dell’Isolotto, di don Milani, di Dossetti, di
Turoldo17.
Tuttavia, nessuno di questi diversi ambiti diventa mai un’area di interesse
esclusivo; al contrario, ciascuno funziona invece come elemento di riequilibrio
e contrappeso che consente allo studioso raffinato di riuscire ad elaborare
creativamente una smisurata capacità di energia intellettuale ed emotiva, base
della fondamentale tensione etica che ha contraddistinto l’intero percorso di
vita e di lavoro. Così è per la psicoanalisi e per quelle che sono state le sue
principali figure di riferimento intellettuale – Wittgenstein, Freud e Benjamin.
Nei paragrafi seguenti mi soffermo sul rapporto che Ranchetti ha avuto con
l’opera e la biografia di ciascuno di essi.
2. I manoscritti di Wittgenstein
Wittgenstein, di cui introduce nel 1999 i Diari, gli appare come il modello di
un pensiero che “ non distingue fra esperienze della vita corrente e riflessioni
di più forte connotazione teoretica”18. Pochi anni prima, nella prefazione alla
biografia scritta da Monk, commentando le scelte spesso incomprensibili di
Wittgenstein (quella di voler diventare maestro, per esempio), riprendeva le
spiegazioni date dal filosofo, il quale aveva voluto descrivere se stesso e il
senso della propria vita come simile a “quel tale che si dibatte per mantenersi
in equilibrio durante l’infuriare della tempesta e che, all’occhio di chi lo
guarda attraverso i vetri che non lasciano passare la violenza del vento, sembra
compiere movimenti del tutto privi di senso”19. Un’immagine che rimane tra le
preferite da Ranchetti per descrivere i suoi personali percorsi intellettuali e
religiosi.
Lo studio dei testi originali dei suoi maestri è al centro della acutissima
attenzione filologica di Ranchetti; una vera e propria passione che rimane tra i
caratteri distintivi del suo lavoro e che spiega le posizioni di grande
radicalità da lui assunte in veste di traduttore, consulente e responsabile di
testi editi e inediti dei suoi tre grandi maestri. Lo studio del pensiero di
Wittgenstein, e in particolare le vicende delle controverse edizioni dei
manoscritti è tra i principali impegni negli anni ’60. Per molti anni, ricorda
nel 2005, insieme a Marino Rosso ha tentato di lavorare sulle migliaia e
migliaia di pagine in tedesco tentando una lettura accurata del contesto
intellettuale e temporale in cui erano state scritte20. L’imperizia, talvolta
condita con una dose di superficialità, qualità che spesso contraddistinguono le
edizioni divenute famose dell’autore del Tractatus, scatenano una rabbia
malcelata e anche un notevole sarcasmo.
Pochi mesi prima di morire, Ranchetti ripercorre le vicende che hanno
caratterizzato i suoi numerosi tentativi per fare un’edizione critica e
filologicamente attenta dei molti manoscritti lasciati inediti da Wittgenstein e
affidati alle cure degli allievi Anscombe, Rhees, e von Wright21. Come egli stesso
ha cercato più volte di documentare, i tre si sono resi colpevoli di una
sistemazione alquanto arbitraria dei testi del filosofo austriaco. Del tutto
indifferenti alle intenzioni del loro maestro - il quale aveva dato istruzioni
per pubblicare i materiali così come essi si trovavano alla sua morte - gli
esecutori testamentari hanno invece disposto gli appunti secondo criteri del
tutto opposti, riordinando quanto era stato pensato e scritto ‘in disordin È, e
operando per tagli che hanno introdotto scansioni arbitrarie all’interno di un
lascito “che costituiva un insieme continuo”, non corrispondenti alla situazione
dei manoscritti come li aveva lasciati l’autore del Tractatus22. Questi interventi
non soltanto hanno irreversibilmente condizionato una interpretazione assai
discutibile del pensiero di Wittgenstein, ma hanno trascurato di prendere in
considerazione almeno due aspetti per Ranchetti fondamentali: la lingua e il
rapporto tra “il modo di vita e i modi del pensiero”23.
Per quel che riguarda il primo aspetto, il problema che viene sollevato è quello
di un pensatore austriaco che fa lezione in inglese ma scrive in tedesco. Questa
asimmetria tra oralità e scrittura ha provocato, a parere di Ranchetti, “uno
spostamento (Verschiebung) della comprensione del suo pensiero”24. Come accaduto
anche nel caso di Freud [cfr. il paragrafo seguente], anche per Wittgenstein i
lettori hanno avuto accesso al suo insegnamento attraverso le versioni di
allievi che avevano ascoltato le lezioni in inglese, e solo successivamente si
erano confrontati con la scrittura in tedesco. Ma questo confronto ha operato un
cambiamento di direzione nel passaggio tra le due modalità (orale e scritto) e
le due lingue; al punto che il pensiero si è trovato in qualche modo a essere
dirottato “in una cultura che è la cultura di un territorio linguistico diverso
e di tradizione differente e spesso opposta”25.
Dotato di un fine gusto per l’ironia, Ranchetti non manca di servirsene appena
si presenta l’occasione giusta. E quale potrebbe essere migliore dell’incontro
con la ’sacerdotessa’ responsabile della criticabile edizione in inglese di uno
dei suoi amati maestri– la temibile Elizabeth Anscombe?
Quando egli si reca a Cambridge per incontrare i tre allievi famosi, nel
tentativo di illustrare la propria intenzione di avviare un’edizione critica
condotta su criteri diversi da quelli delle edizioni inglesi, subisce
immediatamente l’attacco di Miss Anscombe, che lo accusa di arroganza. Ed ecco
che nel rievocare l’episodio spiacevole, Ranchetti non manca di sfogare la
propria stizza; con irrefrenabile desiderio di vendetta e una punta di
misoginia, evidenzia una nota volgare nella scena, con l’allieva prediletta di
Wittgenstein che parla mentre è intenta a un’operazione poco indicata alle
circostanze: “…sono stato aggredito da lei, che continuava a tagliarsi le unghie
con un’enorme forbice da carta: ‘Ma chi crede di essere, Lei, per criticare
Wittgenstein?’” – lo investe Anscombe26. Alquanto sconsolato, Ranchetti non può
che ritirarsi in buon ordine, rammaricandosi del fatto che i tre “non avevano
alcuna idea della filologia, del rispetto del testo”, e così facendo avevano
contribuito a produrre gravi deformazioni del pensiero wittgensteiniano27.
Più di ogni altra cosa, era andato perduto l’elemento alla base della attrazione
che Ranchetti prova nei confronti dei suoi ‘maestri’: la ricerca ad ogni costo,
pagando qualsiasi prezzo, per stabilire “una coincidenza tra vita e filosofia”.
Nei diversi tentativi dei biografi di Wittgenstein è sempre mancata o era del
tutto insufficiente l’idea di individuare i nessi tra “un’imperiosa volontà
teoretica” e “una parallela incertezza etica”, tra la genialità e radicalità
della sua ricerca filosofica, e gli aspetti ambivalenti o nascosti della vita
privata. Quest’ultima, d’altra parte, è stata troppo spesso ricondotta
soprattutto alle scelte omosessuali, “come se – osserva acutamente Ranchetti –
l’omosessualità fosse volta a volta negata o asserita o rimossa, ma per
mantenere un carattere primario tra le ragioni dell’esistenza difficile di
Wittgenstein, come se ad essa si dovesse ricondurre la sua ricerca etica, le sue
scelte di vita…”28.
3. Freud in italiano
Se gli anni di studi e ricerche su Wittgenstein sono motivati dal desiderio di
individuare un esempio unico nel ‘900, “l’ultimo esponente di una vita
filosofica”; nel caso di Freud l’ammirazione di Ranchetti è per la capacità
mostrata dal fondatore della psicoanalisi di inventare un mondo nuovo; per
essere riuscito a introdurre un lessico fino ad allora sconosciuto, e dato avvio
– con la pubblicazione de L’interpretazione dei sogni – a: “una nuova dimensione
della ricerca che non distingue fra un genere e una scienza, un’autobiografia o
autoanalisi e la scoperta di una componente della vita affettiva del singolo,
una pulsione o una difesa, ossia inaugura un territorio della conoscenza in cui
le distinzioni in un primo momento non devono aver corso, per poi ordinare in un
secondo momento le differenti appartenenze”29. Amarezze assai grandi, in occasione
del progetto di curare una nuova edizione italiana delle opere di Freud,
dovevano accompagnare gli ultimi anni di vita di Ranchetti.
Come noto, in Italia la psicoanalisi non ha ancora trovato in tempi recenti uno
o una storica (l’importante pionieristico libro del 1966 di Michel David, si
ferma proprio nel momento in cui la psicoanalisi comincia a diffondersi nella
società italiana, vale a dire negli anni ’60)30. Non c’è una figura paragonabile a
quella di Elizabeth Roudinesco per la Francia o ai diversi studiosi che ormai da
anni hanno prodotto ottime ricerche per l’Argentina, per l’Inghilterra o per la
Germania31. Se per l’Italia tali ricerche sembrano difficili da portare avanti da
parte di chi lavora ed è inserito nelle istituzioni ufficiali, il compito è
stato ricoperto, con ottimi risultati, da chi non ha mai svolto la professione
di analista. Ranchetti è stato forse l’unico intellettuale italiano ad essersi
occupato per diversi decenni degli aspetti riguardanti la possibilità e il senso
di costruire una storia della psicoanalisi. Aveva una profonda conoscenza della
lingua tedesca, e una grande familiarità, avendoli studiati per anni, con le
fonti, gli archivi, gli inediti, le amicizie e i conflitti dentro la cerchia dei
collaboratori ristretti di Freud. Si era soffermato a lungo, e con rara
competenza, sui problemi riguardanti la difficile – talvolta impossibile -
traducibilità di alcune parole chiave del vocabolario tecnico della
psicoanalisi. Aveva inoltre criticato senza mezzi termini, le scelte editoriali
che erano state alla base della edizione per l’editore Boringhieri, a cura di
Musatti, delle Opere di Sigmund Freud (OSF). Su tutti questi temi, il contributo
di Ranchetti è stato illuminante, preciso, diretto a rendere problematicamente
comprensibile un prodotto complesso e talvolta magmatico, che per le
associazioni professionali e i loro affiliati è stato preferibile talvolta
vedere ‘sistemato’ in bell’ordine al pari di un catechismo, piuttosto che
considerarlo come un materiale che ha continuamente bisogno di essere decifrato.
Di Freud, a Ranchetti interessava non solo la geniale impresa che condurrà alla
psicoanalisi; ancora di più era attirato dall’interno dissidio etico,
professionale e religioso di una mente tormentata32.
Anche se l’incontro con James Strachey prima di avviare l’edizione italiana
delle opere di Freud, è stato assai diverso da quello con gli allievi/editori di
Wittgenstein, e improntato a una grande cordialità, le questioni che stanno a
cuore a Ranchetti sono assai simili: la lingua, e l’attenzione filologica.
Accanto ai quesiti sulle fonti lacunose, ne spuntano altri non meno rilevanti,
riguardanti il perchè “la parte dei ‘malati’ sia del tutto assente dalla
‘storia’: come se, ancora una volta, si trattasse di una storia scritta dai
vincitori…”33. Inoltre, egli lamenta più volte il fatto che si pretenda di fare
una storia unitaria di qualcosa che invece è “un insieme spesso contraddittorio
di scuole di pensiero, di strategie di potere, di tecniche”34. Coerentemente, per
molti anni continuerà a insistere sulla lacunosa storia della psicoanalisi in
Italia, la scarsa valorizzazione del contributo di Weiss, le crociate dei
cattolici, attraverso padre Gemelli, per emarginarla dalle università e per
deprivarla di ogni significato etico. Come ricorderà nel 2006 parlando
dell’assenza totale di Freud nella cultura italiana degli anni ’50 e ’60, dovuta
alla presenza “dell’istruzione e della cultura cattolica, che escludevano per
principio la psicoanalisi e tutto quello che poteva essere per principio
alternativo alla coscienza religiosa da formarsi”35.
In effetti, la realizzazione di un’edizione italiana delle opere di Freud fu
tutt’altro che semplice, nella ricostruzione più volta fatta da Ranchetti, il
quale svolse un ruolo di primo piano dell’ideare, tradurre e diffondere la
psicoanalisi fuori dalle cerchie istituzionali. Come egli stesso ricorda, si
deve all’amicizia con Paolo Boringhieri, alla sua grande conoscenza del tedesco
e all’indifferenza di Musatti e della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) per
il progetto, che il primo volume – dei dodici che compongono questa edizione –
riuscì a vedere la luce nel 1966.
Altamente controverso è stato invece il progetto di mettere mano a una nuova
edizione, pubblicata sempre da Bollati Boringhieri ma condotta con criteri
diversi dalla prima, e molto attenta al contesto di relazioni professionali,
intellettuali e familiari di Freud. I primi volumi, usciti nel corso del 2005
sono stati al centro di un’aspra polemica, con strascichi giudiziari e animati
dibattiti sui quotidiani e sulle riviste specializzate. Com’era da immaginarsi,
una nuova edizione delle OSF, il cui fine è quello di rimettere in discussione
l’opera ormai canonizzata del Fondatore, non poteva che attirare l’ostilità
compatta della SPI e della principale traduttrice della versione precedente. Nel
corso del 2005 e 2006, quando i primi volumi curati da Ranchetti escono e pochi
giorni dopo vengono fatti ritirare dalla circolazione, le polemiche si
moltiplicano dentro e fuori le istituzioni per riversarsi sulla stampa e poco
dopo animare prese di posizioni assai nette ben rappresentate da due
pubblicazioni, uscite entrambe nel 150° anniversario della nascita di Freud. Il
fascicolo che la “Rivista di psicoanalisi”, organo ufficiale della SPI, dedica
al corpus freudiano, include contributi di cinque psicoanalisti, e un’intervista
a Renata Colorni sul problema delle traduzioni freudiane; tutti unanimi nella
condanna della nuova impresa di Bollati Boringhieri, di cui vengono sottolineati
soltanto sviste lessicali ed errori di impostazione generale. L’obiettivo è
soprattutto quello di riaffermare l‘autorità e il diritto di primogenitura di
Musatti e della SPI, con il risultato di considerare quello di Ranchetti (che
allora aveva 80 anni) quasi un péché de vieillesse36. Diverso è invece il tono del
numero speciale di “Psicoterapia e scienze umane”, che festeggia i quarant’anni
di attività aprendo un corposo fascicolo con una lunga intervista all’amico e
collaboratore di lunga data37. Ranchetti ripercorre ancora una volta i criteri e
gli eventi principali che fanno da sfondo alla prima edizione, di cui è stato un
protagonista indiscusso per la progettazione e i primi volumi, insieme
all’editore; cui occorre aggiungere il fondamentale contributo di Elvio Fachinelli, traduttore, insieme alla moglie Herma Trettl, de
L’interpretazione
dei sogni, e considerato da Ranchetti “il più grande psicoanalista italiano”38. Da
questa testimonianza, come anche dai numerosi saggi e interventi scritti
nell’arco di quarant’anni39, tra i punti di maggior conflitto con l’istituzione
psicoanalitica - di cui il confronto del 2006 è soltanto l’episodio culminante -
emerge la questione di come fare una storia della psicoanalisi: per Ranchetti,
si tratta di problematizzare quella che nei decenni è stata presentata come
un’epopea coerente e unitaria. Per gli esponenti della SPI che scrivono sul
corpus freudiano, è evidente che una ricostruzione storica è non solo priva di
interesse specifico per gli analisti, ma tutto sommato anche priva di incognite
di fondo, una volta apprese le nozioni fondamentali attraverso il lungo
apprendistato sotto il controllo dell’istituzione, e risolte le questioni
terminologiche con una accettazione della versione ufficiale consacrata nella
prima edizione delle OSF.
L’altro elemento che vede Ranchetti in contrasto con Musatti (e con la SPI)
riguarda la relazione, che è fondamentale in Freud, tra l’elemento teorico e
conoscitivo da un lato, e quello terapeutico dall’altro. Mentre nel fondatore
questi due momenti sono entrambi presenti, anche se non sempre distinguibili
l’uno dall’altro, secondo Ranchetti si è prodotta una visibile scissione tra i
due, con una prevalenza del secondo sul primo; e Musatti – aggiunge – “che è un
totale scettico delle possibilità conoscitive della psicoanalisi, le ha ridotte
ai minimi termini e ha puntato molto sul … valore terapeutico della psicoanalisi
stessa”40.
Infine, anche se soltanto un accenno può essere fatto in questa sede, non si può
tralasciare la questione – cruciale e delicatissima, che continua a tormentare
analisti e studiosi di Freud da varie generazioni – della traduzione del lessico
freudiano di base. La competenza di Ranchetti è su questo punto difficilmente
confutabile. La sua conoscenza delle tante sfumature di una lingua che amava
profondamente, in particolare attraverso i testi poetici più alti prodotti in
tedesco nell’ultimo secolo (Rilke e Celan, da lui tradotti), unita alla
conoscenza dello sfondo culturale austriaco su cui si muove Freud, lo pongono in
una posizione di assoluta autorità. Basti pensare ai contributi intorno alla
traduzione dei termini Affekte, Besetzung, Trieb41, e a quello sul giudizio. A
proposito di quest’ultimo, egli si sofferma ad esaminare la principale fonte
freudiana sul problema – la Critica del giudizio di Kant - e mostra in che modo
Kant ‘entri’ per così dire in Freud, ma ne venga anche in parte modificato. Qui,
inoltre, si trova anche una delle rare menzioni di Ranchetti su Lacan, che non è
mai stato tra i suoi riferimenti preferiti. Proprio intorno al rapporto tra
giudizio medico e giudizio morale non manca di rivolgere un ammirato e aperto
omaggio al francese: “Su di esso l’unica grande opera che io conosca è il
seminario di Lacan sull’etica”42.
4. L’etica nel presente: la scrittura di Benjamin
Dopo l’89 è soprattutto Benjamin, attraverso le
Tesi, a costituire una guida
nella lettura di quella realtà divenuta poco decifrabile; un mondo dove “‘il presente non sembra più corrispondere a nessuna forma di conoscibilità e non
appartiene a nessun sistema di misura”. In esso “tutto sembra svolgersi fuori
del tempo, o meglio, in un passato non più conoscibile anche se recente”. C’è
una non riconoscibilità tra passato e presente, anche se le figure del passato
rimangono come “figure assolutamente incomprensibili, veri mostri”43. Da queste
esigenze, tutte costruite intorno a una incessante e radicale interpellazione,
nasce la nuova edizione delle Tesi sulla filosofia della storia, corredata di
molti materiali inediti, che egli cura nel 1997 insieme a Gianfranco Bonola.
Qualche anno più tardi si sofferma ancora una volta a descrivere la congenialità
che prova per Benjamin, nonostante la difficoltà di una lingua che gli si
presenta subito dotata di insormontabili difficoltà: “non immediata, non
scorrevole”, “che respinge la traduzione”44. Al tempo stesso, sente fortissima
l’ammirazione per una prospettiva “di interrogazione assoluta, non precostituita
da competenze disciplinari”45. Quest’ultimo aspetto è sottolineato con forza come
un obiettivo che non risponde a uno scopo di carattere intellettuale o a una
vocazione, ma è dettato dalle circostanze; vale a dire dall’esclusione di
Benjamin dall’accademia, e naturalmente anche da una predisposizione che lo
porta a sviluppare una smisurata curiosità per gli argomenti più diversi e
disparati, e a scegliere di non avere un fine predisposto, convinto – osserva
Ranchetti – “che solo nella disponibilità nei confronti di ogni aspetto della
scrittura e della vita consistesse per lui il compito non eludibile, il suo
proprio”46.
È un testo squisitamente anticonsolatorio, che viene riproposto per “una
necessità non rinviabile di conoscere il presente, per quanto oscuro possa
essere e imprecise le forme di conoscenza, obsolete le categorie
interpretative”47. Come altri lettori delle Tesi, anche per Ranchetti è
indispensabile rilevarne il carattere profetico e a-sistematico. Esse sono
“dettate da una necessità di ripensamento, e insieme di sopravvivenza, prima che
si verifichino le condizioni della distruzione”48. La scrittura benjaminiana non
fa che sottolineare questi elementi; è allusiva e imprecisa ma “elaborata fino
al virtuosismo persino nel momento della confessione più disperata”. Benjamin
ricorre alle immagini e mescola generi e stili diversi per l’impossibilità di
dare una coerenza teoretica a una elaborazione dominata dall’urgenza del
momento49.
L’edizione delle Tesi è forse il libro di cui Ranchetti si mostra più
soddisfatto. Nato da un seminario svolto a Bologna, si tratta di un lavoro nel
quale ha potuto impegnarsi nella cura filologica e insieme in quella del
contesto. Non considera, infatti, che il prodotto finale costituisca in alcun
modo una interpretazione, esso è piuttosto “un’offerta di suggestioni”, tratte
da materiali diversi, tutti composti in periodi diversi da Benjamin stesso. Le
Tesi costituiscono “un risultato in un certo senso finale del pellegrinaggio di
Benjamin nel corso della sua breve vita, nei frammenti di conoscenza, di
filosofia e di teologia, che l’avevano condotto al pellegrinaggio,
all’itinerario e all’esodo da una storia che è diventata sempre più terrificante
e persecutoria”. Per Ranchetti le Tesi sono qualcosa di diverso da una semplice
edizione di testi; più che altro costituiscono “un controcanto alla sua opera
omnia, così ricche e disperse, secondo un’altra prospettiva: quella della fine”50.
Il risultato di questa attenzione al testo, unita alla totale adesione allo
spirito di cui è intriso, è una edizione esemplare per lo scrupolo con cui sono
stati raccolti e sistemati, accanto alla versione per così dire ‘di base e più
nota, i materiali preparatori delle Tesi - gli appunti provenienti dai
manoscritti sui Passagen-Werk , lemmi sparsi su argomenti affini, documenti
dalla cerchia degli amici (lettere con e tra Scholem, Adorno, Brecht, Ernst
Bloch). È un’edizione che non rispetta né quella canonica dei Gesammelte
Schriften, né alcun ordine strettamente cronologico. Scorrendolo, si ha
l’impressione di avere tra le mani qualcosa di assolutamente nuovo, uno
strumento straordinario per avvicinarsi al pensiero di un autore la cui
caratteristica principale, come osservano i curatori è quella di essere
“scrittore itinerante, figura per eccellenza del flâneur all’interno dei propri
testi”51.
5. Pratiche religiose e culturali
Nel periodo della piena maturità Ranchetti continuerà a condividere con un
gruppo di allievi e studiosi, spesso più giovani, il bisogno impellente di una
osservazione critica sul presente. Ragioni di carattere etico, religioso e
intellettuale incombono e trapelano da tutti gli scritti dell’ultimo decennio di
vita come obiettivi personali non differibili. Questa determinazione lucida e
tragicamente consapevole della necessità di denunciare i pericoli di un tempo
caratterizzato da una profonda involuzione politica e istituzionale, costituisce
ancora oggi un punto di riferimento per molti di coloro che un tempo avevano
avuto un’esperienza interna alla Chiesa e se ne erano poi allontanati nel corso
degli anni ’70, spesso seguendo l’ondata dei movimenti sociali e le prospettive
politiche marxiste, ma avevano conservato un forte attaccamento ai principi
cristiani. Nel secondo anniversario della morte il poeta e amico Ennio Abate ha
così riproposto in rete - in un blog intitolato La poesia e lo spirito - una
intervista fatta 5 anni prima a Ranchetti dopo la pubblicazione del suo libro
Non c’è più religione, nel quale lo studioso non risparmiava critiche severe
alle istituzioni ecclesiastiche, pur riaffermando i profondi vincoli personali
che lo legavano al cristianesimo52. Nel blog si accende un animato confronto al
quale partecipano, principalmente ma non solo, poeti e intellettuali interessati
a dibattere su questioni inerenti il rapporto tra religiosità, cultura,
politica, e società civile. Nel suo intervento, il curatore dei quattro volumi
degli scritti – Fabio Milana – osserva che in quel libro è evidente “quanto
interno sia l’Autore – almeno su un piano psicologico, che vuol dire insieme
affettivo e ragionativo – a quella Chiesa che nel libro demolisce. Qualunque
cosa ne dica e maledica, egli non può prescinderne. …in fondo io invidio e
ammiro la capacità di indignarsi e denunciare che Michele (praticamente unico)
ha conservato fino al suo ultimo giorno di vita, e che gli deriva appunto da
quella radicale appartenenz”53.
Nel dialogo con Abate sono ben compendiate le questioni che tormentano Ranchetti:
“c’è all’interno della professione di fede cattolica, cioè nella vita e nella
dottrina del cristianesimo, qualcosa che imponga il suo pervertimento?”. Si
chiede in seguito se “dalla lettura e rilettura del Vangelo emerga una
possibilità di comportamento anche civile”54. Certo non è questa l’indicazione che
proviene dalla Chiesa55; tutt’al più da alcuni pochi preti molto marginali (come
Turoldo, Balducci, De Piaz, don Milani, e qualche altro) i quali “sono rimasti
nella delusione di una struttura che non corrisponde al loro ideale”56. Non
riuscendo a individuare figure di riferimento magistrali all’interno
dell’istituzione religiosa, ma solo amici tra i disobbedienti come Ivan Illich,
Ranchetti spiega di essersi rivolto a due maestri ‘esterni’ - Wittgenstein e
Freud. Entrambi sono esemplari di una incessante messa in discussione a
prescindere o in aperto contrasto con i presupposti della tradizione. Nel primo
dei due trova una personalità aperta e disponibile a “un’interrogazione
assoluta”; qualcuno che cerca di capire “come stanno le cose, non facendole
dipendere da un precedente già detto, già pensato”57. Nel secondo intravede un
tentativo di ribaltare tutti i presupposti religiosi con l’intento di
rintracciare delle cause diverse da quelle riguardanti la presenza divina. Per
Freud, egli osserva, “ogni struttura causale, che è stata introdotta nella
giustificazione dell’esistenza, - viene sottoposta a un’interrogazione radicale.
Nell’ipotesi (che è riuscita solo in parte) di sostituire ad essa i vari nessi,
che sono diversi da quelli accettati nella tradizione filosofica o religiosa o
in altre tradizioni, compresa quella scientifica.” L’importanza di questa
prospettiva consiste quindi anche nel mettere in discussione i vari statuti
disciplinari, con l’intenzione di sostituirli con altri. Per Ranchetti,
purtroppo, la psicoanalisi, “non ce l’ha fatta. Però la domanda radicale che si
è posta è analoga a quella di Wittgenstein”58.
Nemico di ogni accostamento artificioso tra psicoanalisi e religione, Ranchetti
insiste invece proprio su una indispensabile sottolineatura della loro
diversità. Avvicinare l’una all’altra significherebbe, infatti, cancellare i
caratteri specifici e ineliminabili di ciascuna, piegando entrambe a un
accomodamento “disciplinare e pratico”59. Abolire le differenze tra le discipline
vuol dire considerarle tutte eguali, annullare proprio le ragioni fondamentali
della loro nascita e sviluppo. Al contrario, è bene mettere in risalto quanto il
progetto della psicoanalisi sia del tutto opposto a quello delle varie
confessioni religiose. Si tratta, in realtà, di “un progetto inverso, che tende
a sostituire la costruzione di una dottrina dei modi di Dio, una prassi di
liberazione dai falsi attributi, ad una storia della salvezza dei singoli
secondo il disegno di Dio, la storia di una conquista di sé da parte del
singolo, che avviene anche e forse soprattutto mediante il riconoscimento delle
relazioni causali, al di fuori di ogni progetto a lui esterno”60.
* * *
A conclusione dell’autoritratto offerto in Rifiuto d’ordine a profitto del
contesto, nel tentativo di tracciare un bilancio finale della propria opera,
sparsa in direzioni così svariate, Ranchetti tenta un’estrema definizione di sè:
“un outsider che interviene, non fa testo, e poi se ne va, ma non lascia tracce.
Naturalmente il contrario di quello che desidero. Ma come si fa a desiderare di
essere una traccia? Bisogna esserci…”61.
La lunga narrazione volge alla fine; l’ultima frase è pronunciata mentre è
seduto nel giardino della bella casa fiorentina, e si ripara dal sole con degli
occhiali scuri. Nel corso dei diversi momenti di rievocazione ha parlato senza
mai guardare la cinepresa, concentrato nello sforzo di superare la ritrosia a
parlare di sé e di mettere ordine nei ricordi – proprio lui che per tutta la
vita ha cercato di rifiutare come innaturale l’idea di sistemare ordinatamente
il lavoro della memoria e del pensiero. Soltanto allora, in un gesto che esprime
anche il sollievo per essersi come liberato temporaneamente dal peso di parlare
di una vita di cui si mostra così poco soddisfatto, allarga le braccia e si
concede un ampio bellissimo sorriso.
note
1. Per il riferimento al titolo cfr. l’ultima pagina di questo articolo.
2. Nel senso del Modernismo cattolico degli inizi del ’900. È questo il significato con cui l’espressione viene utilizzata in questo articolo.
3. Ne sono conferma i numerosi interventi e testimonianze in occasione della morte e nei recenti anniversari, come è facile intuire digitando il nome di Ranchetti su ‘google’.
4. Per un profilo biografico cfr. Fabio Milana, Michele Ranchetti. Notizia biografica, in Michele Ranchetti, Scritti diversi, IV. Ulteriori e ultimi (2000-2008), a cura di Fabio Milana, Roma, edizioni di storia e letteratura, 2010, pp. 273-279. La pubblicazione di questo IV volume degli scritti è accompagnata da una bella e lunga intervista, un vero e proprio bio-film su DVD curato da Stefano Franchini: Rifiuto d’ordine a profitto del contesto. Michele Ranchetti si racconta, Firenze, 23 ottobre 2005. Il titolo riprende alcuni versi tratti dalla raccolta poetica di Ranchetti La mente musicale: “Quante rovine sull’aia: travi,/ tralicci, scale, porte, finestre, orci./ Rifiuto d’ordine a profitto / del contesto – puoi tu trovare simili per te arnesi / ad indicare chi tu sei?”. Le citazioni prese da questa intervista, suddivisa in capitoli corrispondenti alle fasi diverse di vita e ai temi di studio e lavoro, verranno in seguito indicate come DVD Rifiuto d’ordine, seguite dalla denominazione del capitolo data dai curatori del DVD.
5. Si veda il ricordo di questo incontro in occasione di un seminario del 1995 su Fortini, in Michele Ranchetti, Franco Fortini esorcista, in ID., Scritti diversi cit., II, pp. 233-238, p. 234.
6. Anima e paura. Studi in onore di Michele Ranchetti, a cura di Bruna Bocchini Camaiani e Anna Scattigno, Macerata, Quodlibet, 1998. Il volume raccoglie 36 contributi, tra i quali sono inclusi scritti di filosofi, psicanalisti, poeti, studiosi di Benjamin, Foucault, Lacan, Freud, Wittgenstein - come Agamben e Bonola, Marchetti, Contri, Grubrich-Simitis, Nedo; scrittori e artisti come Mengaldo e Tadini; teologi, religiosi e storici delle religioni come Turbanti, Miegge, Lettieri, Pierre Riches, De Piaz.
7. Michele Ranchetti, Cultura e riforma religiosa nella storia del modernismo, Torino, Einaudi, 1963; trad. ingl. The Catholic Modernists. A Study of the Religious Reform movement 1904-1907, London, Oxford University Press, 1969.
8. Michele Ranchetti, Scritti diversi, 4 voll. a cura di Fabio Milana, Roma, edizioni di storia e letteratura. Vol. 1, Etica del testo, ivi, 1999; vol. II, Chiesa cattolica ed esperienza religiosa, ivi, 1999; vol. III, Lo spettro della psicoanalisi, ivi, 2000; IV, Ulteriori e ultimi (2000-2008) cit. Una bibliografia aggiornata al 2010 si trova in appendice al volume IV degli Scritti diversi cit., pp. 281-296.
9. Michele Ranchetti, Scritti in figure, Roma, edizioni di storia e letteratura, 2002.
10. Michele Ranchetti, Über sich selbst , in “Lea”, n.1, 2004, pp. 36-44, e ora in ID., Scritti diversi cit., IV, pp. 266-271..
11. Michele Ranchetti, Verbale, Milano, Garzanti, 2001.
12. Quando racconta dei primi passi compiuti per trovare una collocazione professionale, negli anni ’50 e primi anni ’60, diviso com’è tra collaborazione editoriale e università, aggiunge - quasi fosse un dato su cui non desidera soffermarsi - che nel frattempo si era sposato e aveva tre figli.
13. Michele Ranchetti, Über sich selbst, in “Lea”, n. 1, 2004, pp. 36-44; ora in ID., Scritti diversi cit., IV, pp. 266-271.
14. Michele Ranchetti, Verbale, Milano, Garzanti, 2001, p. 28 e 58 rispettivamente.
15. Cfr. Ludwig Wittgenstein. Sein Leben in Bildern und Texten, Frankfurt, Suhrkamp, 1983, composta insieme a Michael Nedo.
16. Cfr. Michel de Certeau, Politica e mistica, Milano, Jaca Book, 1975. Ranchetti ha inoltre curato l’edizione italiana degli scritti raccolti in Michel de Certeau, Storia e psicoanalisi. Tra scienza e finzione, Torino, Bollati Boringhieri, 2006, per la quale scrive una Prefazione, ivi, pp. 9-13. Questo contributo è stato poi ripubblicato con il titolo di De Certeau, esercizi éclatéss, in Ranchetti, Scritti diversi cit., IV, pp. 116-121. Trattasi dell’intervento letto a un seminario su Certeau da me organizzato presso il Centro Internazionale di Semiotica dell’Università di Urbino nel luglio 2003.
17. Per i riferimenti a questi lavori cfr. la nota 8 supra.
18. Michele Ranchetti, Introduzione a Ludwig Wittgenstein, Movimenti del pensiero. Diari 1930-1932, 1936-1937, Quodlibet, Macerata, 1999, in ID. Scritti diversi cit., I, pp. 243-248, p. 244. Egli ha inoltre curato e introdotto le edizioni italiane degli scritti di Wittgenstein Lezioni e conversazioni sull’etica, l’estetica, e la psicologia, la credenza religiosa, Milano, Adelphi, 1967 e i Pensieri diversi, ivi, 1980.
19. Michele Ranchetti, Prefazione a Ray Monk, Wittgentsein. Il dovere del genio, Milano, Adelphi, 1990, in ID., Scritti diversi cit., I, pp. 171-177, p. 176. Si veda in particolare Fabio Milana, Incontro con Ranchetti, in “Bailamme: rivista di spiritualità e politica”, vol. 11-12, 1992, pp. 293-252.
20. Cfr. nel DVD Rifiuto d’ordine cit., capitolo su Wittgenstein. Marino Rosso, che attualmente insegna Filosofia del linguaggio all’università di Firenze, studioso e traduttore di Husserl, , del filosofo austriaco aveva curato le Osservazioni filosofiche, Torino, Einaudi, 1976.
21. Michele Ranchetti, Carattere e destinazione degli scritti di Wittgenstein secondo Wittgenstein, in ID., Scritti diversi cit., IV, pp. 13-21. Si tratta di un contributo scritto per un convegno sulla cultura austriaca negli anni ’30.
22. Ivi, p. 16.
23. Ivi, p. 15.
24. Ivi, p. 16.
25. Ivi.
26. Ivi, p. 17.
27. Ivi. Il brano prosegue: “Ancora più grave, però, il fatto che le partizioni operate dai tre hanno tolto agli scritti di Wittgenstein il carattere di testo unico, di riflessione perenne non ordinata e non ordinabile. E inoltre, conseguenza non percepita, anzi esaltata dalla Anscombe, hanno isolato la figura di Wittgenstein dal contesto della sua vita. Così Wittgenstein è divenuto l’autore di alcuni libri mai scritti, di un insegnamento in lingua inglese non trascritto, di due dettati in inglese all’interno di questo insegnamento, di alcune lettere. Oltre che del Tractatus, naturalmente, ma al di fuori dei tempi e dei luoghi, della sua lingua, e soprattutto delle sue ‘tremende’ decisioni di vita, quasi considerate come cesure nella sua produzione filosofica, intervalli ‘esistenziali’ di crisi vagamente mistiche…”.
28. Michele Ranchetti, Una vita bellissima, in ID. Scritti diversi cit., I, pp. 171-177, p. 174.
29. Michele Ranchetti, Un’introduzione a Freud, in ID., Scritti diversi cit., IV, pp. 222-231, p. 228. Si tratta di uno scritto del 2006.
30. Michel David, La psicanalisi nella cultura italiana, Torino, Bollati Boringhieri, 1966; 3a. ediz. riveduta e ampliata, ivi, 1990. Di grande interesse per ripercorrere gli inizi di una diffusione della psicoanalisi in Italia, è l’intervista di Carlo Viganò a Pier Francesco Galli, direttore della rivista “Psicoterapia e scienze umane”, pubblicata nel 1984 nella rivista lacaniana “Freudiana”, vol. 4, 1984, pp.109-111; è consultabile in rete all’indirizzo www.psychomedia.it/pm/modther/probpsiter/galli84.htm.
31. Per l’Argentina cfr. Hugo Vezzetti, Aventuras de Freud en el país de los argentinos. De José Ingenieros a Enrique Pichon-Rivière, Buenos Aires, Paidós, 1996; v. anche Mariano Plotkin, Freud en las pampas. Orígenes y desarrollo de una cultura psicoanalítica en la Argentina (1910-1983), Buenos Aires, Sudamericana, 2001. Per la Germania il riferimento principale sono gli studi di Ilse Gubrich-Simitis, amica di Ranchetti, con il quale condivideva l’idea di indagare criticamente e filologicamente l’opera di Freud,, e non solo di curarne la monumentalizzazione; v. in particolare Zuruch zu Freuds Texten: Stumme Dokumente sprechen machen, Frankfurt am Main, Fischer, 1993. Per l’Inghilterra, mi limito a segnalare lo studio a cura di Gregorio Kohon, The British School of Psychoanalysis: the Independent Tradition, London, Free Association Books, 1986, e The Freud-Klein Controversies, 1941-45, a cura di Pearl King e Riccardo Steiner, London, Routledge, 1991.
32. Cfr. in particolare i saggi raccolti negli Scritti diversi III dedicati a Lo spettro della psicanalisi cit., e anche nella Parte Terza del vol. IV cit.
33. Michele Ranchetti, Il movimento psicoanalitico: una storia difficile, in ID. Scritti diversi cit., III, pp. 125-142, p. 127. Pubblicato originariamente in tedesco nel 1994. Si veda anche il contributo a proposito del libro di Manfred Pohlen sulla propria analisi con Freud, Un’analisi con Freud, in Scritti diversi cit., IV, pp. 247-253.
34. Ivi, p. 134.
35. Freud: leggere, tradurre, pubblicare, in Scritti diversi IV, pp. 254-260. In queste pagine, scritte in occasione di un convegno per il 150° anniversario della nascita di Freud, Ranchetti ricorda come ancora nel 1967 a Firenze, Freud era quasi del tutto sconosciuto.
36. Cfr. “Rivista di psicoanalisi”, n.1, gennaio-marzo 2006, Centocinquant’anni di Freud: il corpus freudiano. Il progetto di Ranchetti è criticato senza mezzi termini dall’allievo di Musatti, Rodolfo Reichmann, Musatti e le opere di Freud (con un’intervista a Renata Colorni), ivi, pp. 129-148, e da Antonio Alberto Semi, È sufficiente tradurre (bene) Freud?, ivi, pp. 177-188.
37. Cfr. Roberta Pisa & Giovanni Viani, Conversazione con Michele Ranchetti, in “Psicoterapia e scienze umane”, n.3, 2006, pp. 311-328.
38. Così nel DVD Rifiuto d’ordine, capitolo Università e Freud.
39. Il rinvio principale è al vol. III Lo spettro della psicoanalisi, degli Scritti diversi cit., dove sono riuniti i principali contributi composti nell’arco di vent’anni, dal 1980 al 2000.
40. Cfr. Roberta Pisa & Giovanni Viani, Conversazione con Michele Ranchetti cit., p. 316-317. In diverse occasioni Ranchetti ha richiamato l’attenzione sul fatto che Musatti “non aveva nessuna voglia di fare le opere di Freud, non lo riteneva necessario. Era una persona estremamente intelligente. Aveva studiato a fondo la psicoanalisi ma non la riteneva una visione del mondo, una rivoluzione che avesse dato un contributo radicale. Queste per lui erano solo illusioni. Anche se non lo ha mai detto esplicitamente, riteneva che il suo Trattato di psicoanalisi avesse detto tutto e che forse Freud lo si poteva studiare tramite un manuale, invece che con una lettura diretta.” In. Freud: leggere, tradurre, pubblicare, Ranchetti, Scritti diversi cit., IV, p.257.
41. Michele Ranchetti, Affetti, in ID., Scritti diversi, III, pp. 83-94. Questo saggio era originariamente apparso su “Il piccolo Hans”, 55, 1987.
42. Michele Ranchetti, Freud: Giudizio, ivi, pp. 95-106. Si tratta di un contributo inedito del 1988, nel quale risuona molto chiaramente la riflessione di Michel de Certeau in Lacan: un’etica della parola, incluso nel volume curato da Ranchetti stesso, Storia e psicoanalisi cit., alla nota 16.
43. Michele Ranchetti, Un presente ibrido e indecifrabile, in “il Manifesto”, 22 giugno 1995. Ristampato con il titolo In morte dell’ermeneutica, in ID., Scritti diversi cit., I, pp. 383-387.
44. Michel Ranchetti, Leggere Benjamin, in ID. Scritti diversi cit., IV, pp. 27-32, p. 27. Si tratta di un contributo del 2002.
45. Ivi, p. 30.
46. Ivi, p. 29. E poco oltre, a p. 30, riprende l’espressione da lui prediletta (“l’interrogazione assoluta”), per sgomberare il campo dagli equivoci di un Benjamin facilmente imitabile, che chiunque può riprendere e ripetere, fraintendendone completamente le intenzioni: “Di questa prospettiva di interrogazione assoluta, non precostituita da competenze disciplinari (erano proprio queste competenze ad essere messe in dubbio) a me sembra che Benjamin sia l’esponente più autentico, ed è forse per questo carattere della sua figura che io ho creduto di avvertire la congenialità che ho indicato come la seconda difficoltà incontrata nel leggere Benjamin. Infatti il simile induce all’imitazione e non al confronto. E credo che siano in molti coloro che, letta una riga di Benjamin, in particolare un passo dei frammenti del Passagenwerk, si siano sentiti autorizzati a mettersi in cammino con lui, a passeggiare per Parigi o Poggibonsi, e a raccogliere materiali per una nuova fenomenologia dei detriti. Ma a me sembra che essi forse abbiano frainteso l’intenzione che presiedeva il percorso solo in apparenza itinerante di Benjamin: la necessità di costruire un ordine, e non di valersi, di appropriarsi e di usufruire del disordine.”
47. Gianfranco Bonola e Michele Ranchetti, Introduzione a Walter Benjamin, Sul concetto di storia, a cura di Gianfranco Bonola e M.R., Einaudi, Torino, 1997, pp. VII-X, p. X, ripubblicato con il titolo di Walter Benjamin. Prima della fine in Michele Ranchetti, Scritti diversi cit., I, pp. 237-241, p. 240.
48. Ivi, p. 239.
49. Ivi, p. 240.
50. Gianfranco Bonola e Michele Ranchetti, Introduzione a Walter Benjamin, Sul concetto di storia cit., p. VIII.
51. Ivi, p. 72.
52. Michele Ranchetti, Non c’è più religione. Istituzione e verità nel cattolicesimo italiano del Novecento, 2003. Nel libro, che raccoglie scritti diversi, è incluso un intervento di critica radicale alle istituzioni ecclesiastiche apparso su “La rivista del Manifesto”, n.10, ottobre 2000, in cui non si risparmiavano giudizi netti anche intorno al silenzio della Chiesa durante gli anni del nazismo. Cfr. Prevalebunt, ora in Michele Ranchetti, Scritti diversi, IV. Ulteriori e ultimi (2000-20008) cit., pp. 172-181. Sui politici formatisi all’Università Cattolica di padre Gemelli, che sarebbero poi diventati esponenti di spicco nei governi del dopoguerra, scrive: “Quei ministri, dunque, avevano garantito la continuità di quella Chiesa fascista e certo non antinazista, che non aveva mai rotto con il fascismo prima e durante la guerra, che non aveva mai creduto di pronunciare una condanna chiara e limpida dei crimini commessi dalle due dittature. Che, durante l’Olocausto, di cui era perfettamente a conoscenza, era stata zitta, forse giudicando che il suo silenzio fosse infallibile”. (ivi, p. 176)
53. Cfr. www.lapoesiaelospirito.wordpress.com. Il dibattito appare nel blog il 2 febbraio 2010.
54. L’intervista è consultabile nel sito di Poliscritture. Laboratorio di ricerca e cultura critica, www.poliscritture.it.
55. Osserva Ranchetti: “L’istituzione cattolica che si riferisce al Vangelo è evidentemente una perversione del Vangelo. Si può, quindi, e si deve disobbedire ad essa, perché ti dice di votare per Berlusconi in quanto uomo di fede, e non è vero.” (ivi). Conviene ricordare – e sorprende il fatto che Abate non menzioni questa circostanza – che l’intervista in questione ha avuto luogo il 13 maggio 2005, vale a dire pochi giorni dopo l’insediamento del Terzo governo Berlusconi (rimasto in carica dall’aprile 2005 al maggio 2006), succeduto al Berlusconi II, durato dal giugno 2001 all’aprile 2005.
56. Ivi. V. anche gli articoli che Ranchetti scrive su alcuni di essi in diverse occasioni: David Turoldo, Servo della Parola, in Scritti diversi cit., II, pp. 109-112 (del 1992); Discutendo di don Milani, (1997), ivi, pp.135-150; Balducci scrittore e predicatore, (1998), ivi, 151-162; Corsia dei Servi, (2008), in Scritti diversi cit., IV, pp. 186-189.
57. “Wittgenstein per me non è tanto l’autore di una dottrina filosofica, ma un modello di pensiero. Non una filosofia, ma un personaggio filosofico, l’ultimo esponente di una vita filosofica, di una coincidenza tra vita e filosofia”; con queste parole si apre il saggio/dialogo dedicato a Ranchetti da Fabio Milana, Poesie della mano sinistra, in “Bailamme: rivista di spiritualità e politica” cit., pp. 305-352, p. 305 . V. anche il bel ritratto di Witttgenstein tratteggiato in occasione della pubblicazione di alcuni inediti, in Ludwig Wittgenstein, Frammenti di Diario, presentazione di Michele Ranchetti, in “Micromega”, n.1, 1998, pp. 233-245.
58. Intervista a Michele Ranchetti di Ennio Abate cit. Sono conclusioni cui giungono oggigiorno anche psicoanalisti critici come Massimo Recalcati. Si veda l’introduzione al recente L’uomo senza inconscio. Figure della nuova clinica psicoanalitica, Milano, Raffaello Cortina, 2010, pp. IX-XVI.
59. Cfr. Michel Ranchetti, Psicoanalisi o religione, in ID. Scritti diversi, IV Ulteriori e ultimi (2000-2008) cit., pp. 211-214.
60. Ivi, p. 213.
61. DVD Rifiuto d’ordine a profitto del contesto cit. ultimo capitolo, Lavori recenti.
24 giugno 2010
home>interventi/interviste> “un outsider che interviene, non fa testo, e poi se ne va…”: Michele Ranchetti (1925-2008)