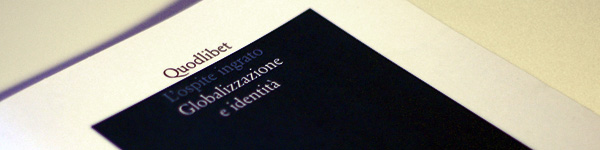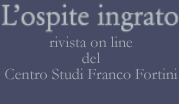home>interventi/interviste> La politica trasformata. La politica riformata
La politica trasformata. La politica riformata
Gabriele Licciardi*
L’impopolarità dei partiti italiani è ai massimi storici: l’antipartitismo è il
corollario essenziale dell’antipolitica che scuote il paese. Il fenomeno in sé
ha una portata che va oltre il caso italiano. E si manifesta nel declino
inarrestabile della militanza e dell’identificazione di partito. I cittadini
sembrano usciti irreversibilmente da un secolare rapporto coi partiti e questi
ultimi si rifugiano nei loro santuari autoreferenziali e nei loro privilegi
castali. L’ipotesi che in queste brevi note si vuole proporre è che una volta
venuta meno la forza ideologica intrisa nella democrazia dei partiti, la stessa
ha subito un processo di destrutturazione profondo e incontrastato che ha
portato il nostro paese a rifondare il suo sistema politico, quindi partitico e
ideologico, secondo i pilastri teorici del neoliberismo. Questo processo non è
avvenuto attraverso la strutturazione di nuovi cleaveges, bensì attraverso
procedure e schemi di formazione del regime democratico, perseguiti tanto a
destra quanto a sinistra, che hanno eliminato qualsiasi elemento di
identificazione e di differenziazione fra i blocchi contrapposti. Tutto questo
ha prodotto una sempre più insistente domanda di semplificazione dei meccanismi
decisionali, esigenza che nel campo della politica si è trasformata in una
spiccata voglia di bipolarismo, con una conseguente reductio ad duem
delle conflittualità.
La semplificazione dell’offerta politica ha fatto si che,
superati gli antichi motivi di divisione del corpo elettorale, motivi di classe
e motivi religiosi, nuovi items sono stati introdotti nel discorso
politico, items su cui tanto l’elettorato, quanto la rappresentanza
parlamentare, tende ad uniformarsi annullando ogni distinguo, ogni frattura,
ogni specifica identificazione sociale. Il riformismo è ormai diventato il nuovo
orizzonte all’interno del quale collocare ogni azione di governo. A destra come
a sinistra troviamo il partito dei riformisti. Tavoli di volenterosi, che
baipassando lo schieramento di appartenenza, proliferano attorno ad un nuovo
progetto riformatore per lo stato. In nome del riformismo si è privatizzato il
capitalismo statale, in nome del riformismo si cerca ora di privatizzare beni di
prima necessità come l’acqua, l’istruzione, il diritto alla salute. Se la
domanda di semplificazione ha trovato nel riformismo il canone culturale
opportuno, la riforma istituzionale è il tema principale che tanto i governi di
destra, quanto quelli di sinistra hanno come priorità assoluta nelle loro
agende. Lo strumento per regolare un sistema bipolare è la legge elettorale di
tipo maggioritario, che dopo una breve parentesi nelle trascorse elezioni
politiche, da tutte le parti, con qualche gradita eccezione, viene invocato come
un passo obbligato verso la stabilizzazione del sistema. La fondazione di una
nuova identità nazionale passa dunque dal radicale abbandono di quel patto
fondativo che è la Costituzione italiana, o almeno da una sua profonda
ridefinizione1.
Tutto questo
si accompagna a una radicale trasformazione del concetto di partito, non più
strumento di sintesi dei conflitti sociali, di rappresentanza delle fratture di
classe, ma più semplicemente, mezzo per intercettare un elettorato, adesso molto
più mobile, rinunciando in ogni modo alla trasformazione dello stesso. Da tempo
i partiti – in particolare quelli della sinistra, nati per rimodellare la
società in base a idee di giustizia e di uguaglianza – hanno rinunciato al
compito di cambiare le preferenze dei cittadini. Il problema non è di
modificarle secondo un progetto di società ma solo di riconoscerle nella loro
contingenza per intercettarle e rappresentarle così come si presentano. Ecco
perché il militante non ha più motivo d’esistere, ecco perché non serve più un
partito pesante, fatto di sezioni, di quadri di partito, di militanza
quotidiana. Il riformismo infra-partitico ha scompaginato il criterio di
identificazione in un partito, per affidarsi al lifting dei mass-media: sembra
che proprio lì si decida la partita per il consenso, a nostro avviso
grossolanamente artificiale2.
Il ruolo dei partiti nella
prima repubblica
I modelli
elaborati dalla politologia italiana, già a partire dagli anni settanta, avevano
sviluppato una forte capacità di spiegazione in merito all’evoluzione del
modello democratico del paese. Partendo da Giorgio Galli con il suo
Bipartitismo imperfetto3,
edito nel 1972, passando per il Pluralismo polarizzato di Giovanni
Sartori4 dato alle stampe nel 1982, siamo arrivati al Pluralismo centripeto
teorizzato nel 1983 da Paolo Farneti5.
Questi sono stati i tre paradigmi di riferimento che la scienza politica
italiana ha prodotto per spiegare un sistema italiano, sicuramente anomalo se
pensiamo alla sostanza della democrazia prodotta, ma sicuramente in grado di
garantire progresso e sicurezza economica6.
Tutte le teorie esplicative proposte fino a questo punto, di colpo sono state
annullate da quanto è successo fra la fine degli anni settanta e gli anni
ottanta.
Fino al
crollo delle ideologie classiche il paese era diviso secondo precise
appartenenze, strutturate e fortificate nel corso di tre lunghi e tormentati
decenni. Ma erano gli stessi partiti, che se in un primo momento dividevano,
subito dopo riunivano, proponendo l’azione politica come strumento di
ricomposizione dei conflitti, all’interno di un viatico di fortificazione della
democrazia rappresentativa7.
Se la Democrazia cristiana dava una veste democratica a quelle correnti di
opinione e forze sociali che si erano ben strutturate sotto il regime fascista8,
spostandole su un terreno di confronto parlamentare, dove spesso i diversi
diventavano compatibili, la stessa azione sul fronte opposto veniva
costantemente condotta dal Partito comunista che, sin da subito, si era
impegnato a declinare ogni tendenza rivoluzionaria del movimento di Lotta di
Liberazione nazionale, tessendo un discorso che trovava nell’accettazione della
democrazia parlamentare il nucleo dell’azione politica, discorso reso
irrimediabilmente chiaro da Berlinguer nel novembre ’77 parlando a Mosca in
occasione del sessantesimo anniversario della Rivoluzione d’Ottobre, quando
definì la democrazia valore universale. Questa inconciliabile antitesi
rappresentava una antidoto valido alle anomalie della nostra democrazia. Se da
un lato i partiti creavano fratture nella società, un attimo dopo, gli stessi,
ricomponevano interessi e idealità, su versanti opposti, assicurando lo sviluppo
interno del paese, quindi una costante strutturazione dell’habitus
democratico. La scena era occupata dal partito, all’interno del quale la
leadership, era una polarità individuale che si irradiava sulla struttura
partitica, che a sua volta ne traeva vantaggio. De Gasperi incarnava la dottrina
sociale della chiesa, un cattolicesimo liberale che faceva i conti con il suo
passato contiguo al fascismo. A sua volta Palmiro Togliatti, “Il Migliore”,
riassumeva la carica tragica dello spirito rivoluzionario, un leader
carismatico, ma che espletava le sue funzioni all’interno delle regole del
centralismo democratico9.
La
repubblica dei partiti che, come ha abilmente spiegato Alfio Mastropaolo, si
reggeva sul principio dell’arco10,
ovvero un sistema democratico che si fondava su due opposti sostegni, ha subito,
contemporaneamente alla crisi del sistema dei partiti, un feroce attacco, che ha
riassunto quarant’anni di democrazia sotto la categoria di consociativismo,
categoria interpretativa che è stata formalizzata nella maniera più raffinata da
Alessandro Pizzorno in Le radici della politica assoluta nel 199411.
A nostro avviso il consociativismo è stato per molti lo strumento principale di
delegittimazione dei partiti, in un momento in cui, gli stessi, non hanno saputo
gestire la trasformazione che l’opinione pubblica gli chiedeva. Ma ad una
analisi più attenta ci accorgiamo che solo dal 1975 in poi l’opposizione
comunista è riuscita, nelle sedi istituzionali, ad adoperare un consistente
potere di interdizione. Amministrando comuni, province e regioni il PCI è
riuscito a strutturare un’azione di condizionamento che gli ha permesso di
accedere alle risorse di governo, ma sempre in posizione subordinata rispetto
alle forze di maggioranza governativa. Le vere consociazioni vanno fatte
risalire agli anni ottanta, quando DC e PSI, approfittando di un declino del
nemico interno12,
hanno eretto nuove barriere a rafforzare la rinnovata conventio ad
excludendum, salvo poi concedere lauti compensi, non tanto per neutralizzare
un’opposizione sociale ormai fortemente ridotta, quanto per ottenere un clima
collaborativo dall’opposizione nei ranghi istituzionali.
Ma una volta
esauritasi quell’eterogenesi dei fini che l’antitesi, con il tempo
diventata sempre più conciliabile, aveva sapientemente costruito lungo gli anni
della repubblica, nessuno si impegnava, nel frattempo, a cercare la soluzioni
alle distorsioni che il sistema aveva comunque prodotto. La politica iniziava a
perdere la sua capacità di incidere sui bisogni sociali, diventando un corpo
separato dal suo elettorato, autoreferenziale e autocelebrativo, poco incline ad
una riconversione dei motivi che l’avevano portata troppo lontano dalla
ricomposizione dei numerosi conflitti sociali che in tutta Italia, proprio in
quegli anni, avevano trovato terreno fertile.
Il passo dal
paradigma dell’incompiutezza a quello del degrado è stato breve13
14.
A rompersi è stato proprio il compromesso keynesiano – socialdemocratico,
declinato come sviluppo e garanzie sociali, compromesso che è entrato in crisi
per la conversione occidentale alle teorie neoliberiste che dagli anni ottanta
si sono profondamente radicate anche in Italia. Deindustrializzazione, voglia
di sicurezza e flessibilità sono nel frattempo diventate le parole d’ordine
della svolta a destra che si è consumata nell’ultimo ventennio.
Il pregiudizio dualistico
Com’è
ampiamente dimostrato da una vasta letteratura socio – politica, uno degli
stereotipi che ha caratterizzato, e che continua a farlo, l’interpretazione dei
regimi rappresentativi ammette nella divisione in due della rappresentatività
politica una sua necessità costante15.
Tutti i regimi rappresentativi divengono in questo modo succubi di un ostinato
pregiudizio dualistico. Da sempre i regimi parlamentari hanno rappresentato una
leva importante per la conduzione e l’indirizzo del conflitto sociale, tanto
meglio se questo perde molta della sua complessità riducendosi ad una
raffigurazione duale. L’operazione diventa ancor più mistificante quando la
reductio ad duem viene strutturata in un sistema dove la complessità del
sistema dei partiti diventa il motivo detonante della stessa. Se noi proviamo a
guardare la storia della nostra repubblica, cercando di allontanarci dalla
logica del nemico interno, potremmo benissimo accorgerci di come una
formula tanto discussa e tanto delegittimata come il centrismo, ha dettato i
tempi e i modi di un quasi perfetto apprendistato per quelle forze definite
antisistema, ma che negli anni recenti hanno dato prova delle loro capacità di
governo. Per circa quarant’anni, se la retorica del discorso pubblico si è
caratterizzata per un acceso anticomunismo, e quindi per una rappresentazione
duale dello scontro, la realtà della composizione dell’area di governo aveva,
nella formula centrista, la sua manifestazione più forte di come fosse possibile
governare un paese evitandone la semplificazione del sistema, quindi della
domanda e dell’offerta politica. Con un sistema elettorale di tipo
proporzionale, e con la DC sempre perno centrale di ogni compagine di governo,
l’Italia riusciva a sostenere le sfide che i funambolici processi di
modernizzazione le metteva innanzi. È chiaro come per centrismo non ci riferiamo
strettamente a quello degasperiamo, ma alla formula che ha dettato la struttura
di governo nel modello italiano, ovvero con l’entrata nell’area di governo nel
1960 del PSI di Nenni, e, dopo il 1973, con il tentativo fatto da Berlinguer
nella proposizione del compromesso storico. Quindi un centrismo che polarizzava
verso l’area dell’elettorato moderato anche i partiti di sinistra.
Tutti gli
anni ottanta sono denotati da una forte polemica che traduce l’incapacità da
parte dei partiti di leggere la trasformazione in atto. Attraverso un discorso
antipolitico l’oggetto centrale della critica diventava la democrazia e le
regole del suo funzionamento. Al sistema italiano veniva rimproverato un eccesso
di democrazia, secondo il canone classico delle teorie conservatrici della
crisi, troppi pesi e contrappesi per una democrazia che, essendo ormai matura,
aveva necessità di un maggiore decisionismo e di uscire dal pantano
parlamentare. L’Italia repubblicana era nata come una democrazia consensuale, e
come tale era divenuta una delle maggiori potenze economiche mondiali, con un
sistema democratico ormai consolidato, con una maggioranza plurale ed una
opposizione monocolore, che avevano istaurato a pieno titolo il dialogo
istituzionale come metodo di confronto, e l’urna elettorale come arma di
condizionamento. Ma tutto questo non bastava a chi auspicava un cambio di
maggioranza, e visto che dalle urne era chiaro che in Italia una maggioranza di
sinistra non era possibile averla, tanto vale cercare di cambiare le regole del
gioco, riscriverle. Questo è ampiamente raccontato nelle pagine di MondOperaio16,
l’organo di dibattito ufficiale del PSI. Su quelle pagine Giuliano Amato
lanciava l’anatema contro la repubblica dei partiti, istituendo la possibilità
di un sistema leaderistico con l’elezione diretta del capo dello stato,
operazione di totale revisione che veniva compiuta con la campagna referendaria
di Segni, dove veniva abolita la proporzionale e istituito un sistema
maggioritario. La riduzione della complessità del conflitto, nel momento in cui
questo esplode, diventa la prima necessità. E per provvedere ad un cambiamento
radicale degli strumenti di governo, gli elementi necessari sono sempre uguali,
un forte movimento della società civile, una buona dose di retorica antipolitica
e un bersaglio facile da attaccare. In quel momento era cosa molto semplice
delegittimare la democrazia come sistema, nel momento in cui forse le storture
maggiori potevano essere corrette, ma dall’interno, e la convergenza
programmatica fra i partiti lo testimoniava, basta pensare all’accettazione da
parte del PCI dell’adesione dell’Italia alla Nato, mentre il modello
socialdemocratico veniva da tutti non solo condiviso ma anche attuato. Con una
DC logora e un PCI che aveva abbandonato la prospettiva del socialismo, il
ricambio, la democrazia dell’alternanza era quasi pronta. Ma all’alternanza è
stata preferita l’alternativa, o comunisti o anticomunisti, o statali o privati,
o onesti o evasori e potremmo continuare a lungo sulle numerose esemplificazioni
che la retorica della crisi ha sviluppato. Con la caduta del muro di Berlino
anche il PCI accelerava i processi di mutazione interna, e si sbrigava a
cambiare nome e simbolo, per cercare di riciclare il suo potenziale elettorale,
come tutti gli altri partiti, attorno al modello neoliberale, con ruolo di
freno, inizialmente, e edulcorando, via via, le pretese di chiara estrazione
socialista, si adoperava con sempre più convinzione come ammortizzatore della
protesta sociale, mancando, comunque, di una prospettiva ideale diversa da
quella antagonista. In buona sostanza destra, sinistra e centro, dagli anni
ottanta in poi iniziavano un percorso comune di convergenze nell’intento
dichiarato di seppellire la prima repubblica, quindi sul potenziamento
dell’esecutivo rispetto ai partiti e all’assemblea. Sarebbe però ingeneroso
mettere sullo stesso piano la politica plebiscitaria seguita nell’ultimo
quindicennio dal centro – destra, e le acquiescenze del centro sinistra. Se per
i primi il modello bipolare è il volano per meglio guidare lo scontro e pilotare
l’opinione pubblica, con la facilità che ne consegue nell’individuare il nemico
nel fantomatico comunismo statalista, per il centro sinistra la divisione netta
in poli contrapposti ha forse rappresentato l’occasione giusta per migliorare un
sistema asfittico. Ad una bipolarizzazione delle ragioni della politica doveva
affiancarsi lo strumento per il riordino del sistema dei partiti. Per una lunga
ed intensa stagione il maggioritario ha rappresentato il tabù imprescindibile
della nuova Italia, il simbolo della discontinuità nei confronti dell’assemblearismo
parlamentare. È stato, e per motivi diversi rimane, il mito fondatore della
rinascita della politica del paese, anche se poi alla prova dei fatti la
palingenesi collettiva, fatta balenare nelle infuocate campagne referendarie, si
è rivelata ben poca cosa17.
Ma ancora una volta è questa la strada perseguita dal ceto politico italiano,
indistintamente, si continua a ragionare sui motivi di ulteriore riduzione
della complessità del sistema, senza pensare minimamente ai problemi di
rappresentatività che un partito politico deve porsi.
Il riformismo e le riforme.
La mitizzazione di una falsa soluzione
Uno sguardo
breve, ma attento, alle vicende dell’economia occidentale dell’ultimo ventennio
ci pone subito nella condizione per accorgerci di come la sinistra europea
abbia, in maniera acritica, ceduto al mito del neoliberismo attraverso la
pratica poco oculata delle privatizzazioni su larga scala. Blair ha dimesso quel
poco ch’era rimasto dopo l’era Thacter, in Francia privatizzazioni su larga
scala sono state fatte al tempo di Mitterand e Jospin, mentre in Italia, dopo il
crollo del 1994, fra le personalità che con più ardore e impegno hanno
contribuito alle dismissioni statali possiamo ricordare Amato, D’Alema e Prodi18.
Benché la
partita sia stata iniziata dalla destra neoliberista, con il dichiarato intento
di abolire le roccaforti sindacali e di conseguenza un blocco politico – sociale
consolidato, la sinistra italiana ha visto nelle dismissioni su larga scala la
possibilità di un nuovo posizionamento politico sociale nel quadro della
politica europea19.
Il riposizionamento, che una parte della sinistra italiana ha cercato, ha alla
base una convinzione culturale che la dice lunga sul percorso fatto in temi di
economia e sostenibilità dello sviluppo, se è vero che il suo nuovo orizzonte
concettuale sta nella profonda convinzione ch’è impossibile governare al di
fuori dei mercati finanziari. Se questo è il punto di partenza ne consegue che
da un lato la sinistra ha offerto di trasferire posizioni di rendita
monopolistica alle élite finanziarie mondiali, chiedendo, dall’altro lato, un
appoggio discreto nella sua legittimazione come forza di governo20.
L’operazione viene presentata
sotto la categoria rassicurante della modernizzazione. Ma se cerchiamo di
storicizzare il caso italiano, non abbiamo difficoltà a vedere come sotto le
vesti dei processi di modernizzazione si è celato il totale ribaltamento della
politica del blocco sociale immaginato dal riformismo italiano, del primo
riformismo che ha avuto le gambe e le idee di uomini come Nenni o anche Amendola,
che ha nazionalizzato l’energia elettrica e che ha rotto con gli oligopoli,
tentando una prospettiva socio – politica alternativa al libero mercato.
Cercando nella programmazione lo strumento fondamentale per la progettazione di
uno sviluppo razionalizzato del paese e vedendo nella fusione della classe
operaia con la media borghesia, avveratosi attraverso il tessuto delle piccole e
medie imprese, il suo blocco sociale di riferimento.
Quello che
n’è derivato è stata la completa accettazione, tanto da destra quanto da
sinistra, di un, cosiddetto, Stato leggero, senza proprietà, che ha governato i
processi di mercato in maniera efficientistica. Se sotto il profilo logico
questa proposta ha retto, la declinazione dello stato in senso democratico ha
reso l’intento meno appetibile, poiché ha finito per affidare alla tassazione e
alla regolamentazione delle procedure uno spazio eccessivo, con la conseguenza
di fortificare, in maniera progressiva, le correnti antipartitocratiche e, più
in generale, antipolitiche21
sempre vive nel nostro paese. Il riconoscimento dello stato democratico passa
dalla sua legittimazione sociale, attraverso il potenziamento delle funzioni
qualitative dei suoi processi di integrazione. Uno stato che governa secondo
delega diventa uno stato che esclude, con un depotenziamento sempre maggiore dei
servizi che lo stesso offre. La questione evidentemente non è solo italiana, ma
coinvolge la possibilità all’interno dell’Unione Europea di sviluppare uno
spazio d’integrazione politico e sociale che vada oltre le semplici procedure
elettorali, uno spazio politico dove la sinistra europea riacquisti i tratti
distintivi del suo elettorato di riferimento, accettando la possibilità, anche
solo teorica di un’azione di governo che miri ad un ripensamento delle strutture
del welfare state di stampo socialdemocratico. Lo sviluppo non può essere
coniugato al singolare, ma ha necessità di qualità plurali.
Se come abbiamo sopra spiegato,
è ormai assodata la convergenza di quasi l’intero spettro delle forze politiche
in merito a quale tipo di politica economica seguire, il tema delle riforme ha
altrettanto omogeneamente interessato le forze presenti nel parlamento. Anche in
questo caso non si tratta di una specificità italiana, ma della ricezione delle
linee di tendenza che dagli anni ottanta, con sempre più vigore, hanno
caratterizzato, prima il dibattito e poi le regole di quasi tutte le democrazie
occidentali. A partire dal 1992 era un segno intangibile presente nell’opinione
pubblica che una riforma del sistema politico italiano era diventata non solo
utile, ma urgente. La rappresentazione pubblica di un cambiamento necessario fu
data anche dal PCI di Occhetto, che una volta caduto il muro non perse tempo a
incamminarsi sul sentiero delle riforme istituzionali, concorrendo alla raccolta
delle firme per il referendum del 1991. Anche il PCI aveva maturato l’idea di un
cambiamento e lo manifestava sotto forma di delega al popolo, potenziando la
macchina referendaria di Segni22,
che nel breve tempo di due anni avrebbe radicalmente mutato il volto alla
struttura istituzionale della nostra democrazia. Non proprio un successo. Le
elezioni politiche del 1994 avevano decretato lo sfondamento elettorale delle
correnti antipolitiche, che contro la elefantiasi burocratica e un rinnovato
sentimento anticomunista, erano riuscite a rassicurare quell’elettorato moderato
orfano dello scudo crociato. La breve parentesi del primo governo Berlusconi non
diede atto a nessuna riforma degli assetti. Il discorso riprendeva in grande
stile nel 1996. Prodi non aveva perso tempo ad istituire una commissione
bicamerale presieduta da D’Alema con a fianco in qualità di vice il leader
dell’opposizione. Ne era venuta fuori la proposta di un sistema
semipresidenziale, ovvero un presidente eletto a suffragio dal popolo, ma con
nessun potere di condotta di politica estera e di difesa. L’accordo in
conclusione prevedeva una riforma delle legge elettorale che avrebbe sancito la
legittimazione popolare del capo del governo23.
Il progetto decadde nel 1998 in sede di approvazione. Che il progetto sia
fallito poco importa, il dato inequivocabile sta nella convergenza fra le due
opposte fazioni in un progetto di riforma istituzionale che aveva il suo chiaro
obiettivo nel rafforzare il ruolo della leadership del capo di governo.
Centralizzazione del potere e snellimento delle procedure, con l’eliminazione
del doppia lettura alla camera e al senato, erano i punti nodali per una nuova
riforma, a destra e a sinistra. Il percorso trovava un primo sbocco nella
riforma del 1999 in materia di elezione dei presidenti delle regioni, dove
veniva introdotta l’elezione diretta dello stesso. Si capisce come il solco era
ormai segnato, la personalizzazione del rapporto elettore - candidato era il
nuovo orizzonte entro il quale agire. I partiti, da quel momento, hanno perso,
ogni giorno di più, un pezzo del loro potere di indirizzo24,
sintomo n’è stata la proliferazione, elezione dopo elezioni, di un numero sempre
maggiore di liste del presidente che molto spesso portano il nome stesso del
candidato, come a sancire la diretta riconoscibilità, al di fuori di qualsiasi
appartenenza partitica e ideologica25.
Si è orami in presenza di una politica profondamente cambiata nelle sue
tradizionali funzioni di integrazione, formazione e rappresentazione, che pone
al centro della sua azione una spasmodica ricerca di visibilità. A questo punto
si è consumato il passaggio, dalla propaganda alla persuasione26.
Conclusioni
La democrazia italiana era
nata come una democrazia del consenso, ma negli ultimi due decenni si è
gradualmente trasformata in una democrazia d’investitura27.
Come abbiamo spiegato fino a questo punto le cure proposte al malato sono andate
tutte verso la stessa direzione, ma come vedremo adesso, non sempre la cura
sortisce, obtorto collo, gli esiti sperati.
Il presunto rinnovamento della
classe dirigente è passato in secondo piano poiché, più che ad un rinnovamento
dei quadri, abbiamo assistito ad una diversificazione dell’offerta politica. Si
sono potenziate le leghe, tanto a nord quanto a sud la Lega di Bossi e il
Movimento per l’Autonomia di Raffaele Lombardo hanno ritirato fuori dal cassetto
gli arnesi della retorica antipartitocratica e antipolitica che ciclicamente
ritorna sulle pagine dei principali quotidiani, fortificando la loro rendita di
posizione a prescindere del sistema elettorale, esempio n’è il MPA nato sotto un
sistema maggioritario e fortificatosi sotto quello proporzionale. Sul fronte del
centrosinistra troviamo radunati i reduci dei vecchi partiti, o chi
letteralmente ne ha ereditato cariche e simboli, sicuramente lontani dai
collegamenti con la società civile che le antiche chiese garantivano. Il costume
politico non ha subito nessun radicale cambiamento, ma anzi le storie del
sottosuolo si sono perfettamente integrate con quello che accade nel mondo di
sopra, malavita e malaffare si sono associate con la rappresentazione politica
dei propri interessi. Ma alla fine l’importante è modernizzare, costi quel
costi, che tradotto ha significato affrancare l’economia e la società dai
vincoli eccessivi istituiti dal welfare, resi inconciliabili con le esigenze
della globalizzazione dei mercati.
Il mutamento di prospettiva,
avvenuto fra gli anni ottanta e novanta, ha messo in crisi le logiche dei
sistemi socialdemocratici che avevano come principale obiettivo la correzione
delle disfunzioni prodotte dal mercato. Ma proprio durante gli anni
sopraccitati, le teorie neoliberiste riportavano in auge l’infallibilità del
mercato, e di conseguenza l’allontanamento di ogni intromissione da parte del
pubblico. Alla sinistra europea non è rimasto altro che appropriarsi del governo
invadendo le aree di elettorato prevalentemente di destra, attraverso una
decostruzione intellettuale ed economica del proprio blocco sociale28.
La soluzione del cambiamento di rotta ha avuto delle pratiche precise come ad
esempio abbassare le aspettative dell’elettorato di sinistra, invocare i vincoli
del mercato globale, o del mercato europeo, infine esternalizzare non solo
servizi ma soprattutto responsabilità di governo. Il risultato è evidente, con
una sinistra italiana che ha fatto molto per spostarsi verso il centro,
accreditandosi agli occhi dell’elettorato moderato, e una destra che si è
limitata ad abbracciare la retorica populistica come leva del consenso. Ne è
conseguito un completo estraneamento dell’elettorato che per decenni aveva
votato a sinistra credendo in politiche di welfare state e rigore morale. La
percezione di una mancanza di alternative nell’offerta politica può essere uno
dei motivi che caratterizza il partito del “non voto”, che si aggira ormai fra
il 20 – 25%.
In definitiva in
Italia, come ha affermato Salvatore Lupo, un riformismo di sinistra non è mai
esistito perché oltre la metà degli anni settanta, quando il PSI di Craxi aveva
messo questo tema al centro dell’azione politica, nel resto dell’Europa iniziava
il decennio del neoliberismo di matrice reaganiana. Da allora il riformismo ha
parlato il linguaggio economico delle liberalizzazioni, e quello istituzionale
delle riforme. Restringimento della spesa pubblica e un costante smantellamento
delle garanzie sociali ne sono stati i diretti corollari. Quello verificatosi
fra gli anni ottanta e novanta è stato un vero e proprio passaggio d’epoca su
scala mondiale, all’interno del quale si sono ridefinite le categorie
interpretative dello sviluppo economico senza però accedere al serbatoio delle
risorse morali. Sono mutati i quadri dei rapporti tra soggetti politici in
competizione, che appaiono sempre meno concorrenti nella percezione
dell’elettorato. Le sinistre europee additate come responsabili del crollo del
welfare, non hanno fatto nulla per contrastare la deriva neoliberista. La forte
tradizione pedagogica sembra essere stata dimenticata. Sono rimaste le abiure,
una dopo l’altra le professioni di fedeltà all’alleato sono state tutte
esaurite, almeno ci auguriamo. Nella crisi d’identità che tormenta oggi il
nostro paese le uniche risposte praticate sono, ancora una volta tanto a destra
quanto a sinistra, il localismo29.
Una società smarrita necessita di una ridefinizione degli strumenti
interpretativi. Potremmo iniziare da un motivo forte di distinzione, di
divisione, che possiamo costruire se riusciamo a slegare i motivi delle pratiche
politiche da un suo immediato riscontro quantitativo. Distinguere il guadagno
dalle procedure di regolamentazione della vita pubblica deve essere il limen
fra la possibilità di costruire un’alternativa all’orizzonte neoliberale
oggi radicato nel nostro spazio politico e il perdurare in uno spazio politico
unificante, nelle aspettative e nelle pratiche.
I partiti,
nel loro lungo cammino di metamorfosi, giunti all’ultimo stadio, si sono
trasformati in gruppi centralizzati di eletti e amministratori, vuoti di
tensioni ideali e di spessore organizzativo: poco più di un marchio per il
franchising elettorale. L’ideologia, l’idea di una società alternativa, con
blocchi sociali diversi, soltanto il radicale ritorno a questi strumenti può
garantire, a nostro avviso, e contemporaneamente giustificare l’esistenza di una
sinistra italiana, dove il simpatizzante è un tesserato, e dove il tesserato
abbia fiducia nel vincolo di rappresentatività che lega la sua condizione
sociale alle pratiche politiche del suo partito.
* Gabriele Licciardi, laureatosi nel 2003 in Storia presso l’Ateneo di Catania, è docente di storia e filosofia nei licei del Veneto. Si occupa di storia del Novecento. Nel 2006 è stato docente di “Fotografia e storia” presso il “Medialab” della Facoltà di Lingue di Catania. È collaboratore alla ricerca presso la cattedra di Storia contemporanea della facoltà di Scienze della Formazione dello stesso ateneo. Collabora con la rivista Segno.. Ha pubblicato con L. Severino, Narrazione egemonica, uso pubblico della storia e memorie resistenti, in Annali, Facoltà di Scienze della Formazione (2008); Il ’68 in periferia. Catania, Bonanno, 2009. Ha partecipato al progetto Siciliane, curando il profilo biografico di Adelaide Bernardini Capuana.
note
1. Mi permetto di rimandare a L. Severino – G. Licciardi, Narrazione egemonica, uso pubblico della storia e memorie resistenti, in Annali, Catania. CUECM, 2008, pp. 7 – 51.
2. S. Belligni, La nobiltà di spada nella repubblica dei compari, in Nuvole, n. 38,. Marzo 2009.
3. G. Galli, Il bipartitismo imperfetto, Bologna, Il Mulino, 1972.
4. G. Sartori, Teoria dei partiti e caso italiano, Milano, SugarCo, 1982
5. P. Farneti, Il sistema dei partiti in Italia, 1946 – 1979, Bologna, Il Mulino, 1983.
6. P. Scoppola, La repubblica dei partiti, Bologna, Il Mulino, 1997.
7. In questo senso cfr., A. Mastropaolo, La repubblica dei destini incrociati. Saggio su cinquant’anni di democrazia in Italia, Firenze, La Nuova Italia, 1996; id., Che ne è della politica italiana, in Segno, n° 283, aprile 2007.
8. Cfr., S. Lupo, Partito e antipartito. Una storia politica della prima Repubblica, 1946 – 1978, Roma, Donzelli, 2004
9. Su questo tema «Repubblica» ha dedicato il suo approfondimento settimanale nella rubrica Diario, con gli articoli di E. Berselli, Quando erano i partiti a dettare la linea, e C. Galli, L’occidente in crisi sedotto dal capo, 5 giugno, 2007.
10. Cfr., A. Mastropaolo, La Repubblica dei destini incrociati, op. cit.
11. A. Pizzorno, Le radici della politica assoluta e altri saggi, Milano, Feltrinelli, 1994.
12. Cfr., A. Ventrone, Il nemico interno, Roma, Donzelli, 2005.
13. Su questo tema cfr., A. Blando, Italia 1992 – 1993: la retorica del regime, in, A. Blando – P. Viola (a cura di), Quando crollano i regimi, Palermo, Palumbo, 2004.
14. G. Amato, Una repubblica da riformare. Il dibattito sulle istituzione in Italia dal 1975 ad oggi, Bologna, Il Mulino, 1980. Il saggio di Amato appare di grande interesse poiché esprimeva e teorizzava il superamento del vecchio paradigma dell’incompiutezza e con sottigliezza iniziava a elaborare il paradigma del degrado, frutto di una politica da “governo sparititorio”. Il saggio si basava su una requisitoria severissima contro tutti gli attori politici del tempo. La soluzione era non più riscontrabile in una evoluzione delle maggioranze parlamentari, ma nella radicale trasformazione dell’assetto istituzionale del paese. Alla base di tutto c’era l’elezione diretta del Capo dello Stato.
15. Cfr., A. Mastropaolo, Vita, morte, passione del centrismo in Italia, paper presentato alla “PSA 2006 Conference”. Reading 4 – 6 aprile 2006.
16. Su questo tema cfr., N. Bobbio, Compromesso e alternanza nel sistema politico italiano. Saggi su MondOperaio, 1975 – 1989, Roma, Donzelli, 2006; cfr., M. Revelli, Destra e sinistra, Roma – Bari, Laterza, 2007, dove lo storico torinese traccia un profilo diverso rispetto alle terze vie di Giddens sulla possibilità di ragionare ancora in termini di identità politiche contrapposte, indicandone motivi forti e scelte ragionate.
17. Cfr., M. Calise, La terza Repubblica. Partiti contro presidenti, Roma – Bari, Laterza, 2006.
18. Sul tema del riformismo la rivista Meridiana ha dedicato un numero monografico il 50/51 del 2004.
19. In relazione a questo aspetto della tematica cfr., M. Florio, Le privatizzazioni come mito, in Meridiana, n° 50/51, 2004, pp. 133 – 160.
20. Possiamo provare a capire il senso dell’azione proposta se leggiamo la storia del nostro capitalismo. Cfr., Storia del capitalismo italiano, a cura di Fabrizio Barca, Roma, Donzelli, 1997.
21. A. Mastropalo, L’Antipolica. All’origine della crisi italiana, Napoli, L’ancora del Mediterraneo, 2000.
22. M. Fedele, La repubblica referendaria,Roma, Donzelli, 1994
23. Interessante e seguire questo dibattito attraverso la critica liberale di Giovanni Sartori, che ha riassunto il suo punto di vista su questo argomento e su altri ancora in Mala tempora, Roma - Bari, Laterza, 2004
24. S. Niccolai, Il Governo, Roma – Bari, Laterza, 2003
25. A. Mastropaolo, La democrazia manomessa. Riformare, deformare, conformare, in Meridiana, n° 50/51, 2004; M. Calise, Il partito personale, Roma – Bari, Laterza, 2000; G. De Luna, Tra propaganda e marketing. La politica della Seconda Repubblica, in G. De Luna, G. D’Autilia, L. Crescenti (a cura di), L’Italia del Novecento. Le fotografie e la storia, vol. 1. 2, Il potere da De Gasperi a Berlusconi 1945 – 2000, Torino, Einaudi, 1994
26. Cfr., A. Campi, Metamorfosi del nemico interno, in, A. Ventrone (a cura di), L’ossessione del nemico interno, Roma, Donzelli, 2006.
27. S. Ceccanti – S. Vassallo, Il sistema politico italiano tra cambiamento, apprendimento e adattamento, in id. (a cura di) Come chiudere la transizione: cambiamento, apprendimento e adattamento del sistema politico italiano, Bologna, Il Mulino, 2004.
28. Cfr., M. Blyth – J. Hopkin, Questa è la globalizzazione?, in Meridiana, n° 50/51, 2004.
29. Cfr., P. Segatti, Una nazione di”compaesani”. Localismo e sentimento nazionale, in, A.M.L. Parisi – H.M.A. Schadee, Sulla soglia del cambiamento. Elettori e partiti alla fine della prima repubblica, Bologna, Il Mulino, 1995; per un’analisi di carattere sociologico sull’affermazione dei partiti locali ed in particolare la Lega cfr., A. Bonomi, Il Rancore. Alle origini del malessere del Nord, Milano, Feltrinelli, 2008.
[9 maggio 2009]
home>interventi/interviste> La politica trasformata. La politica riformata