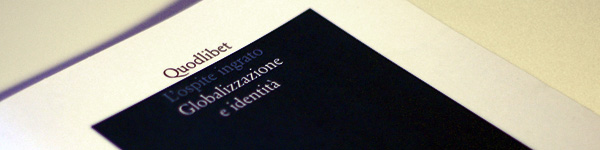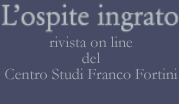home>interventi/interviste> Levar la mano su di sé. Radicati e la questione del suicidio
Levar la mano su di sé. Radicati e la questione del suicidio
Massimo Cappitti
«Gli Struldbruggs arrivavano alla soglia dei sessanta, che è il limite medio dei mortali, non solo con quelle malattie della mente e infermità del corpo che aduggiano gli uomini in generale, ma con ben altre ancora, dovute alla terribile prospettiva di non morire mai».
J. Swift, I viaggi di Gulliver
Nella Dissertazione filosofica sulla morte,
Alberto Radicati conte di Passerano (1668-1737) scrive che la morte – una volta
rimossa l’insensata e innaturale paura che l’accompagna – non solo ripristina
l’originaria eguaglianza tra gli uomini, ma «ci libera dalla persecuzione dei
nostri nemici, dalla tirannia dei grandi, dalle inquietudini che ci affannano,
dalle angosce che ci tormentano, dalle infermità che ci tiranneggiano e, in una
parola, da tutte le nostre miserie».[1] Per questo motivo, darsi la morte, lungi
dal costituire un’espressione di debolezza o un omicidio di sé, come voleva
Agostino, diventa, all’opposto, la manifestazione della libertà e della dignità
umane, soprattutto quando la vita sia diventata un fardello insopportabile.
Agisce, in questa visione, la convinzione ereditata da Seneca che importi non
tanto vivere ad ogni costo, quanto vivere bene. La saggezza, allora, consiste
nel saper scegliere quando, ospiti sazi, abbandonare la vita, quando, cioè,
decidersi per una fine certa contro una esistenza dolorosa e umiliante.
La
Dissertazione, come ben evidenzia Cavallo, il curatore del libro, è intrisa
di riferimenti – talvolta espliciti, altrimenti celati tra le pieghe del
discorso, sebbene riconoscibili – ad autori antichi e moderni: Lucrezio, Persio,
Empedocle, Seneca, Bruno, Spinoza, Locke, Montesquieu, Swift, per citarne solo
alcuni. Riferimenti sapientemente rifusi da Radicati in una composizione serrata
e sistematica eppure non costrittiva.
La bellezza e la profondità del testo,
tuttavia, non risiedono tanto nell’originalità teorica delle argomentazioni
dell’autore, quanto, piuttosto, nel fatto che il libro sembra inscriversi nella
tradizione della precettistica antica della “cura di sé” e del dialogo
intrattenuto da ciascuno con se stesso al fine di vivere la vita all’altezza che
essa richiede e con la consapevolezza che essa esige. Radicati, infatti,
chiarisce che il suo intento non consiste tanto nello «staccare l’animo altrui»
dal falso terrore della fine e dell’aldilà, quanto nel desiderio di
«fortificare» se stesso «contro ogni credenza così vana» [2], quasi, come nota il
curatore, ritenesse che una morte liberamente scelta potesse costituire l’esito
della sua vita a quell’epoca molto travagliata e dolorosa. Biografia dell’autore
e argomentazioni teoriche, pertanto, si stringono in un nesso dove diventa
impossibile separare l’una dalle altre senza compromettere l’integrità e la
forza persuasiva del testo. Del resto, quando, nel 1732, pubblica la
Dissertazione, Radicati è già esule a Londra per aver espresso opinioni
eretiche e, quindi, in conflitto con la Chiesa di Roma. Nei suoi scritti, più
volte, aveva rimarcato la necessità di liberarsi dal «giogo crudele dei preti»
e, insieme, dalla loro pretesa di fare della propria l’unica ed esclusiva
verità.
Anche nella Dissertazione egli polemizza contro quegli «arditi
impostori» così abili a servirsi o, addirittura, a indurre la paura della morte
e il terrore dell’aldilà per imporre il proprio dominio. «Interpreti della
volontà divina e sovrani di quella degli uomini» [3], quegli individui «ambiziosi»
non solo «corrompono il nostro intelletto» ma contaminano e violentano «la
nostra immaginazione» popolandola di vane e false credenze e asservendo, così,
l’umanità alle rappresentazioni che loro stessi hanno contribuito a creare.
Non
solo, facendo leva sulla superstizione, hanno provveduto a edificare un potere
oppressivo dove la dimensione religiosa e quella secolare sono accomunate dalla
volontà di assoggettare il popolo, obbligato a credere di obbedire a Dio mentre,
in realtà, si sottomette ai suoi pretesi rappresentanti. Asservimento che è
anche l’esito dell’oscillazione continua tra sentimenti così inaffidabili – come
ben sapeva Spinoza – quali la speranza e il timore.
Solo l’uscita dalla
«minorità» e l’esercizio consapevole della ragione possono, allora, costituire
l’antidoto alle menzogne e ai poteri su di esse fondati, svelando, nel contempo
l’origine convenzionale di tutte le idee e rappresentazioni umane.
«La strana potenza dell’abitudine»
L’idea della morte è una delle «idee più orride e
spaventose». Eppure, nonostante, appaia «antica e universale», tuttavia non è
un’idea innata, invece è, al pari delle altre, «acquisita e malfondata»,
risultato, cioè, della forza con la quale l’abitudine e l’educazione hanno
plasmato e pervertito l’umanità, strappandola alla sua condizione naturale per
consegnare gli uomini a spaventosi e «vani timori». Alla luce della critica
dell’innatismo, ripresa da Locke, allora anche il terrore, per quanto radicato e
persistente, non può essere un’idea «nata con noi». Lo dimostrano, ad esempio,
«bambini» e «folli» che non temono affatto di morire.
Radicati più volte
attribuisce alla «civiltà» il distacco dalle leggi di natura e la conseguente
sottomissione a quelle inventate dagli uomini «quasi sempre totalmente opposte
alle leggi originarie» [4]. Infatti, «l’educazione e l’abitudine sono una seconda
natura e, in quanto tali, sono capaci di corrompere e di mutare le disposizioni
naturali tanto della mente che del corpo» [5].
Radicati elenca numerosi esempi della
«strana potenza dell’abitudine» che spinge gli uomini – ma non solo gli uomini –
ad accettare e mantenere comportamenti dannosi perfino per la conservazione
stessa della vita: dal «disprezzo della libertà» indotto dall’abitudine ad una
lunga reclusione, accettata come condizione inoltrepassabile, alla «servitù
volontaria» che caratterizza i rapporti con i detentori del potere. Ma il
carattere acquisito e contratto delle idee è testimoniato dalla «diversità di
opinioni» e di comportamenti, cosicché, come già avevano evidenziato Montaigne e
Pascal, «molti dichiarano certe cose oneste, giuste e buone, le raccomandano
come tali e le mettono in pratica», mentre «molti altri dichiarano le stesse
cose disoneste, ingiuste e cattive, le detestano e se ne tengono lontani» [6]. Da
qui deriva l’infondatezza di ogni etica universale perché non esiste «giudice»
imparziale che possa dirimere il conflitto tra visioni così opposte e, tra loro,
in contrasto. Anzi, sono gli Stati e le Chiese che commettono le azioni più
atroci: le guerre che giustificano le peggiori efferatezze in nome dello Stato
e, in nome di Dio, «le violenze, le perfidie» considerate tanto più «giuste e
lodevoli» se «commesse contro i nemici della religione di coloro che le hanno
compiute» [7]. Se dunque la medesima azione è suscettibile di interpretazioni e
valutazioni così diverse, come la storia dell’umanità ampiamente dimostra,
allora è evidente che non esiste alcuna idea innata. Gli uomini, allora, non
sono inclinati né al bene né al male, ma si orientano nell’esistenza al fine di
soddisfare il principio di «autoconservazione» - lo spinoziano sforzo di ogni
cosa «di perseverare nel suo essere» - assumendo, a tale scopo, il bene e il
male fisico quali criteri di riferimento. È bene ciò che è in accordo con le
disposizioni della natura; è male ciò che pone in «contrasto» con essa,
violandola o «forzandola» a fare ciò che non vuole. Spetta, così, alle sue
creature fare «buon uso» di ciò che la natura ha fornito loro.
«Levar la mano su di sé»
Se, dunque, la natura ha dato la vita agli uomini
affinché ne godano «sino a che essa sia dolce e piacevole», allora è legittimo
che essi decidano di restituirgliela «una volta che diventa per loro un peso».
La morte liberamente scelta, come già aveva sottolineato Montesquieu, è un
sollievo e un «rimedio» per guarire dai mali dell’esistenza. La natura, infatti,
«volendo rendere l’uomo felice e non infelice, ed essendo nemica inconciliabile
di ogni violenza non può obbligarlo a vivere se egli è diventato misero e
sventurato» [8]. Per questo è «naturalissimo togliersi la vita».
Radicati, mentre
destituisce di fondamento le obiezioni tradizionalmente rivolte contro il
suicidio inteso come «trasgressione del nostro dovere verso Dio, il prossimo e
noi stessi» [9], inscrive le sue argomentazioni entro una più ampia concezione della
natura spinozianamente considerata come «materia modificata dal movimento in un
numero infinito di forme diverse» [10]. Materia «eterna» e potenza sempre in atto in
ogni parte dell’universo, la natura appare come una divina forza trasformatrice,
il cui respiro è scandito dal continuo avvicendarsi di generazione e corruzione,
di creazione e distruzione in costante lotta tra loro: antagoniste e, insieme,
complementari.
La materia, quindi, lungi dal rappresentare il «sostrato sterile»
e opaco di Plotino o l’estrema degradazione dell’essere, è la matrice inesausta
e inesauribile dei possibili che da essa, incessantemente, prendono forma, per
poi, a tempo opportuno, rientrarvi, pronti per nuove combinazioni. Essa permane
identica eppure sempre diversa nelle sue singole manifestazioni che, volta a
volta, ne attualizzano un aspetto. Figure che si compongono per essere
successivamente abbandonate, obbedendo all’imperativo del ringiovanimento e del
«vigore perpetuo» che permeano la natura [11].
Radicati inscena una rappresentazione
della vicenda del vivente tragica e, insieme, gioiosa: tragica perché, nel suo
eterno movimento, la morte di una sua parte alimenta una nuova vita ed è
condizione necessaria della nascita di un’altra; gioiosa perché le forme che in
essa proliferano testimoniano della sua infinita potenza metamorfica e delle sue
infinite combinazioni solo all’apparenza casuali [12].
In realtà, la natura agisce
secondo «saggezza» e «perfezione» dando vita a «una infinità innumerevole di
specie, tutte non solo necessarie e perfette, ma anche inimitabili ed eterne»
[13].
L’universo
è, allora, «uno stato infinito che contiene l’immensa materia disseminata e
ovunque frammista a dei vuoti sottilissimi in cui sono agitate da una parte
all’altra con un mutamento inesauribile le più piccole particelle della
materia»[14]. Ogni atomo concorre febbrilmente a «formare e sostenere i corpi», da
un lato, e, dall’altro «a farli decadere e a dissolverli». Nulla, quindi, può
rimanere uguale a sé: in ogni istante i corpi sono soggetti a urti e pressioni
esterne e a mutamenti interni spesso impercettibili e inavvertiti cosicché «oggi
non siamo del tutto le stesse cose di ieri» [15]. Nel confluire di ogni cosa nel
tutto, nella trasmutazione senza posa delle forme, nel reciproco compenetrarsi
dei corpi, non solo ogni individuo scopre di essere «parte di migliaia di cose
contemporaneamente», ma anche di non poter vantar alcun legame stretto e
privilegiato con «una certa figura o forma» poiché «la perde e la muta
continuamente» [16].
Anche la morte, quindi, non rappresenta più una condizione
definitiva, bensì «un processo di dissoluzione» in virtù del quale una
determinata configurazione si scioglie per ricomporsi in un’altra forma. Così
come nulla può provenire dal nulla, altrettanto non può vi essere un
annichilimento definitivo [17]. Se, come ricorda Cavallo, la natura, per Radicati,
«ama e desidera il mutamento», allora tanto più incomprensibile appare la paura
della morte che è solo modificazione di stato e non una condizione definitiva.
Saggio è chi acconsente alle ragioni del tutto, abdicando alla
pretesa di costituirne il centro e il fine. Con Spinoza, Radicati
respinge la concezione finalistica secondo la quale le cose sono state
create in vista e al servizio dell’uomo. La morte di un singolo,
pertanto, non sconvolge «l’ordine della Provvidenza»,
come l’equilibrio della natura non è turbato dal fatto che
qualcuno «viva o meno». È solo un’illusione
umana immaginare che «l’annientamento di un essere perfetto
come noi degraderebbe tutta la natura» o, ancora, che la vita
degli uomini – inconsapevoli della loro «piccolezza»
- possa, agli occhi di Dio, valere di più di «un atomo
sottile, isolato» [18].
Infine,
darsi la morte non reca alcun «torto» alla società. Denunciando il carattere
fittizio del contrattualismo, Radicati rivendica la possibilità di uscire dal
legame sociale quando un soggetto cessi di trarne vantaggio e, in particolare,
se la società si è costituita «senza il suo consenso e il suo concorso, perché
nessuno è obbligato ad assolvere un impegno fissato senza la sua partecipazione
e contro la sua volontà». Il contratto sociale, dunque, non può vincolare un
individuo imponendogli condizioni gravose tali da metterlo in conflitto con se
stesso.
Perseguitato anche in Inghilterra per le tesi sostenute nella
Dissertazione, Radicati fuggirà in Olanda dove morirà malato e in miseria.
Restano, nelle sue pagine, non solo il coraggio e la tensione etica, ma la
sobria eppure radicale affermazione della libertà e dignità umane contro ogni
potere che, in ossequio alla violenza di un principio assoluto, ne voglia
impedire l’esercizio.
Note
1. A. Radicati, Dissertazione filosofica sulla morte, a cura di T. Cavallo, edizioni ETS, Pisa 2003, p. 89. Levar la mano su di sé è la traduzione italiana di un libro di J. Améry pubblicato nel 1990 da Bollati Boringhieri. Tomaso Cavallo ha contribuito, con il suo appassionato rigore, a riportare, dopo gli studi di Venturi, l’attenzione su Radicati, curando anche Vite parallele e Dodici discorsi morali, storici e politici, entrambi pubblicati da Gammarò, Sestri Levante (Ge) 2007. Nella stesura del testo ho ripreso alcuni dei molteplici e ricchi stimoli presenti nella sua introduzione alla Dissertazione. Questo contributo è la rielaborazione di un intervento tenuto ad un convegno su Radicati, svoltosi a Passerano il 29 settembre 2007.
2. A. Radicati, Dissertazione, cit., p. 71.
3. Ivi, p. 87.
4. Ivi, p. 121. Cfr. T. Cavallo, Introduzione, cit., p. 38.
5. Ivi, p. 123.
6. Ivi, p. 103.
7. Ivi, p.99. Su questo tema di ispirazione lucreziana cfr. Lucrezio, La natura delle cose. De rerum natura, a cura di G. Milanese, Mondadori, Milano 1992, vv. 82-83, p. 9.
8. Ivi, p. 131. Sul tema cfr. C. de Montesquieu, Lettere persiane, Rizzoli, Milano 1997, p. 166.
9. D. Hume, Sul suicidio, in AA. VV., In difesa dell’eutanasia, a cura di C. Angelino, Il Melangolo, Genova 2007, p. 41.
10. A. Radicati, Dissertazione, cit., p. 75. Sul «materialismo panteistico» e sugli autori cui Radicati fa riferimento sono debitore a T. Cavallo, Introduzione a A. Radicati, Dissertazione, cit., pp. 29-36.
11.J. Toland, Lettere a Serena, Laterza, Bari 1977, pp. 115 e ss. e pp. 149 e ss. La metafora del ringiovanimento – della Verjüngung – ripresa da Herder giunge, per suo tramite, a Hölderlin e ai romantici. Cfr. M. Cometa, Mitologie della ragione in Johann Gottfried Herder, in Id., Il romanzo dell’infinito, Aesthetica, Palermo 1990, pp. 11-86.
12. Sul tema morte-vita e sul loro avvicendarsi tra gli altri cfr. J. Toland, Lettere a Serena, cit., pp. 147 e ss.; Lucrezio, La natura delle cose, cit., vv. 261-264, p. 21; D. Hume, Sul suicidio, cit., p. 50; M. de Montaigne, Saggi, vol.1, Adelphi Milano, 1992, pp. 119 e ss.; Empedocle, Poema fisico, 4 in Id., Poema fisico e lustrale, a cura di C. Gallavotti, Mondadori, Milano 1993, p. 17.
13. A. Radicati, Dissertazione, cit., p. 75.
14. Ivi, p. 71. Riprendo T. Cavallo, Introduzione, cit., p. 33.
15. J. Toland, Lettere a Serena, cit., p. 148.
16. Ibidem.
17. Radicati scrive che il nulla «non ha alcuna proprietà o attitudine a formare la benché minima cosa», (Dissertazione, cit., p. 75). Cfr Lucrezio, La natura delle cose, cit., vv. 215-216, p. 17.
18. C. de Montesquieu, Lettere persiane, cit., p. 167. Affermazione ripresa da Radicati, Dissertazione, cit., p. 137.
19. A. Radicati, Dissertazione, cit., p. 133. Si trovano considerazioni analoghe in C. de Montesquieu, Lettere persiane, cit., p. 167; D. Hume, Sul suicidio, cit., p. 51.
home>interventi/interviste> Levar la mano su di sé. Radicati e la questione del suicidio