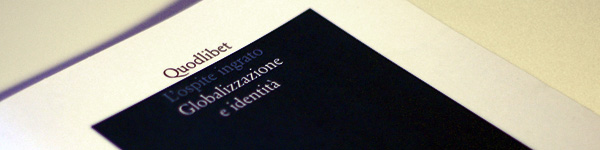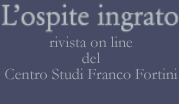home>interventi/interviste> I guanti di Maroni
I guanti di Maroni
Luca Lenzini
1. Nel 1781 il capitano
Luke Collingwood, al comando della nave negriera Zong, ordinò di gettare
a mare, al largo dei Caraibi, 132 africani vivi e incatenati ai loro ceppi.
Motivo della decisione: la nave era fuori rotta, a corto di cibo e d’acqua, e il
suo carico umano – più precisamente, la merce – sempre più avariato,
sarebbe perito prima di giungere a destinazione, ragion per cui l’assicurazione
non avrebbe pagato lo spettante ai padroni della nave. Ad essere pagata era
infatti solo la quota per le “perdite in mare”1.
Ciò che portò alla ribalta il caso fu il processo che seguì, a Londra,
rifiutandosi appunto l’assicurazione di pagare le “perdite” dello Zong.
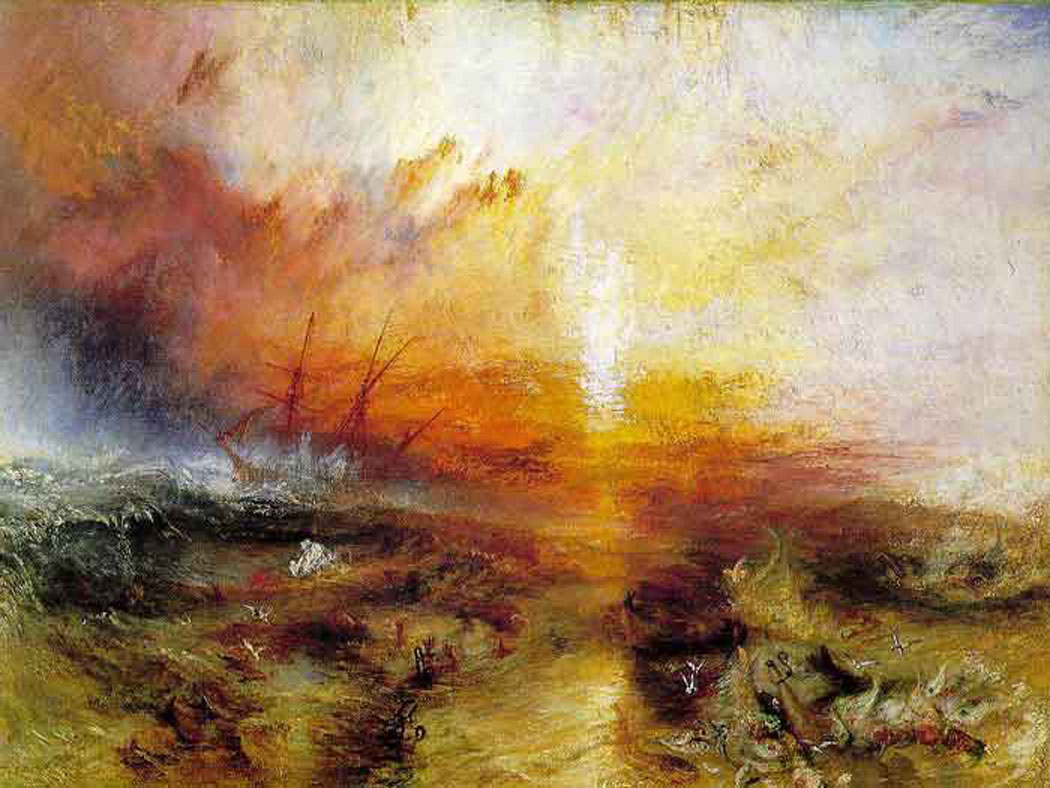 Dell’episodio
esistono resoconti e documenti di archivio; ad esso si riferiscono saggi assai
rilevanti nella storia dell’abolizione della schiavitù (1838 in Inghilterra). Ma
la storia dello Zong è nota anche perché ispirò a Turner uno dei suoi
quadri più famosi, Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying – Typhoon
Coming On, comunemente conosciuto come The Slave Ship, esposto per la
prima volta a Londra nel 1840, nel pieno della campagna abolizionista (allora la
tratta degli schiavi era ancora fiorente negli Stati Uniti e negli imperi
coloniali portoghese e spagnolo). Probabilmente, secondo Simon Schama, oltre che
dalla storia dello Zong, all’epoca riproposta in racconti e pamphlets,
Turner fu influenzato anche da cronache più recenti, come quelle relative all’African
Squadron, la flottiglia della marina britannica impiegata per la caccia alle
navi negriere: «si era saputo» - scrive Schama - «che, incalzati dalle navi
britanniche, gli schiavisti, sia per guadagnare velocità e sfuggire
all’inseguimento, sia per sbarazzarsi delle prove che, se raggiunti, li
avrebbero incriminati, gettavano a mare il loro carico di schiavi»2.
Al quadro di Turner dedicò una pagina celebre John Ruskin, che nel primo volume
dei Modern Painters lo definisce «la più nobile opera» del pittore
inglese, ed anzi «la più nobile marina mai dipinta da un pittore»3. Ruskin puntò tuttavia l’attenzione sulla tecnica con cui Turner riusciva a
rendere, mirabilmente, gli effetti di luce e movimento della scena
rappresentata, ed erano perciò soprattutto il mare e la natura, non la tragica
fine degli schiavi, al centro del suo commento: alla nave negriera ed alla sua
truce storia Modern Painters dedica solo una breve nota a piè di pagina.
Dell’episodio
esistono resoconti e documenti di archivio; ad esso si riferiscono saggi assai
rilevanti nella storia dell’abolizione della schiavitù (1838 in Inghilterra). Ma
la storia dello Zong è nota anche perché ispirò a Turner uno dei suoi
quadri più famosi, Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying – Typhoon
Coming On, comunemente conosciuto come The Slave Ship, esposto per la
prima volta a Londra nel 1840, nel pieno della campagna abolizionista (allora la
tratta degli schiavi era ancora fiorente negli Stati Uniti e negli imperi
coloniali portoghese e spagnolo). Probabilmente, secondo Simon Schama, oltre che
dalla storia dello Zong, all’epoca riproposta in racconti e pamphlets,
Turner fu influenzato anche da cronache più recenti, come quelle relative all’African
Squadron, la flottiglia della marina britannica impiegata per la caccia alle
navi negriere: «si era saputo» - scrive Schama - «che, incalzati dalle navi
britanniche, gli schiavisti, sia per guadagnare velocità e sfuggire
all’inseguimento, sia per sbarazzarsi delle prove che, se raggiunti, li
avrebbero incriminati, gettavano a mare il loro carico di schiavi»2.
Al quadro di Turner dedicò una pagina celebre John Ruskin, che nel primo volume
dei Modern Painters lo definisce «la più nobile opera» del pittore
inglese, ed anzi «la più nobile marina mai dipinta da un pittore»3. Ruskin puntò tuttavia l’attenzione sulla tecnica con cui Turner riusciva a
rendere, mirabilmente, gli effetti di luce e movimento della scena
rappresentata, ed erano perciò soprattutto il mare e la natura, non la tragica
fine degli schiavi, al centro del suo commento: alla nave negriera ed alla sua
truce storia Modern Painters dedica solo una breve nota a piè di pagina.
 2. Qualche anno fa, una
fotografia che per un po’ suscitò qualche scandalo ritraeva la spiaggia di
Lampedusa, a mezzavia tra Africa e Italia: vi si vedevano alcuni villeggianti
intenti ad abbronzarsi e, un po’ discosto, il cadavere di un “migrante”
restituito al bagnasciuga dal mare. Uno dei tanti, approdato per il gioco delle
correnti ad un lido riservato al relax di turisti e amanti della “natura
incontaminata”: naufragi veri di “carrette del mare”, o procurati da zelanti
“scafisti”, sono infatti all’ordine del giorno nell’ex Mare nostrum,
ma per lo più i cadaveri hanno il buon gusto di restare al
2. Qualche anno fa, una
fotografia che per un po’ suscitò qualche scandalo ritraeva la spiaggia di
Lampedusa, a mezzavia tra Africa e Italia: vi si vedevano alcuni villeggianti
intenti ad abbronzarsi e, un po’ discosto, il cadavere di un “migrante”
restituito al bagnasciuga dal mare. Uno dei tanti, approdato per il gioco delle
correnti ad un lido riservato al relax di turisti e amanti della “natura
incontaminata”: naufragi veri di “carrette del mare”, o procurati da zelanti
“scafisti”, sono infatti all’ordine del giorno nell’ex Mare nostrum,
ma per lo più i cadaveri hanno il buon gusto di restare al fondo, senza turbare le vacanze dei villeggianti.
Nella foto, comunque, non era traccia dell’«ombra
della morte» evocata da Ruskin (alludendo a Macbeth) per la marina di Turner, e
tanto meno tifoni all’orizzonte: quel pacco di ossa e carne avariata era solo
un’intrusione, o meglio un’imperfezione, presto rimossa, nell’immagine mille
volte rivista nelle agenzie di viaggio: spiaggia, pieno sole, mare azzurro,
corpi ben sani e levigati.
fondo, senza turbare le vacanze dei villeggianti.
Nella foto, comunque, non era traccia dell’«ombra
della morte» evocata da Ruskin (alludendo a Macbeth) per la marina di Turner, e
tanto meno tifoni all’orizzonte: quel pacco di ossa e carne avariata era solo
un’intrusione, o meglio un’imperfezione, presto rimossa, nell’immagine mille
volte rivista nelle agenzie di viaggio: spiaggia, pieno sole, mare azzurro,
corpi ben sani e levigati.
Più recentemente, su «Paris-Match»
sono state pubblicate alcune fotografie che documentano l’accoglienza riservata
dagli agenti della Guardia di Finanza italiana ai migranti che una nave di
pescatori, il Bovienzo, aveva salvato dal naufragio al largo di
Lampedusa. I militari italiani indossano i guanti, particolare che spicca per il
contrasto con la pelle degli africani respinti in Libia. Così inizia il
servizio, intitolato Immigrants: le rêve brisé4:
Il croyait [il migrante, vedi
foto] quitter l’enfer, il y est replongé.
L’Italie le
reconduit sur le continent qu’il a fui avec ses 79 compagnons
d’infortune. Pour la premiére fois, des immigés
africains sont refoulés à la matraque et remis à
la brutalité des geôliers libyens, sous les yeux des nos
reporters. En 2008, 36900 “naufragés” se sont
échoués aux abords de l’ĩle de Lampedusa. Pour
endiguer ce flux, Silvio Berlusconi a fait voter une loi, au
mépris des droits de l’homme, qui requalifie la demande
d’asile en délit passible de dix-huit mois de prison.
L’an passé 3 immigrants sur 4 avaient déposé
une demande d’asile politique: 50 % avaient été
acceptées. Depuis, un accord a été signé
avec Kadhafi, les expulsés sont ramenés à Tripoli
sans que leur securité et leur dignité les plus
élémentaires ne soient garanties. Mais il n’y a pas
de barrage contre la misère. À Tripoli, il n’y aura
plus de photographes pour témoigner…
3. La procedura con cui è
rifiutata l’accoglienza ai migranti ha un nome: respingimento. Fino
ad oggi desueta, la parola è diventata improvvisamente popolare: impiegata dal
legislatore e dai giornali, dai politici e dai cittadini della Repubblica. Non
sappiamo a chi si debba tale nomenclatura; per certo però la parola-chiave è
associata al Ministro dell'Interno del governo italiano, Roberto Maroni, di cui
illustra la concreta devozione alla sicurezza del Paese.
Il Grande Dizionario
della Lingua Italiana registra per questa parola due accezioni, una generica e
l’altra tecnica: 1) «spinta all’indietro, in direzione opposta»; 2) «rinvio di
una lettera al mittente». La tipologia linguistica evoca immediatamente la
tipica aura burocratica italiana: vi si può cogliere una parentela con il
lessico che agenti e appuntati maneggiano con goffaggine stilistica, ma non
senza una certa sadica voluttà, nelle questure della penisola. In questo senso
il termine conserva l’impronta della plurisecolare stirpe degli
“azzeccagarbugli” e dei legiferanti, e si colloca così in un tempo lungo, che
rinvia ad un potere distante e minacciosamente imperscrutabile, ottuso e
malefico; tuttavia è da aggiungere che nell’uso corrente la connotazione
generica indicata dal Dizionario è specificata da quella tecnica (di ambito
esplicitamente “postale”), che mantiene, in forma di metafora, un contenuto di
verità. Una verità che appartiene al senso ideologico profondo, anzi al piano
viscerale dell’ideologia: qualcosa che precede perfino il razzismo, in quanto si
fonda sul piano brutalmente economico che regola l’esistenza degli individui
nell’odierno Mercato Globale. Rinviati al mittente (con i guanti): questa è
propriamente la ventura dei migranti. Che tornino alle loro terre di miseria, di
carestia, di guerre, di Aids: al niente da cui sono venuti, e che
vogliamo rimuovere dallo sguardo. Con la sua faccia da ometto da banco dei
pegni, nascosta e ammodernata dagli occhiali alla moda dell’anno scorso, il
Ministro degli Interni (amante del jazz) ci fa sapere che d’ora in poi i
nostri surfisti non avranno da temere pacchi dispersi tra le onde.
Quando venne in uso nei
media l’espressione extraordinary renditions Salman Rushdie scrisse un
articolo con il titolo Ugly phrase conceals an uglier truth5.
Lo scrittore vi denunciava l’intento mistificante che presiedeva alla
“brutalizzazione” del linguaggio operata con tale parola, e faceva i casi di
analoghe espressioni, come pulizia etnica o soluzione finale.
Altri esempi potremmo aggiungere, estraendoli dal campionario di ipocrisie e
rimozioni della storia patria: per esempio, per restare all’Africa, in merito
all’uso degli «aggressivi chimici» da parte dell’aviazione nella guerra
colonialista in Africa Orientale; ma già nel suo Goodbye to all that
Robert Graves notava come nelle comunicazioni dello stato maggiore agli
ufficiali inglesi al fronte sulla Somme l’uso del gas fosse definito «rilascio
dell’accessorio»6.
Eufemismi, ma di un genere particolare. Genere legato insieme alla civiltà di
massa ed alla guerra, dichiarata o meno, dai governanti – fascisti, nazisti o
sedicenti democratici – e destinata ad annientare l’altro. I protocolli
nazisti ne sono solo l’esempio più conseguente. Il guscio terminologico
neutralizza il nucleo abietto e inumano, mantiene le distanze – diciamo che usa,
linguisticamente, i guanti - restando sul piano “tecnico”, e così consentendo un
margine di ottenebramento, un’autoassoluzione che segna l’ingresso nella zona
grigia della coscienza che ha permesso Auschwitz. Il saggio di Th. W. Adorno
intitolato (appunto) L’educazione dopo Auschwitz si conclude con questa
osservazione:
Walter Benjamin mi chiese una
volta a Parigi, durante il periodo del nostro esilio politico, quando io
ritornavo ancora sporadicamente in Germania, se là ci fosse un numero
sufficiente di aguzzini pronti ad eseguire i comandi dei nazisti. C’era. La
domanda ha tuttavia una sua profonda ragion d’essere. Benjamin intuiva che gli
uomini che materialmente commettevano quegli orrori, al contrario degli
assassini da tavolino e degli ideologi, agivano in contrasto coi loro interessi
immediati, e assassinando gli altri, diventavano assassini di se stessi7.
4. Ha fatto bene Turner a
non mettere in primo piano gli schiavi annegati nel mare dei Caraibi, e a
fornire il vasto quadro d’insieme: onde («ampio sollevarsi dell’oceano intero»,
scrive più precisamente Ruskin), e tramonto, ombre fonde e vascello in corsa
verso la tempesta «con le esili alberature che si stagliano contro il cielo in
linee sanguinose». Ed ha ragione Schama, nel suo commento al dipinto, a
ricordare che l’artista («come Goya nei Disastri della guerra») non
voleva offrire «la bellezza», quanto piuttosto «farla a pezzi»: quel «tronco
semisommerso di un’africana nuda, di cui soltanto una gamba si leva impotente e
terribile in aria, mentre il corpo enfiato ondeggia oscenamente sotto la
superficie dell’acqua»8
doveva stare dentro un ampio e drammatico movimento, essere portata via e per
sempre e in corso di sparizione, appena una cosa – un particolare, un
dettaglio - tra i ceppi, gli squali e le onde. Solo così la condanna poteva
essere impietosa, totale, e insieme accennare ad una redenzione.
Poco prima dell’arrivo
del Bovienzo, a largo di Lampedusa era rimasto bloccato per quattro
giorni il cargo turco Pinar, al quale sia le autorità di Malta sia quelle
italiane avevano negato l’ingresso nelle rispettive acque territoriali. A bordo
143 migranti, recuperati da barconi alla deriva; ed il cadavere di una donna
incinta, che l’equipaggio non aveva fatto in tempo a salvare. «È l’ordine più
infame che abbia mai eseguito»: così si è espresso un militare delle motovedette
italiane che hanno riportato in Libia i migranti. «Un successo», e più ancora
«una svolta storica» ha commentato il Ministro degli Interni. Con che parole il
capitano Collingwood avrà argomentato le proprie azioni, per ricevere il premio
dell’assicurazione? Comunque sia, egli morì prima che il processo giungesse a
compimento. Ha fatto la sua parte, è entrato nella storia. Ora tocca all’ometto
del banco dei pegni. La domanda che ci riguarda è quindi: quanti aguzzini sono
pronti ad eseguire gli ordini?
note
1. L’episodio è ampiamente ripreso nell’opera di Paul Gilroy, The Black Atlantic. L’identità nera tra modernità e doppia coscienza, Roma, Meltemi, 2003 (ed. orig. London – New York, 1993). Tra gli studi recenti sul tema segnalo, sulla scia soprattutto di Glissant, Ian Baucom, Specters of the Atlantic («The South Atlantic Quarterly», Winter 2001, pp. 61-82).
2. Simon Schama, Il potere dell’arte. Le opere e gli artisti che hanno cambiato la storia, Milano, Mondadori, 2007, p. 268.
3. John Ruskin, Pittori moderni, a cura di G. Leoni, Torino, Einaudi, 1998, I, p. 480. Vedi Paul Gilroy, Art of Darkness, Black Art and the problem of bellnging to England, «Third World: Perspectives on Contemporary Art & Culture». (Spring 1990), 10, pp. 45-52. Il dipinto si trova al Boston Museum of Fine Arts.
4. François de Labarre, «Paris Match», 14 Mai 2009. Disponibile in linea: http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Immigrants-le-reve-brise-95709/ [19/05/2009]
5. Salman Rushdie, Ugly phrase conceals an uglier truth, «The New York Times», January 12, 2006. In linea: http://www.smith.com.au/articles/2006/01/09/1136771496819.html [11/06/2009] L’articolo è apparso in traduzione italiana su «Repubblica», 09/01/2006, pp. 1-17.
6. Robert Graves, Good-bye to All That. An Autobiography, New York – London, Jonathan Cape and Harrison Smith, p. 179 (trad. it. Addio a tutto questo, Casale Monferrato, Piemme, 2005, p. 171). L’espressione inglese è «discharge of the accessory»; Graves aggiunge in nota che «fu emanato un ordine speciale che impartiva severe punizioni a chiunque usasse termini diversi da “accessorio” per indicare il gas.» (ibidem). Per l’uso dell’iprite nella guerra d’Etiopia vedi Angelo Del Boca, I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d’Etiopia, con contributi di G.Rochat , F. Pedriali e R. Gentilli, Roma, Editori Riuniti, 1996.
7. Theodor Wiesengrund Adorno, L’educazione dopo Auschwitz [1966], in Id., Parole chiave. Modelli critici, Milano, SugarCo, 1974, p. 142.
8. S. Schama, Il potere dell’arte… cit., p. 269
[24 giugno 2009]
home>interventi/interviste> I guanti di Maroni