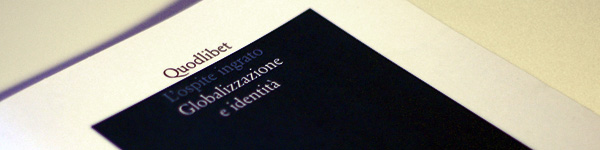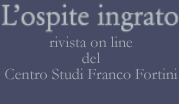home>interventi/interviste>
Ancora su Intellettuali e vittime.
Ancora su Intellettuali e vittime.
Gabriele Fichera
A partire
dalla lettura del saggio di Roberto Talamo su intellettuali e
“vittime”, e sulla base dell’intervento
di Alessandra Reccia che ne è immediatamente scaturito,
vorrei provare ad articolare un brevissimo ragionamento su almeno un
punto della questione. Quello che mi sento di dire è che
dissento abbastanza dall'idea che l'intellettuale non possa/debba
più parlare “in nome di”. Questa vecchia “presunzione”, se problematizzata e
aggiornata, ovvero se rivista alla luce dello stare “di fronte” alla vittima,
cioè dell'intraprendere con e grazie ad essa un processo
duplice di riconoscimento di sé e dell'altro,
questa “presunzione” del parlare “in nome di”, dicevo, non è
da mettere frettolosamente da parte. Per l’intellettuale la sua
innegabile condizione di privilegio è al tempo stesso stigma
e stemma: “l’intellettuale non ha da
vergognarsi della sua specializzazione e del privilegio esplicito
(capacità di fare qualcosa meglio di chi non la sa fare) ma
solo dei privilegi impliciti che ne trae o che la società
gli conferisce”1. In questa insanabile
contraddizione va inserita la compresenza,
nell’intellettuale, di complicità col potere
– direi almeno, e nel migliore dei casi, oggettiva
– e di irriducibile opposizione ad esso. Una
dicotomia che si rende evidente nel momento in cui
l’intellettuale si pone seriamente il problema degli
oppressi, dal novero dei quali non può, in molti casi,
chiamarsi fuori. È solo questo riconoscimento, di essere lui
stesso vittima, a dargli il diritto/dovere di pronunciare delle
parole “in nome di”. Questo accade sulla base
di una precisa presa di coscienza avvenuta. Questa: che i motivi per
cui l'altro è “vittima” non sono di diversa natura
rispetto a quelli per cui lo è, vittima, l’intellettuale stesso, e lo
sono, in generale, molti fra coloro che non lo sospettano nemmeno. Non
dunque in virtù di una sostituzione (parlo “io” al posto
del rom che viene
perseguitato, perché quest’ultimo non ha voce) deve
parlare l’intellettuale, ma sulla base
dell’avvertimento di una
somiglianza fra il nocciolo della sua condizione materiale e sociale e
quella del rom. È un problema di comprensione della
realtà e di resistenza pratica alla barbarie che trionfa.
Da ultimo direi che parlare in modo generico di “vittima” e di “carnefice” non aiuta a cogliere il
nucleo di un nodo concettuale così complesso. Sto leggendo
una raccolta di saggi di Gunther Anders che si intitola Uomo
senza
mondo. Nel libro, composto da saggi redatti negli anni
Sessanta a
proposito di vari testi letterari e scrittori, si dà una
definizione precisa, nonché articolata, di chi siano
le “vittime” nelle società
capitalistiche.
Concludendo, mi sembra troppo facile vedere i lineamenti della vittima
solo nel bambino denutrito che ci osserva da una
foto “umanitariamente” scattata. Io li scorgo
anche nei volti di tanti pasciutissimi ragazzi che mi stanno
quotidianamente di fronte. Eppure non lo
sembrerebbero, delle vittime.
note
1. F. Fortini, Intellettuali, ruolo e funzione, in Id., Questioni di frontiera. Scritti di politica e letteratura 1965-1977, Einaudi, Torino 1977, p. 72.
[25
gennaio
2011]
home>interventi/interviste> Ancora su Intellettuali e vittime.