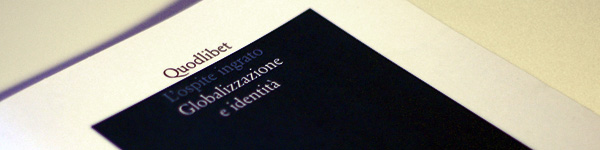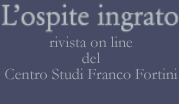home> interventi/interviste> Michel de Certeau, maestro senza discepoli
Michel de Certeau, maestro senza discepoli
Paola Di Cori
Quella
di Michel de Certeau (1925-1986) è stata una figura di studioso e
insegnante assai particolare. I suoi molteplici interessi, uniti alla
prodigiosa erudizione e a una sfrenata curiosità intellettuale, oltre a
una profonda indifferenza nei confronti della carriera accademica,
rendono difficile classificarlo secondo parametri tradizionali. Membro
della Compagnia di Gesù dai 25 anni fino alla morte, partecipò accanto
a Lacan alla fondazione della École freudienne nel 1963. Il suo
insegnamento, sparso tra università parigine di periferia, quella
californiana a San Diego, e poi in Messico, in Brasile e in Cile, si
esplicava nella maniera più stimolante all’interno dei seminari e dei
gruppi di studio da lui promossi in tutti i luoghi in cui gli capitava
di lavorare. Protagonista del dibattito storiografico francese degli
anni Settanta e grande studioso della mistica nei secoli XVI e XVII, le
sue ricerche spaziano dalla linguistica alla psicanalisi,
dall’antropologia alle culture giovanili intorno al ’68. Ma non solo.
Da alcuni anni, infatti, Certeau gode di una grande fortuna presso gli
studi culturali in lingua inglese, in particolare per la originale
ricerca del 1980 su L’invention du quotidien - condotta insieme
a Luce
Giard e Pierre Mayol - punto di riferimento essenziale nel rinnovato
interesse delle scienze sociali e umane per l’analisi della vita
quotidiana. Instancabile ed entusiasta animatore, dal 1971 al 1982, di
memorabili incontri durante i convegni estivi presso il Centro di
Semiotica dell’Università di Urbino, Certeau rimane da noi ancora
scarsamente conosciuto. Lo scritto Che cos’è un seminario?,
inedito in
Italia, costituisce un’ottima occasione per approfondire il carattere
assai speciale di un magistero “senza allievi”, come scrive nella
presentazione Luce Giard, collaboratrice di Certeau e profonda
conoscitrice della sua opera.
A chi affronta per la prima volta un autore non facile da avvicinare,
forse qualche avvertimento si rende necessario.
Come accade con l’intera prosa di Certeau, nel leggere si viene
immediatamente catturati dalla scrittura elegante e dall’originalità
della prospettiva offerta, ma allo stesso tempo ci si sente pervasi da
un senso di incertezza su ciò che si è letto. Di primo acchito verrebbe
quasi da dire: “mi piace ma non lo capisco”. A un secondo tentativo le
difficoltà di comprensione diminuiscono, ma rimane sempre come la
traccia di qualcosa che non è stato del tutto chiarito, qualcosa che
per essere afferrato appieno richiede uno sforzo ulteriore; una specie
di invito ad approfondire ciò che si è appena cominciato a capire.
All’opposto di ciò che fa il seduttore classico, il quale provoca
estraniamento e perdita di sé (sedurre significa infatti essere portati
via), la scrittura di Certeau - specchio testuale della dinamica nel
seminario, dove sono presenti come modelli ispiratori fondamentali il
transfert analitico e gli esercizi spirituali ignaziani - attira senza
annullare, accoglie senza imprigionare; ascolta “ciò che non vi [è]
detto”. Contrariamente a quanto accade con la seduzione vera e propria,
la pagina certiana attiva un processo di ri-conoscimento, di sé e degli
altri, e anche dell’oggetto di ricerca intorno al quale si è costituito
il seminario. Questo risultato si ottiene per effetto di un
rovesciamento completo rispetto alla dinamica tipica dei luoghi
canonici deputati all’insegnamento e dei gruppi che li costituiscono:
non l’approfondimento di un certo problema o argomento imposti
dall’esterno, né una applicazione meccanica di tecniche e obiettivi
formativi, ma il rispetto delle soggettività e la valorizzazione della
pluralità insita in ogni gruppo.
Simili aspetti hanno il potere di attribuire
a pagine scritte nel lontano 1977 i caratteri di una preziosa e
incomparabile inattualità. Nel momento in cui scuola e università hanno
smesso di costituire luoghi significativi di crescita e di confronto
culturale tra generazioni, i suggerimenti contenuti in Che cos’è un
seminario? offrono infatti numerosi motivi di interesse per chi
insegna
e apprende. Anziché voler raggiungere obiettivi di eccellenza
artificiosi, programmati burocraticamente, qui la pratica didattica è
intesa come gioco, scambio assai vario senza un nucleo né una
direzione
unici. Il seminario certiano non si colloca a un livello superiore ed
esclusivo rispetto a quelli tradizionali esistenti nella maggioranza di
scuole e università: viene al contrario concepito come uno spazio
transitorio nella vita di ciascuno/a; si pone, cioè, come luogo non
proprio. Questa “a-topicità” è basata sulla convinzione che il
seminario ha caratteristiche affini a quelle della vita ordinaria, non
è estranea né esterna a chi vi prende parte, e cerca di rendere
visibile “ciò che accade effettivamente” quando ci si riunisce in un
gruppo di studio: «le procedure della ricerca, egli scrive, non sono
fondamentalmente distinte dalle procedure o dalle “maniere di fare”
comuni».
Tali caratteristiche, spiega Certeau, sono ingredienti basilari per garantire la pluralità e la convivenza delle differenze all’interno del gruppo, e per aprire così la strada sia alla storia (il tessuto che unisce i partecipanti e conferisce identità di appartenenza al gruppo) che alla politica (lo spazio nel quale si rendono possibili il confronto, il conflitto, l’accordo): sono queste - oggi come trent’anni fa - componenti irrinunciabili di pratiche didattiche non autoritarie e di esperienze creative nel lavoro intellettuale.
Opere
principali di Michel de Certeau
La Prise de parole, Paris, 1968
La possession de Loudun, Paris, 1970
L’écriture de l’histoire, Paris, 1975
L’Invention du quotidien. Arts de faire, vol. I, Paris, 1980
La Fable mystique, Paris, 1982
In traduzione italiana
Politica e mistica, Milano, 1975
La scrittura della storia, Roma, 1977
Fabula mistica, Bologna, 1987
L’invenzione del quotidiano, Roma, 2001
Studi su
Michel de Certeau
Luce Giard (a cura di), Michel de Certeau,
«Cahiers pour un temps», Centre Georges Pompidou, Paris, 1986
Jeremy Ahearne, Michel de Certeau, Cambridge, 1996
AA.VV., Michel de Certeau. Les chemins de l’histoire, Paris,
2002
François Dosse, Michel de Certeau. Le marcheur blessé, Paris,
2002
AA.VV., Michel de Certeau,histoire/psychanalyse. Mises à l’épreuve,
EspacesTemps, Paris, 2002
[pubblicato in «École», dicembre 2004]
note
1. Ringrazio la professoressa Luce Giard per aver consentito la pubblicazione del saggio di Certeau su «École», accompagnato dalla sua limpida presentazione. Ringrazio in modo particolare, inoltre, il prof. Luigi Mantuano, per aver lavorato con generosità e competenza alla traduzione italiana.
[20 gennaio
2011]
home> interventi/interviste> Michel de Certeau, maestro senza discepoli