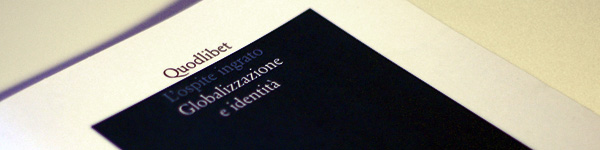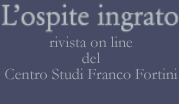home>interventi/interviste> Dare fiato alle lotte. Una possibilità per i knowledge workers.
Dare fiato alle lotte. Una possibilità per
i knowledge workers.
Alessandra Reccia
La rappresentazione tradizionale che vede, dentro i movimenti,
intellettuali e gruppi in lotta come entità socio-politiche distinte ma
alleate è ormai falsa. Il ceto intellettuale non si pone più il
problema di prestare la sua opera alla causa politica, e quindi esso
non esiste più nel senso in cui è esistito per più di un secolo nella
sinistra europea. Da qui parte anche l’analisi di un interessante
articolo di P. Rimbert, tradotto per «Le Monde diplomatique» (14
gennaio 2101), dal significativo titolo Il pensiero critico nel
ridotto
universitario, dove si passa al vaglia la possibilità stessa di
produrre pensiero critico in rapporto alla politica militante, per una
categoria ormai rinchiusa dentro l’università e che ingabbia nelle
logiche baronali anche le ultime generazioni.
Continuano ovviamente ad esistere élites ristrette di
intellettuali,
espressione più o meno diretta e consapevole dei gruppi economici e
politici di potere. Eppure il sospetto è che si stia modificando anche
la funzione che queste esercitano dentro gli apparati. Gli
intellettuali un tempo attivi come “consiglieri del principe” oggi
appaiono sempre di più come meri diffusori, a volte inconsapevoli, del
pensiero comune, esecutori instancabili dell’ordine costituito.
D’altro canto le nuove giunture storico economiche fanno di quelli che
teoricamente e tradizionalmente dovrebbero ingrossare il ceto in
questione, semplicemente degli operatori della conoscenza, senza più
privilegi di sorta.
In questa nuova situazione l’auspicio è che le lotte sociali in atto
non sviluppino un nuovo ceto intellettuale, mente separata di braccia e
teste che non le appartengono, ma che attraverso esse si produca una
diffusa capacità critica, ovvero intellettuale e politica insieme. I
presupposti sociali ci sono tutti anche se non mancano (anzi!) gli
ostacoli.
Un lavoratore della conoscenza non è automaticamente un intellettuale.
In realtà il suo lavoro non può essere definito intellettuale, nel
senso classico del termine, e ciò non dipende solo dalle condizioni
lavorative, ma soprattutto dalla qualità del lavoro svolto. Questo
infatti continua ad essere oggettivato in macchine, relazioni,
discorsi, documentazioni, ricerca, ma i suoi prodotti si sono
standardizzati, come le conoscenze utili per crearli, e sono passati
sul mercato al pari di qualsiasi altra merce. Allo stesso modo il
lavoro che le produce si è immesso nel sistema concorrenziale della
divisione del lavoro locale e globale. Il cammino che ha portato a
questo, almeno in Occidente, è stato molto lungo e oggi può dirsi il
risultato dell’interconnessione di diversi processi sia storici che
economici: la sconfitta del movimento operaio europeo, il passaggio
all’attuale fase del sistema produttivo comunemente nota come
post-fordista, l’alfabetizzazione generalizzata e il conseguente
sviluppo delle diverse industrie della cultura, per non parlare dei
sistemi di comunicazioni di massa.
Sottrarre il lavoratore della conoscenza al ruolo sociale al quale si
pensa destinato significa, paradossalmente, restituirgli la possibilità
di assumere la coscienza della sua funzione. In questo il knowledge
worker è simile a qualsiasi altro lavoratore, poiché la sua
capacità
intellettuale dipende direttamente dal grado di partecipazione alle
lotte, di comprensione del ruolo che svolge entro il sistema produttivo
e in esso del rapporto che esiste tra la sue e le altre categorie.
Si ribatterà che certo i lavoratori della conoscenza hanno forse
qualche chance in più di acquisire una funzione intellettuale
critica,
fosse solo per il fatto di aver studiato. Ma, si risponderà che
innanzitutto la scolarizzazione avanzata non è più esclusa ad altre
categorie di lavoratori. Questo è evidente quando per esempio
consideriamo gli immigrati, occupati nei settori tradizionalmente
caratterizzati da una cattiva e povera istruzione, ma spesso con alti
livelli di scolarizzazione. Il dato, chiaramente, mette in evidenza che
l’istruzione non è più tout court un elemento
discriminante nella
strutturazione della divisione sociale del lavoro, e questo a livello
globale.
Inoltre, si dovrebbe aggiungere, che questo fenomeno va di pari passo
con la standardizzazione, in Occidente, dei sistemi formativi di massa
che, come denuncia il movimento studentesco, mira ad un abbassamento
non solo del livello delle informazioni ma dei metodi stessi di
apprendimento. Per non parlare dell’ovvia verità secondo la quale
possedere un’istruzione non vuol dire avere gli strumenti per la
comprensione del reale.
Tutto questo ribalta l’ovvio presupposto che la formazione sia
naturalemnte finalizzata ad esercitare una funzione intellettuale e per
di più critica. Anzi il rischio è che essa venga utilizzata come un
discrimine sociale per la realizzazione di un’aspirazione di casta,
quella a cui il lavoratore della conoscenza si sentiva destinato fino a
non molto tempo fa. A ben guardare, ciò che viene immediatamente
recriminato da un lavoratore della conoscenza è il suo diritto ad
appartenere a quel mondo che gli avevano promesso mandandolo a scuola e
che invece gli è stato negato dalla crisi economica.
Ma, se si tratta da un lato di riconoscere questa situazione,
dall’altro bisogna sottolineare che proprio ciò che un’intera
generazione di aspiranti intelligenti vive come dramma, può diventare
un’opportunità politica importante.
Naturalmente la realtà è molto più fluida e varia di come la
raccontiamo. Esistono e sono attivi anche all’interno di questo
variegato soggetto socio-economico gruppi politicamente avanzati, pieni
di incertezze e già con una serie di fallimenti totali o parziali alle
spalle, ma che cominciano a pensarsi criticamente dentro questo sistema
produttivo e tentano di agire di conseguenza.
Le difficoltà che questi incontrano sulla strada della
soggettivizzazione riguardano direttamente la struttura e
l’organizzazione tipiche del loro lavoro. I due famosi aggettivi,
flessibile e precario, che si usano generalmente per descriverlo,
concernono quest’aspetto. Ma molte altre cose si potrebbero dire, e
sono state dette, sulle caratteristiche proprie di questo lavoro. Tra
queste vale almeno la pena ricordare l’individualizzazione del rapporto
di lavoro, che comporta tanto una ricaduta della responsabilità
lavorativa sul singolo (S. Bologna), quanto una solitudine del
lavoratore determinata da ragioni concorrenziali e anche dal fatto di
non condividere con i suoi colleghi spazi e orari. Tutto questo
determina, oltre che la difficoltà pratica a comunicare e dunque ad
organizzarsi (S.Bologna), una perdita della ritualità stessa del lavoro
e dunque della distinzione tra tempo di lavoro e tempo di svago
(L.Vasapollo)1. Si può essere impegnati in un’attività di
ricerca o di
editing, per esempio, tutti i giorni domenica e festivi inclusi e per
svariate ore al giorno, senza che ci sia una sirena a stabilire la fine
della giornata lavorativa e nel totale isolamento. Queste condizioni
non favoriscono l’organizzazione, ma anzi di fatto la rendono se non
impossibile certamente molto complessa.
Esiste poi la difficoltà, da non sottovalutare, di una generazione che
sconta trent’anni di assenza di dibattito politico e di partecipazione
attiva. Da questo punto di vista molti tra i nati tra gli anni Settanta
e Ottanta, quand’anche abbiano esperienze politiche pregresse legate ai
movimenti studenteschi oppure sociali, fanno fatica a costruire con i
loro coetanei discorsi politici generali e condivisi, capaci di uscire
fuori dalle logiche meramente vertenziali e di categoria. Chiunque
abbia partecipato almeno ad uno dei movimenti politici di questi ultimi
anni, precari della ricerca o della scuola o ricercatori per esempio,
sa che questo orizzonte si ripresenta ogni volta, ad ogni assemblea e
che costituisce un problema e un limite politico che non può essere
eluso.
Parliamo inoltre di un gruppo composto da diverse categorie di
lavoratori, i quali faticano a riconoscersi in una comune condizione.
Così, per esempio, un grafico con partita Iva non riesce a pensarsi
simile ad un precario della scuola.
I lavoratori della conoscenza sono una federazione di categorie cui
manca, nell’insieme, una tradizione di lotta. Contribuiscono a
fondarla, ovviamente, le esperienze pregresse dei singoli o delle
specifiche categorie, ma manca un discorso autonomo. Questo,
chiaramente, non può essere costruito ad hoc, come pretendono spesso
talune sigle sindacali che portano vecchie proposte a problemi di cui
sembra sappiano poco o nulla, ma ha bisogno di dispiegarsi nella
pratica politica stessa.
In questo senso l’alleanza che si sta tentando con operai e studenti è
importante, in quanto categorie con una lunga esperienza di lotta
possono fungere da canalizzatori di istanze e pretese politiche. Sembra
comunque doveroso in questo momento tentare la difficile ma unica
strada dell’alleanza sperando si creino i presupposti della
costituzione di un nuovo soggetto, certamente articolato al suo
interno, ma in grado di proporre un’alternativa. È chiaro che
l’alleanza comporta e comporterà tutta una serie di problemi teorici e
pratici, tra cui non ultimo quello di tentare un discorso almeno
europeo. Ma funzionerà se sarà in grado di porsi seriamente il problema
del lavoro nella nuova fase di produzione, il destino in esso delle
singole categorie e dei gruppi sociali, e il problema
dell’organizzazione razziale e sessista del mercato del lavoro globale.
Problemi classici e tuttavia nuovi.
In questa nuova esperienza di lotta, certamente in Europa, i lavoratori
della conoscenza possono dare un contributo importante, poiché la loro
organizzazione produttiva costituisce indubbiamente un punto di vista
privilegiato, economico e sociale. Ma ognuno in realtà è chiamato a
fare la sua parte.
Intanto non sarà inutile individuare quelli che sono stati i luoghi di
resistenza politica e culturale in questi ultimi trent’anni, tutte
quelle realtà o quei singoli che hanno contribuito instancabilmente a
mantenere alta la guardia. Altrettanto, resta fondamentale recuperare
alla lotta un pensiero e lo si faccia criticamente, riflettendo su
possibilità e sconfitte storiche ma anche sui modelli e le forme
dell’organizzazione.
Insomma, anche se la contingenza sembra chiamarci alle decisioni
meramente politiche, non si può perdere l’occasione di dare fiato alle
lotte attuali, di metterle in prospettiva, di recuperare, infine, la
funzione intellettuale come criterio politico.
note
1.
Rispettivamente, S. Bologna, I lavoratori della conoscenza e la
fabbrica che dovrebbe produrli, in «L’ospite ingrato», I, 2005, pp.
15-32; S. Bologna, Ceti medi senza futuro?, Derive e Approdi,
2007; L.
Vasapollo, J. Arriola, L’uomo precario nel disordine globale,
Milano,
Jaka Book, 2005.
[27 gennaio 2011]
home>interventi/interviste>
Dare fiato alle lotte. Una possibilità per i knowledge workers.